-
 Intervista a Umberto Cocco
Intervista a Umberto Cocco L'intervista si apre con una breve presentazione del giornalista Umberto Cocco. Fin dall’inizio ha collegato il culto di San Costantino alla schiavitù in Sardegna, facendo riferimento alla leggenda sullo schiavo di Scano Montiferro, liberato da San Costantino e che, in segno di gratitudine, avrebbe costruito la chiesa sul Monte Isei. Secondo il giornalista Cocco, a Scano Montiferro questa memoria è forse più viva rispetto a Sedilo, dove invece vengono tramandate diverse storie locali, come quella secondo cui San Costantino avrebbe salvato il paese dall’imposizione di tasse da parte dell’esercito piemontese.
Tuttavia, l’esperto ha ammesso di non conoscere molti dettagli sul collegamento diretto tra il culto e la schiavitù.
Si è poi soffermato sull’importanza del culto di San Costantino, sottolineando come oggi abbia assunto grande rilevanza, talvolta eccessiva, mentre in passato non rappresentava la devozione principale. Negli anni Duemila, l’amministrazione aveva commissionato una ricerca agli archivisti di Cagliari, dalla quale emerse che fino all’Ottocento il nome Costantino non veniva attribuito ai figli appena nati. Se il culto fosse stato così centrale, sostiene Cocco, il nome sarebbe stato più diffuso. In effetti, esso compare tardivamente ed è presente soprattutto in alcune zone della Sardegna come Sassari, Olzai e Orotelli, non lontano da Sedilo.
Per quanto riguarda gli ex voto presenti nella chiesa, il giornalista afferma che molti sono scomparsi nel tempo, in parte perché alcuni sacerdoti non li ritenevano esponibili e in parte perché fino a pochi anni gli ex voto da parte dei sedilesi erano molto rari.
Secondo l’esperto, il culto non apparteneva realmente alla comunità sedilese fino al Novecento, quando il paese decise di appropriarsene, soprattutto in relazione all’Ardia. Oggi, infatti, il rito risulta fortemente centrato sull’Ardia stessa, mentre la devozione verso San Costantino appare marginale, soprattutto tra i giovani, e teme che in futuro questa tendenza possa accentuarsi ulteriormente.
L’intervista si è conclusa con il consenso alla pubblicazione per fini di studio e di ricerca.
-
 Intervista Giovanni Melis
Intervista Giovanni Melis Nel corso della ricerca si è rivelato fondamentale il contributo del confratello ed ex presidente Giovanni Melis, il quale ha chiarito il legame tra schiavitù e l’Arciconfraternita, definendolo piuttosto marginale. Questo esperto ha spiegato che l’Arciconfraternita fu fondata da venti ex schiavi, i quali, al momento della costituzione, non erano più in stato di schiavitù. Si presume, sebbene non vi siano fonti scritte che lo attestino con certezze, che fossero stati liberati dall’Arciconfraternita dei Genovesi e successivamente condotti a Cagliari. Una volta giunti in città, chiesero aiuto ai padri agostiniani, dai quali furono accolti e gradualmente introdotti nella società locale.
Con il passare del tempo, questi ex schiavi sentirono la necessità di restituire quanto ricevuto, offrendo il proprio servizio alla comunità e, in particolare, aiutando le persone più deboli. In seguito, con il sostegno di alcuni confratelli dell’Arciconfraternita dei Genovesi, diedero vita a una nuova confraternita, quella della Madonna d’Itria, che essi già veneravano durante il periodo della schiavitù.
Il confratello ha inoltre sottolineato che la Madonna d’Itria era conosciuta anche come Madonna del Buon Cammino, poiché ritenuta guida delle persone sul giusto percorso di vita. Esistono infatti confraternite che assumono il nome di Confraternite del Buon Cammino o dei Viandanti, come nel caso di Sassari.
Il riconoscimento ufficiale dell’Arciconfraternita raggiunse il suo apice nel 1607, con la bolla di papa Paolo V, che ne sancì lo status di confraternita dotata di diritti e doveri ecclesiastici. Nel 1625 la confraternita viene affiliata alla cerchia di Sant’Agostino di Roma, ottenendo anche il titolo di Arciconfraternita.
Lo scopo principale di questa è l’aiuto ai poveri e ai bisognosi, con particolare attenzione alle donne in stato di necessità, come ad esempio le ragazze madri. L’Arciconfraternita offre sostegno anche ai confratelli in difficoltà, tuttavia, per rispetto della privacy, non vengono resi noti i dettagli degli aiuti forniti pur essendo noto all’interno della comunità che tali interventi avvengono.
L’Arciconfraternita si distingue dalle altre anche per la sua struttura interna: non esistono le figure del priore o della priora, ma solo confratelli e consorelle che costituiscono un unico gruppo. L’abito è uguale sia per gli uomini sia per le donne e anche la carica di presidente può essere ricoperta da una donna, evento che si è già verificato in passato. Di questo aspetto l’Arciconfraternita si dichiara particolarmente orgogliosa.
L’intervista si conclude con il consenso da parte di Giovanni Melis a pubblicare l’intervista per fini di studio e di ricerca.
-
 Intervista Antonio Esposito Ordine Mercedario
Intervista Antonio Esposito Ordine Mercedario L’intervista si apre con il racconto della nascita dell’Ordine Mercedario nel 1218 a Barcellona. La guida ha sottolineato come il fondatore dell’Ordine, Pietro Nolasco, fosse un laico, ribadendo più volte che la santità fosse accessibile a tutti. Nolasco era un ricco mercante di stoffe che, viaggiando, si rese conto della diffusa povertà e della schiavitù presenti nel mondo, da questa consapevolezza nacque un profondo cambiamento nella sua vita, che lo portò a donare i propri beni ai poveri e ai prigionieri.
Secondo il racconto, Pietro Nolasco ebbe successivamente una visione della Madonna della Mercede, che gli chiese di fondare un ordine religioso dedicato al riscatto degli schiavi. Iniziò così, insieme ai suoi compagni, a raccogliere denaro per pagare il riscatto dei prigionieri. Tra le figure centrali vi era il cosiddetto frate cercatore, incaricato a reperire le somme necessarie e di consegnarle per la liberazione degli schiavi. La guida ha inoltre spiegato che molte opere presenti nella sagrestia raffigurano proprio queste scene: i frati trattavano con i saraceni, che spesso richiedevano somme sempre più elevate. In alcuni casi, il responsabile della questua offriva persino la propria vita in cambio della liberazione del prigioniero. Tra il Trecento e il Quattrocento, secondo quanto riferito, circa cinquecento frati mercedari persero la vita in modo violento, impiccati, bruciati vivi, lapidati o squarciati nel tentativo di riscattare gli schiavi.
Un episodio particolarmente significativo per la Sardegna riguarda i carlofortini, deportati in Tunisia e riscattati uno alla volta dai padri mercedari. Per questo motivo ancora oggi, i carlofortini si recano a Cagliari portando la Madonna dello Schiavo, in segno di ringraziamento alla Vergine e ai padri mercedari per la liberazione dalla schiavitù.
L’intervista si chiude con un invito di Antonio Esposito alla popolazione a visitare il Santuario di Bonaria e a scoprirne la storia; infine, esprime il suo consenso alla pubblicazione dell’intervista per fini di studio e di ricerca.
-
 Intervista ad Andrea Luxoro
Intervista ad Andrea Luxoro Secondo l’esperto, il culto è legato all’esperienza tragica dell’incursione barbaresca compiuta dai tunisini nel 1798. Nella notte fra il 2 e il 3 settembre si verificò il famoso sacco di Carloforte, durante il quale una parte della popolazione fu ridotta in schiavitù e deportata in Tunisia. Tra gli schiavi vi era Nicola Moretto, che il 15 novembre 1800, in un giardino della Tunisia, ritrovò il simulacro della Madonna dello Schiavo in circostanze misteriose, definite quasi miracolose da un attestato del prefetto di Tunisi.
Successivamente Andrea si sofferma sull’importanza che la Madonna dello Schiavo ha per sé stesso e per la comunità di Carloforte, definendola una delle devozioni più significative della sua vita. Il culto, infatti non riguarda soltanto una scelta individuale, ma assume una dimensione collettiva, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Andrea Luxoro ha raccontato di aver sempre partecipato alle celebrazioni, rientrando da Cagliari a Carloforte, sia per la festa del 15 novembre, legata al ritrovamento del simulacro, sia per quella del 2 settembre, che ricorda l’incursione barbaresca. Quest’ultima è caratterizzata da un tono più sobrio e solenne.
La modalità delle celebrazioni è cambiata nel tempo: documenti storici mostrano che inizialmente veniva commemorata soltanto la data del 2 settembre; nel 1924 don Gabriele Pagani istituì la festa del 15 novembre e, dalla seconda metà del Novecento, entrambe le ricorrenze vennero mantenute.
Attualmente la festa si arricchisce di nuovi momenti rituali, tra cui la processione del trasferimento del simulacro dal suo santuario alla chiesa parrocchiale di San Carlo, che avviene il 5 novembre, vigilia dell’inizio della novena. In passato tale trasferimento avveniva in forma privata, mentre oggi è accompagnato dai giovani e assume forme sempre più solenni. Il rientro del simulacro nella sua chiesa avviene la settimana successiva alla festa, ma qualora la celebrazione cada in un giorno successivo al giovedì, il rientro non avviene la domenica immediatamente successiva, ma quella seguente, con una permanenza di circa quindici giorni nella parrocchia di San Carlo.
La festa comprende anche altri momenti significativi: i carlofortini residenti nell’area del Cagliaritano celebrano la Madonna dello Schiavo presso il Santuario di Nostra Signora di Bonaria, ricordando anche l’intervento dell’Ordine della Mercede per la liberazione degli schiavi. Un’ulteriore celebrazione si svolge in Liguria, alla fine di novembre, presso la parrocchia dell’Immacolata di Pegli, con la partecipazione dei carlofortini residenti in quella regione.
Infine, l’esperto ha sottolineato come il concetto di schiavitù venga tramandato ai carlofortini fin dall’infanzia, attraverso il racconto dell’incursione e della storia della Madonna dello Schiavo. Di conseguenza, le forme devozionali legate alla Madonna veicolano, anche involontariamente, la consapevolezza della schiavitù anche tra le generazioni più giovani.
L’intervista si conclude con il consenso di Andrea alla pubblicazione dei contenuti per fini di studio e di ricerca.
-
 Intervista a Mauro Salis a Cagliari
Intervista a Mauro Salis a Cagliari Durante l’intervista, l’attenzione si è concentrata fin da subito sul rapporto tra la Madonna del Rimedio e la schiavitù in Sardegna. Secondo Mauro Salis, la Madonna del Rimedio è conosciuta anche con il titolo di Madonna del Riscatto: due denominazioni differenti che fanno riferimento alla medesima manifestazione mariana.
Il docente ha spiegato che tali devozioni sono patrocinate dall’Ordine dei Trinitari, un ordine religioso medievale, la cui finalità principale era il riscatto delle persone ridotte in schiavitù. Il riscatto avveniva attraverso la raccolta di elemosine, necessarie a raggiungere una somma richiesta dai detentori degli schiavi per la loro liberazione. Nel corso di queste attività, la richiesta di elemosine era accompagnata da argomentazioni religiose, preghiere e invocazione alla Madonna nella sua titolazione di Riscatto.
Come sottolineato dal docente esperto, il termine riscatto è ancora oggi corrente nella lingua italiana e chiarisce il collegamento semantico tra la liberazione degli schiavi e la devozione mariana.
Nel contesto sardo, lo storico dell’arte ha evidenziato come il riscatto fosse quasi sempre legato a schiavi sardi di fede cristiana, catturati durante le cosiddette incursioni barbaresche e deportati nelle città nordafricane, dove rimanevano in attesa di liberazione. Il processo di riscatto comportava anche lo spostamento temporaneo dei membri dell’Ordine verso porti di nordafricani. In questo contesto, la Madonna del Rimedio veniva invocata anche come protettrice dei naviganti.
Dal punto di vista della storia dell’arte, il docente ha citato lo scultore Giuseppe Antonio Lonis, al quale è stata attribuita una statua conservata nella chiesa di San Lucifero. Sebbene tale attribuzione sia oggi oggetto di discussione, il docente ha sottolineato che il suo interesse per l’opera nasce proprio dalla presenza della titolazione della Madonna del Rimedio.
Infine, ha evidenziato come nell’analisi delle immagini sacre, si debba tenere conto anche delle ragioni sociali e antropologiche che determinano le variazioni iconografiche. In questo senso, si è interrogato sul significato e sulle origini della devozione alla Madonna del Rimedio, mettendola in relazione con altri culti mariani legati al tema della schiavitù, come quello della Madonna d’Itria. Quest’ultima, in particolare, nel Seicento entra in competizione con la devozione alla Madonna del Rimedio nel cuore e nell’esperienza di coloro che avevano i familiari da riscattare.
L’intervista si è conclusa con il consenso alla pubblicazione dei contenuti a fini di studio e di ricerca.
-
 Intervista ad Antonio Esposito a Cagliari
Intervista ad Antonio Esposito a Cagliari Durante l’intervista, la guida ha ricostruito l’episodio dell’arrivo della cassa davanti al colle di Bonaria, in prossimità dell’area dove oggi si trova la scalinata. La popolazione tentò invano di aprire la cassa, finché una donna, presente con il proprio bambino, mandò quest’ultimo a chiedere aiuto ai religiosi. Due frati giunsero sul posto, presero la cassa e la trasportarono nel Santuario. Esposito ha sottolineato la difficoltà nello spostamento, affermando che, anche vuota, per sollevarla sarebbero necessarie almeno dieci persone per sollevarla.
Una volta aperta la cassa davanti a testimoni, i religiosi trovarono la Madonna con il Bambino e la candela ancora accesa. Inizialmente la statua fu collocata nella cappella laterale della chiesa, poiché al centro dell’altare si trovava già la Madonna del Miracolo. Tuttavia, per quattro notti consecutive, le statue sembravano spostarsi autonomamente. I frati decisero allora di vegliarle, ma il fenomeno continuò a verificarsi. A questo punto fra Catalano, custode del Santuario, ricordò una visione avuta in precedenza, nella quale gli era stato annunciato che dal mare sarebbe arrivata la Signora del colle. Da quel momento la Madonna di Bonaria venne collocata al centro dell’altare, mentre la Madonna del Miracolo fu spostata sulla parte destra.
Durante l’intervista è stato inoltre spiegato il significato del nome Madonna di Bonaria. All’epoca, a Cagliari era diffusa la malaria e le persone si recavano sul colle per respirare aria salubre; per questo motivo la Madonna venne associata all’aria buona. Secondo la tradizione, il nome avrebbe inoltre influenzato quello della capitale argentina, Buenos Aires.
Infine, Esposito ha descritto le celebrazioni in onore alla Madonna di Bonaria raccontando che la prima si svolge il 25 marzo, la seconda ad aprile, la terza a settembre, mentre la prima domenica di luglio ha luogo la processione a mare, durante la quale la comunità ringrazia la Madonna per i miracoli compiuti e per la sua protezione come patrona dei naviganti.
Un ulteriore elemento significativo è rappresentato da una barca d’avorio collocata sopra il Santuario, donata da una pellegrina diretta in Terra Santa.
Secondo la tradizione, una volta posta sull’altare di fronte alla Madonna di Bonaria, la barca si muoverebbe quotidianamente, con la prua che indicherebbe le correnti presenti nel Golfo degli Angeli.
L’intervista si conclude con il consenso di Antonio Esposito a pubblicarla per fini di studio e di ricerca.
-
 Intervista ad Albertina Piras a Villamar
Intervista ad Albertina Piras a Villamar Durante l’intervista, svolta presso la chiesa campestre, la docente ha raccontato la storia della Madonna, sottolineando il suo arrivo da Costantinopoli, fino al territorio sardo grazie ai Bizantini. Si è soffermata inoltre sull’iconografia del simulacro, evidenziando come solo in Sardegna la Madonna venga raffigurata insieme al moro e al turco.
Secondo Piras, la comunità villamarese è molto devota alla Madonna, e ritiene sia stata lei stessa a scegliere il paese, poiché, secondo la tradizione la statua era diretta verso Pauli Arbarei, ma i buoi che la trasportavano si fermarono a Villamar e non vollero più andare avanti. Questo episodio fu interpretato dai villamaresi come un segno della volontà della Madonna di restare nel loro paese. Ancora oggi, nel punto in cui avvenne l’episodio, è presente una croce chiamata Sa Gruxi de Nostra Signora.
Nell’intervista è stata affrontata anche la questione del cocchio, che ha generato conflitti all’interno della comunità: inizialmente si desiderava collocarlo all’interno della chiesa, ma ciò non fu consentito. Attualmente, per questo motivo, il cocchio è custodito in un garage, mentre presso la parrocchia di San Giovanni Battista è conservato un cocchio in miniatura.
Infine, la docente ha ricordato come in passato gli abitanti del paese ritenessero che il culto della Madonna d’Itria esistesse solo a Villamar, mentre studi successivi hanno dimostrato la sua diffusione in altri centri della Sardegna.
L’intervista si conclude con l’autorizzazione della docente a pubblicare l’intervista per fini di studio e di ricerca.
-
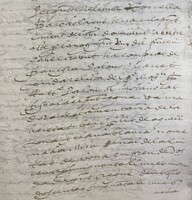 Schiavi che usano la schiavitù
Schiavi che usano la schiavitù Nelle vicende di mobilità che conduce alla libertà possiamo trovare casi in cui gli schiavi stessi, inevitabilmente, partecipano delle dinamiche commerciali di quel sistema oppressivo dal quale sono per primi soggiogati: acquistano schiavi loro stessi sia per liberarli, sia per riuscire a liberare se stessi.
Alcuni esempi della prima fattispecie possiamo ritrovarli nel caso di di Amet Decoll di Annaba che, nel 1619, acquista la schiava Fatima da don Angel dela Bronda con l’intento di affrancarla, e anche nell’acquisto di Mira da parte di Melchior Torrella su commissione dello schiavo Monço ha lo stesso intento.
Amet Decoll e Monço in qualche modo sono parte del meccanismo di possesso delle persone. Acquistare (o, nel secondo caso, far acquistare) Fatima e Mira come schiave è un modo per poterle liberare. Si servono dell’istituto schiavile stesso come mezzo per ottenerne la cessazione.
La vicenda di Amet di Annaba è ancora più singolare. Nel 1615 vive da alcuni anni al servizio della nobile Ysabel Alagon e Requesens, marchesa di Villasor e vedova di Martino Alagon. Determinato a riconquistare la libertà, con una piccola somma di denaro elabora un piano ingegnoso. Tratta con donna Ysabel, che inizialmente rifiuta di lasciarlo andare, probabilmente per non rinunciare al suo servizio. Amet decide di aggirare il rifiuto. Si reca al porto durante un'asta pubblica e compra un altro schiavo, anch'egli chiamato Amet e proveniente da Annaba. Amet offre il nuovo schiavo a donna Ysabel, proponendolo in cambio della sua libertà. La marchesa accetta.
Amet rappresenta un esempio di riappropriazione della dignità individuale. La sua vicenda mostra una sintesi tra integrazione nella società ospitante e determinazione personale. Da un lato, riesce a stabilire legami lavorativi che gli permettono di guadagnare denaro; dall'altro, dimostra capacità di negoziazione, giungendo a compromessi sia con la padrona che con chi gli vende un altro schiavo. Amet sfrutta ogni risorsa a disposizione con astuzia, intraprendenza e una certa dose di spregiudicatezza.
Utilizza infatti la schiavitù come strumento di liberazione, sostituendosi con un altro schiavo per migliorare la propria condizione. È “complice” del meccanismo di privazione della libertà. Rompe la schiavitù, ma lo fa deliberatamente a spese di un altro come lui.
In altri casi, invece, gli schiavi usano la schiavitù per trarre profitto, come nel caso di Salem Desfachs. Egli viene pagato da Hagemusa, schiavo del viceré Calatayud, affinché faccia da garante durante il suo viaggio in patria, dove deve trovare il denaro necessario per riscattarsi dalla schiavitù.
Questi e altri casi mostrano la complessità del fenomeno schiavile e, per la prima volta, fanno emergere il ruolo attivo e contraddittorio degli schiavi nel sistema stesso.
-
 La società cagliaritana e gli schiavi: gli uomini del mare
La società cagliaritana e gli schiavi: gli uomini del mare Corsari e mercanti sono figure chiave nell’esperienza schiavile mediterranea.
Attraverso essi si instaurano il dialogo e le connessioni più concreti tra la Sardegna e l’esterno. Versatili, capaci di adattamento e di gestire affari in due “mondi” diversi e opposti, con linguaggi verbali, culturali e sociali diversi.
I corsari sono i primi a guadagnare dalla merce umana, sono i principali responsabili del traffico di schiavi e rappresentano il loro canale di ingresso nel Regno e nel circuito di mercato. L’efficacia del loro ruolo dipende, nelle fasi di cattura, dalla scaltrezza, dalla rapidità e dalla forza che possono mettere in campo e, successivamente, dalla capacità contrattuale e dalla fermezza che impiegano nel negoziare con le autorità e con gli acquirenti per ottenere il massimo profitto dalle proprie prede.
D’altra parte, i mercanti rivestono una posizione altrettanto significativa non solo nelle compravendite, ma anche e soprattutto nelle operazioni di riscatto degli schiavi. Operano come intermediari nelle complesse transazioni di redenzione, parallelamente ai noti ordini religiosi dediti a questa attività1. Per il successo nel big business2 dei riscatti, sono indispensabili non solo le risorse economiche per finanziare viaggi, mobilitare persone e far circolare denaro, ma anche una solida abilità di negoziazione e una rete di relazioni ben sviluppata.
A Cagliari, nel primo Seicento, sono presenti molti corsari naturals, ma sono soprattutto i forestieri a svolgere questa professione del mare. Valenzani, maiorchini, francesi, maltesi, napoletani e siciliani.
Analizzare le relazioni di cui sono protagonisti permette di ampliare la comprensione della società, conoscendo anche quei nomi che, pur implicati nella vicenda, sfuggono all’analisi delle connessioni più rilevanti. Tante persone, infatti, emergono nelle nostre fonti per aver acquistato anche un solo schiavo, ma ciò non nega la loro rilevanza in un discorso generale di movimento di captivi nella società. Anche i singoli atti di acquisto contribuiscono a tracciare una mappa sociale più complessa e interconnessa.
I corsari di maggior successo sono Andreu de Lorca, definito ora maiorchino e ora valenzano, attivo dal 1600 al 1617, e Guillelm Prevost, francese, attivo nei primi anni del secolo.
Secondo le fonti che abbiamo potuto esaminare, i due catturano e vendono circa cento schiavi entrando in contatto, rispettivamente, con cinquantadue e quarantasette acquirenti. A queste si aggiungono le interazioni con gli ufficiali implicati nella gestione dei pubblici incanti: il Procuratore Reale, il Procuratore Fiscale, il Maestro Razionale e il Pubblico Corridore, spesso protagonisti anche come compratori. Tra i nomi degli acquirenti ritroviamo principalmente personalità eminenti di estrazione soprattutto locale: nobili e ufficiali reali, letrados, canonici, dottori della Reale Udienza insieme a mercanti e notai.
Anche per Miquel Mitzavilla, maiorchino, e Barthomeu Didià, francese, riscontriamo una discreta attività nel 1632 e nel 1633. Vendono ventuno schiavi ciascuno ad altrettanti acquirenti. Tra costoro, molti sono protagonisti del commercio di persone già trent’anni prima, come don Pau di Castelvì e don Gaspar Pira, i canonici Simo Montanacho e Melchior Pirella; troviamo nuovi esponenti di famiglie già note che continuano la "tradizione" di possesso di schiavi avviata all'inizio del secolo, come i Fortesa e i Capay, dottori in in legge, i dela Matta, i Bonfant, famiglia di notai; vi sono, infine, personalità che appaiono per la prima volta nella nostra ricerca, come don Joan Dexart, dottore in leggi, avvocato e giudice della Reale Udienza, il dottor Antoni Sauni, il dottor Matheo Benedeto, i canonici Pere Folgiari e Lorens Sampero, i mercanti Sisinni Geruna e Diego Alonço.
Altri corsari attivi ma meno documentati sono Juan Maltes e Miquel Matos, dei quali non conosciamo la provenienza, Bathomeu Torres, maiorchino, Paulo Pilicato, trapanese abitante nell’appendice cagliaritana di Lapola, Francesch Bramon, Andreu Gisbert e Jean Baptiste Lalgin, francesi.
Gli ultimi tre operano all’inizio del secolo, nel 1600, 1602 e 1603. Ad acquistare i gli schiavi catturati da loro sono soprattutto grandi personalità del Regno: don Pedro de Castelvì, don Hieroni Delitala di Alghero, il dottore in medicina Joan Antoni Sanna, il viceré conte d’Elda, don Joan Naharro de Ruecas, il dottor Mostallino e Juan Antoni Martì, mercante.
Pilicato è attivo tra il 1617 e il 1619 e vende sei schiavi a don Pau de Ravaneda e al mercante Augustin Regestra. Lo ritroviamo alcuni anni dopo, nel 1638, a sua volta schiavo a Tunisi nelle mani di Sidi Atias. Pilicato dà procura a tale Mateo Farere, anche lui trapanese, per recuperare alcuni crediti e, con quel denaro, riscattarlo.
Torres, infine, va in corso nel 1633 e 1634 e vende tre schiavi a Juan Font, Joan Luis Fiorillo e al canonico Thomas Rachis.
Alcuni altri corsari compaiono una sola volta nella documentazione, ma la loro attività da conto della vivacità di Cagliari come porto corsaro nel Seicento. Si tratta di Joan Arbizola, maiorchino, Paulo de Vicco, napoletano, Gabriel Hernandez, siciliano, Llorens Soliman e Monserrat de Lorca, maiorchini, Steve Già, genovese, Hercules Velle, maltese, Ugues Athenos, francese, Baptista Brumeo, Damian Domingo Lian, Joan Veloto, Nicolao Justiniano e Bernardo Beltran di provenienza sconosciuta, Joan Pere Masala e Jaume Sala, sardi, e diversi altri.
Gli schiavi sono una merce tra le tante, venduta, scambiata e trasportata. Per questo parrà normale constatare come anche molti mercanti, uomini di mare che spesso sono anche patroni di imbarcazioni, siano implicati nella loro compravendita, in attività creditizie e di riscatto, o in attività commerciali. Come nel caso dei corsari, si tratta soprattutto di uomini forestieri, spesso domiciliati nelle appendici di Cagliari, Lapola e Stampace. Non manca qualche autoctono.
Miquel Vidal, maiorchino, è proprietario di almeno tre schiavi, Soliman, Aly Badari e Fatima. Il primo viene acquistato al pubblico incanto da Andreu de Lorca, il secondo gli viene venduto da un altro mercante, Alexi Picasso, mentre sulla terza non abbiamo a disposizione questo dato. Vidal entra in relazione con Salem Desfachs e Baptista Baldo, nel 1606, per la commissione di un riscatto in Nordafrica.
Anche il cagliaritano Miquel Calabres entra in contatto con Salem Desfachs e Amet di Tripoli attraverso uno dei quattro schiavi che possiede. I due liberti gli consegnano il denaro che il suo schiavo David Jucu deve pagare per essere affrancato.
Nicolò Derouche, mercante residente a Cagliari negli anni Trenta e Quaranta del Seicento, si ritaglia il suo protagonismo nella vicenda schiavile occupandosi di alcuni riscatti di musulmani in Sardegna. Il primo è Mahamet Cherif, il quale consegna a Derouche il denaro per pagare il proprio riscatto, denaro che ha ricevuto in prestito da un altro schiavo musulmano. Derouche, ancora, riceve da Rais Ayet, moro di Biserta, il denaro necessario per riscattare due bistertini in prigionia a Cagliari, di nome Abdelatif e Abraham Rassit. Infine, riceve da Marina Hienone, ebrea, venti pezzi da otto reali per riscattare, a Cagliari, Moussa, figlio della donna, schiavo di Joan Caulcer, mercante maiorchino.
Un personaggio ricorrente nelle fonti è il patrone di Torre del Greco Salvator Izzo, un “ingranaggio” rilevante nella macchina della schiavitù non solo a Cagliari, ma anche al di fuori. Oltre che occuparsi di prestare denaro ad alcuni schiavi perché possano pagare il proprio affrancamento, è piuttosto attivo in operazioni di riscatto di schiavi sardi, siciliani, calabresi e napoletani in Nordafrica, specificamente a Tunisi. Riceve una commissione da Joan Antoni Marti, anch’egli mercante abitante a Cagliari, per occuparsi del riscatto del frate Cherubi Pichiotta, calabrese schiavo a Tunisi18. Izzo si occupa anche del secondo riscatto di Baptista Morvillo, schiavo a Tunisi, e di quelli del frate siciliano Francesco Francavalli e di Giuseppe Pancrazzi.
È probabile che Izzo metta in piedi una sorta di rete di prestiti e crediti, in quanto troviamo almeno tre testimonianze di crediti aperti nei suoi confronti da parte di Raffaello Francesco di Marsiglia, Guglielmo Martino di Maiorca, e Hugues Changet, console francese.
-
 La società cagliaritana e gli schiavi: l'alto clero
La società cagliaritana e gli schiavi: l'alto clero Anche gli arcivescovi e gli alti prelati partecipano attivamente agli scambi di schiavi.
L’arcivescovo di Cagliari, Alonso Laso Sedeño, in carica tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento (1596-1604), è una delle figure più rilevanti. Uomo di grande prestigio, è abilitatore e trattatore dello stamento ecclesiastico nel Parlamento tenuto all’inizio del secolo dal viceré d’Elda. Nel 1603, il monsignore possiede cinque schiavi, quattro dei quali acquistati al pubblico incanto dal patrone Guillelm Prevost, mentre il quinto è il figlio di uno di loro. Subito dopo l’acquisto, Laso Sedeño battezza e cresima i suoi schiavi, e nei ruoli di padrini e madrine vengono scelte importanti personalità laiche e religiose, come la nobile donna Magdalena Portugues e Barbarà, baronessa di Posada, il canonico Joseph Laso, parente dell’arcivescovo, e i canonici Guerau de Pinna e Joan Thomas Caldentey.
Il successore di Laso Sedeño è don Francisco d’Esquivell (in carica dal 1605 al 1624), il quale sembra possedere tre schiavi, uno dei quali acquistato al pubblico incanto dal corsaro francese Barthomeu Didià. Tra i padrini e madrine dei suoi captivi compaiono don Francisco Torrella, futuro barone di Capoterra, il canonico Miquel Claramont, e due figure di estrazione ignota: Maria Esprugas e Joan Gunallons.
Infine, in merito a monsignor don Antonio Canopolo, arcivescovo di Arborea presente in Parlamento fino al 1614, ci sono pervenuti un atto di compravendita e uno di battesimo. Canopolo vende la sua schiava Portia a donna Ysabel Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon, e nel 1610 fa battezzare un suo schiavo nella chiesa di San Nicola di Sassari. A officiare il rito è il Vescovo di Bosa. Lo schiavo di Canopolo viene battezzato insieme uno schiavo di don Antonio Mulines. Padrino e madrina di entrambi gli schiavi sono don Enrico de Sena, governatore del capo di Sassari, e sua moglie.
Tra i canonici, molti dei quali intervengono nello stamento ecclesiastico durante i Parlamenti del Regno, alcuni acquistano i loro schiavi direttamente dai corsari nelle pubbliche vendite all’asta: Salvador Soler, Jaume Spiga, Antoni Quença, Thomas Rachis, Augustì Murtas, Lorens Sampero. Altri sono implicati in compravendite con vari esponenti dell’élite.
Ad esempio, il canonico Antoni Tola acquista una schiava mora da donna Hieronima Carta e Requesens, mentre il canonico Joan Meli, della cattedrale di Iglesias, tramite il proprio procuratore Jaume Hortola, acquista uno schiavo di nome Barca da Gavi Sasso, ex avvocato fiscale e patrimoniale del Regno. Barca viene utilizzato come moneta di scambio per la liberazione del fratello di Meli, Francesch, schiavo della madre di Barca in Nordafrica.
Il canonico Vincent Baccallar è discretamente attivo nel possesso di schiavi. Per il battesimo di Joan Baptista, sceglie come padrino don Pere Portugues, barone di Posada, e come madrina la propria sorella donna Marchesa Baccallar. Il canonico a sua volta battezza una schiava del barone don Miquel Portugues e di sua moglie Madalena Portugues e Barbarà. La ricorrenza della famiglia Portugues indica una certa prossimità tra le due famiglie.
Simon Montanacho, canonico e giudice di appello nel Regno, acquista uno schiavo dall’eredità dell’omologo Joan Sini, con cui sembra avere un rapporto di vicinanza visto l’intervento di entrambi come padrini dei rispettivi schiavi. Montanacho entra anche in contatto, tramite uno dei suoi schiavi, con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli, i due liberti le cui avventure sono contenute nel secondo capitolo. Bilcasser, schiavo del canonico, si impegna come creditore nei confronti dei due. Sini, infine, è legato al viceré don Calatayud, comparendo sia come officiante del battesimo di uno dei suoi schiavi, sia nel ruolo di padrino di un altro.
In generale, sembra che anche gli alti prelati, come i viceré, preferiscano interagire prevalentemente con i notabili del Regno per quanto riguarda il possesso di schiavi. Il rapporto più frequentemente attestato tra loro e i nobili o gli ufficiali regi è quello di padrinaggio. Meno attestati sono gli atti di compravendita o altre tipologie di passaggio di schiavi. Sul piano spaziale, i legami restano principalmente locali, mentre sono i corsari, gli schiavi e i liberti a proiettare il Regno verso l’esterno, stabilendo connessioni con luoghi come la Francia, Maiorca, Malta e il Nord Africa.
-
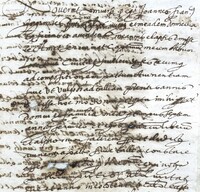 La società cagliaritana e gli schiavi: gli ufficiali regi
La società cagliaritana e gli schiavi: gli ufficiali regi Ai più alti livelli istituzionali e amministrativi del Regno, molti esponenti sono attivi nel commercio e nel possesso di schiavi.
La famiglia Soler, di origini barcellonesi, si distingue in Sardegna col canonico Salvador, con Gaspar e con Pere Joan.
Gaspar Soler, dottore in utroque iure del capitolo della Cattedrale di Cagliari e avvocato dello stamento ecclesiastico nel parlamento d’Elda, possiede un solo schiavo, acquistato dal corsaro Andreu de Lorca. È implicato personalmente nelle vendite all’asta di schiavi almeno nel 1604, agendo come delegato del procuratore reale don Nofre Fabra e Deixer.
Pere Joan Soler è reggente la Reale Cancelleria, molto attivo nelle prime Corti del Seicento come abilitatore, trattatore, giudice dei gravami, rappresentante del viceré e ambasciatore di diversi ufficiali regi: tutti ruoli che favoriscono il dialogo e il contatto con i maggiori esponenti di tutti gli stamenti e con gli altri rappresentanti regi. Soler possiede diversi schiavi che acquista direttamente dai corsari de Lorca e Prevost e che vengono battezzati da personalità come Ysabel Soler, sua figlia, Juan Masons, giudice della Reale Udienza e il nobile don Joan Baptista Delitala; troviamo poi Nicolau Sart, Antioga Paisana, levatrice, Miquel Atzeni e Catelina Xanquir, tutti di estrazione sociale non rilevabile. Soler ricopre anche il ruolo di padrino insieme a donna Marianna Deixer e Castelvì, marchesa di Cea e moglie di don Pau de Castelvì, nel battesimo di Joan Thomas de Santa Creu, il giovane musulmano recatosi a Cagliari dalla Barberia per diventare cristiano.
Un altro esempio significativo di protagonismo nella vicenda schiavile è rappresentato da don Joan Naharro de Ruecas, reggente della Tesoreria Generale del Regno. Nel 1599, acquisisce il titolo nobiliare e da quel momento partecipa attivamente ai Parlamenti del Regno, cooperando con figure chiave come i viceré don Anton Coloma o don Carlos de Borja, gli altri ufficiali regi e i principali rappresentanti dei tre stamenti.
Tra il 1601 e il 1612, don Joan possiede almeno quattordici schiavi e, attraverso la documentazione che li riguarda, possiamo ricostruire alcuni dei contatti sociali. Acquista quattro schiavi dai corsari Andreu de Lorca, Jean Baptiste Lalgin e Guillelm Prevost e uno da don Christofol Centelles.
Il suo captivo Amet di Annaba si interfaccia con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli per chiedere loro un prestito di denaro per potersi riscattare. I due creditori consegnano a don Juan duecentosettanta lire; per ripagare il debito. Amet si accorda poi con don Emanuel de Castelvì, componente dello stamento militare nei Parlamenti d’Elda e de Borja, ottenendo un secondo prestito dello stesso ammontare.
Abdalla, altro degli schiavi di Ruecas, compare come garante in un contratto di taglia di un altro captivo, mettendo il suo padrone in contatto con i proprietari degli altri schiavi implicati nell’accordo: donna Joanna Castelvì e Amat e i giudici della Reale Udienza Joan Masons e Francesch Jagaracho.
Lo schiavo Juan Francesco viene battezzato dai nobili don Augustin Baccallar e donna Catherina Naharro e Baccallar, i cui cognomi evidenziano l’esistenza di una parentela tra le due famiglie. Joana viene battezzata dallo stesso don Augustin Baccallar e da una tale Lucrecia Vaquer e viene cresimata dal canonico Miquel Claramont; Antiogo Francesco ha come padrino il dottor Salvador Carcassona, avvocato dello stamento militare nel parlamento d’Elda; Antonio viene battezzato da Joan Pullo, mentre Antiogo da Martin del Contado. Martin del Contado compare anche nel 1611 nella documentazione sulle galere conservata nell’Archivo General de Simancas. Le galere della squadra di Genova, condotte dal duca di Tursi Carlo I Doria del Carretto, arruolano dieci forzati da Milano e dal Regno di Sardegna. Tra questi ultimi compare Del Contado, condannato perpetuamente al remo.
Francesch Jagaracho fa parte di una famiglia borghese sassarese, dedita alle professioni liberali. Nel primo Seicento è giudice della Reale Udienza e avvocato fiscale.
Possiede almeno undici schiavi tra il 1603 e il 1611, quattro dei quali vengono acquistati in occasione delle pubbliche aste successive alle prese dei corsari De Lorca e Prevost. In occasione di un accordo di credito a vantaggio del suo schiavo Amet di Annaba, Jagaracho si interfaccia con donna Juanna Castelvì e Amat, padrona dello schiavo creditore, con il barone don Portugues e con il suo schiavo Scandaria, intervenuti come testimoni dell’atto.
Un altra occasione di contatto con donna Juanna è la partecipazione dello schiavo Ali come garante per lo stesso atto di taglia cui partecipano Adalla di don Naharro de Ruecas e Ali del dottor Joan Masons.
Infine vediamo nei rapporti di padrinaggio, ancora una volta, l’emersione di figure sconosciute e non meglio collocabili: Gavino Bonaventura ha come padrino Joan Francesc Corda, Maria viene battezzata da Angel de Andriola e da Catelina Jana, Joan Gavi da Marta Carta e da Joan Hieroni Pascanal.
Monserrat Rossellò è un letrado, giudice della Reale Udienza e, alla fine del Cinquecento, visitador degli ufficiali del Regno.
Come i due precedenti, si trova in grande prossimità con i grandi nobili, ecclesiastici e con i principali protagonisti dell’amministrazione del Regno per via della comune partecipazione ai Parlamenti.
Rossellò acquista due schiavi nel 1604 da una presa del corsaro francese Prevost, e altri due nel 1606 da Miquel Roca, quarto consigliere della città di Cagliari, e da don Augustin Baccallar, nobile. I due schiavi vengono utilizzati da Rossellò come moneta di scambio per liberare un frate di nome Arcangel Daviso Capretzi, schiavo “in potere degli infedeli” nella città di Biserta.
Tra i dottori della Reale Udienza troviamo anche Joan Masons, attivo protagonista dei Parlamenti fino alla prima riunione del XVII secolo. Avvocato del Regio Patrimonio, giudice della Reale Udienza, dottore in leggi, sindaco e avvocato della città di Oristano, presente prima nello stamento reale e poi in quello militare.
I canali di scambio attivati dal possesso di schiavi sembrano restare sostanzialmente nell’ambito delle interazioni parlamentari. Tra compravendite, battesimi e fideiussioni sono coinvolti il corsaro Andreu de Lorca, donna Joanna Castelvì e Amat, Melchior Torrella e i mercanti genovesi residenti a Cagliari Joan Costa e Pere Morteo; ancora, il Reggente Pere Joan Soler, il dottor Angel Jagaracho, Gracia Quença e Santoru, Miquel Angel Bonfant, notaio, il reverendo Pau Sanna e Balthasara Bonfant e Masons.
Quest’ultimo cognome mostra l’esistenza di una parentela tra la famiglia del giudice Masons e quella dei notai Bonfant.
Anche la famiglia Palou è discretamente presente nelle fonti come proprietaria di schiavi, con Joan Antoni Palou e sua moglie Francisca Palou e Garcet.
Gli atti ritrovati parlano di acquisti, vendite e affrancamenti, oltre che dell’intervento di uno dei loro schiavi come garante in un atto di taglia.
Si tratta di accordi nei quali sono protagonisti Pere Blancafort, consigliere municipale di Cagliari, i nobili don Gaspar de Requesens e don Joan Baptista Zatrillas e i mercanti Miquel Calabres, Gaspar Bonato e Andria Materano. I Palou non risultano attestati nella fonte parrocchiale e sembra, dunque, non intervengano in occasione di battesimi e cresime, né come padroni di schiavi cristianizzati né come padrino e madrina di schiavi altrui.
Un altro protagonista istituzionale del Regno è Joan Francisco Jorgi, convocato nello stamento militare dei Parlamenti Aytona (1592-1594) ed Elda (1602-1603). È consigliere civico di Cagliari per diverse volte, podestà nel 1606 e, in Parlamento, svolge il ruolo di procuratore del feudo di Quirra e di diversi esponenti dell’élite del capo di Sassari.
Jorgi possiede numerosi schiavi ed è una figura ricorrente nella nostra ricerca. Attraverso le vicende riguardanti i suoi captivi, possiamo individuare alcuni legami parentali.
È sposato con Angela Cascali, componente di una famiglia che, attraverso il matrimonio della sorella Sperantia con don Melchior Torrella, si lega ai nobili baroni di Capoterra. La moglie di Jorgi, i cognati, donna Sperantia e don Melchiorre, e i nipoti, donna Magdalena e don Francesch Torrella sono molto presenti nelle tappe dell’esperienza schiavile dell’uomo. Compaiono spesso come padrini e madrine di battesimo e di cresima degli schiavi, insieme a personalità come il protomedico Joan Andreu, il canonico Spiga, don Pere Portugues e il canonico Miquel Gessa.
La cognata Sperantia e la nipote Magdalena sono anche le destinatarie della donazione di due schiave da parte di Jorgi che, alla fine della sua vita, lascia tutti gli schiavi che possiede a sua moglie Angela, comprese le due precedentemente donate alle Torrella. Gli accordi di compravendita che Joan Francisco Jorgi stringe lo mettono in relazione con il corsaro Guillelm Prevost ed evidenziano rapporti con la famiglia Carrillo nella persona di don Joan, e Montelles, con don Salvador.
Alla morte di Joan Francisco, sua moglie Angela si trova a gestire gli schiavi ereditati e decide di liberarne la maggior parte. La schiava Xarifa paga ad Angela Jorgi e Cascali centocinquanta lire per il proprio riscatto, denaro che viene consegnato alla padrona da Amet di Annaba, schiavo appartenuto a Miquel Calabres, mercante di Cagliari. La vedova Jorgi compare anche come madrina di battesimo di uno schiavo di don Melchior Torrella, suo cognato.
-
 La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà
La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà Le casate che si distinguono maggiormente nell’esperienza schiavile sarda della prima metà del Seicento sono i Centelles, i Castelvì, i Requesens e i Torrella.
Tra i nobili feudatari più potenti e importanti del Regno, troviamo don Christofol Centelles, prima conte e poi, dal 1603, marchese dello sconfinato feudo di Quirra.
Don Christofor è attivo protagonista delle Corti del 1602-1603 in qualità di ambasciatore e trattatore dello stamento militare. È in stretto rapporto col viceré conte d’Elda e con i maggiori esponenti dei tre stamenti e della regia cort, come personalità delle famiglie Castelvì, Alagon, Zatrillas, Zapata, Aymerich, Fortesa, Masons, Baccallar, Requesens, Torrella.
Dal 1602 al 1609 possiamo contare circa venti schiavi in suo possesso, molti dei quali acquistati direttamente durante i pubblici incanti delle prese corsare di Andreu de Lorca, Andreu Gisbert e Guillelm Prevost.
Don Christofor ha la tendenza a battezzare e cresimare buona parte degli schiavi che possiede.
I nomi dei padrini e delle madrine non sembrano rimandare, di norma, a famiglie della nobiltà. Tali famiglie emergono, invece, nel caso in cui sia Centelles a svolgere il ruolo di padrino o in occasione di compravendite private.
All’inizio del secolo, don Christofor battezza uno schiavo del viceré Coloma insieme alla contessa di Laconi donna Anna de Castelvì e vende uno dei propri captivi a don Joan Naharro de Ruecas, Tesoriere Reale.
Al proprio procuratore, Gaspar Cugia, ordina nel 1609 di occuparsi di ritrovare e ricondurre a casa Almanzor, schiavo fuggitivo. Cugia, a sua volta, delega il compito al proprio procuratore, il capitano del re Christofor Franco, palermitano abitante di Cagliari, anch’egli possessore di schiavi. Gaspar Cugia si occupa altresì di un’operazione di riscatto: troviamo una procura che Laurenso Pira, cittadino di Sassari schiavo di Sidi Hamida, dà a Cugia per occuparsi di procurare il denaro necessario alla sua liberazione dal padrone.
Nello stesso anno il marchese si trasferisce nella sua città natale, Valencia, portando con sé almeno quattro schiavi. A presentarsi davanti al Bailo di Valencia per occuparsi degli adempimenti necessari al trasferimento dei captivi fuori dalla Sardegna è un altro procuratore di Centelles, Antoni Datos del Castillo, insieme al nobile don Hieroni Mercader il quale si assume la responsabilità di recarsi a Cagliari per trovare le carte patrimoniali che attestano l’avvenuto pagamento del quinto reale sugli schiavi.
Dei contatti che è stato possibile ricostruire per don Christofol Centelles, una buona parte si intreccia al rapporto con Salem Desfachs, declinato prima nel binomio padrone-schiavo e poi evolutosi verso una collaborazione “professionale” dopo la sua liberazione.
Ricordiamo, ad esempio, i patroni Joan Dale e Baptista Baldo, Honorat Rocafort e Spirit Pipin.
Il caso del marchese di Quirra mostra una rete sociale “schiavile” che, più che sovrapporsi a quella “istituzionale”, prende nuove direzioni. Sottolinea un modo unico di sfruttare la schiavitù, almeno nel panorama della nostra ricerca. Centelles utilizza i suoi schiavi non solo durante il periodo vero e proprio di cattività, non solo per il lavoro forzato, non solo per il profitto delle vendite o dei riscatti. Porta avanti, invece, la strategia di utilizzarli anche successivamente, quando sono diventati uomini liberi, sfruttandone competenze, connessioni e abilità per il beneficio dei propri commerci. Possiamo ipotizzare che, da una parte, Salem sfrutti le conoscenze e le connessioni del marchese, ma che anche il marchese possa trarre vantaggio delle relazioni costruite autonomamente dal suo collaboratore. La spazialità che il network di Centelles disegna crea ponti tra Cagliari, Valencia, Biserta e altre città della Barberia e la Francia.
Un cognome ricorrente e particolarmente noto nella storia della Sardegna è Castelvì. Si tratta di una famiglia feudale di origine valenzana che nel Regno di Sardegna forma tre rami: i marchesi di Laconi, i signori di Samassi e Serrenti e i marchesi di Cea, imparentandosi con altre grandi famiglie nobiliari e feudali. Gli uomini della famiglia sono tra i più eminenti membri dello stamento militare in Parlamento, svolgendo spesso il ruolo di rappresentanti, abilitatori, trattatori e giudici dei gravami, stringendo rapporti di prossimità con gli altri maggiori nobili e feudatari. La famiglia Castelvì si rende protagonista nella vicenda schiavile anche con le sue esponenti femminili.
Don Jaume Castelvì tra il 1603 al 1617, tramite gli schiavi che possiede, entra in contatto con diverse personalità. Il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i quali gli consegnano il denaro del riscatto di uno dei suoi schiavi; Jaime de Aquena e Isabel Torres sono il padrino e la madrina uno “schiavetto”; lo schiavo Juan Baptista invece è battezzato da don Jaume stesso e da sua moglie, donna Anna de Castelvì; Juan Seraphi ha come padrini Salvador Caddeo, prete, e Joana Sorja; per Juan Jordi, invece, sono Jordi Jaquello e Rosa Marras. Al momento della cresima dello schiavo Pablo Zacharias, a fargli da padrino è Benitto Bravo.
Donna Anna de Castelvì battezza, oltre a Juan Baptista, anche uno schiavo del viceré Coloma insieme al marchese di Quirra don Christofol Centelles. La donna possiede a sua volta due schiave: una battezzata da Nicolau Porxella, signore della villa di Serdiana e ambasciatore dello stamento militare nel parlamento d’Elda, e l’altra cresimata dal dottore in utroque iure Gaspar Pira.
Don Francesco, visconte di Sanluri, al momento dell’ingresso nell’ordine dei padri cappuccini (nel 1607) lascia in eredità al fratello don Pau due schiavi che dovranno servire per quattro anni a suo beneficio e a beneficio di don Hieronim de Sena, sindaco della città di Alghero nel parlamento d’Elda, e di don Joan Sant Just, anche lui ripetutamente abilitato a partecipare alle Corti del Regno nello stamento militare. Don Francesco possiede un altro schiavo, Joan Baptista, che viene battezzato da Hieronima Sarroch e Castelvì, ed è anche padrino di battesimo di uno degli schiavi del nobile dottor Anton de Tola, anch’egli presente in Parlamento, insieme a Margalida Castañeda.
Don Pau è cavaliere di San Giacomo e Procuratore Reale dal 1616, grazie alle nozze con donna Mariana Deixar, erede dell’ufficio per via del padre don Nofre Fabra e Deixar. Don Pau possiede diversi schiavi oltre a quelli ricevuti dal fratello, tra i quali Amet, acquistato dal corsaro Barthomeu Didià. Compare, poi, come padrino nel battesimo di uno schiavo del conte di Cuglieri insieme a donna Mariana.
Altri esponenti della famiglia sono don Salvador de Castelvì che, per mezzo di Miquel Velasquez, intraprende un rapporto di compravendita col viceré Gandìa; donna Juana Castelvì e Amat dopo aver concesso una taglia allo schiavo Anasar, riceve la garanzia “fideiussoria” di altri tre schiavi dei quali sono padroni il dottor Juan Masons, don Juan Naharro de Ruecas e il dottor Francesch Jagaracho. Don Emanuel presta denaro allo schiavo Amet di proprietà di don Joan Naharro de Ruecas. Anche donna Mariana Castelvì e Deixar viene scelta come madrina: battezza una schiava di suo padre, don Nofre Fabra e Deixar, ed è madrina di cresima di Joan Thomas, il “negro venuto nella terra dei cristiani per farsi cristiano” con la cui storia famigliare si apre questo lavoro.
I numerosi contatti d’alto rango della famiglia sono tendenzialmente locali e identificati nell’alta società nobile e borghese della città e del circondario. Fanno eccezione alcuni nomi non meglio ascrivibili a specifici ambiti o posizioni sociali e presenti in qualità di padrini e madrine. Rileviamo, in alcuni casi, il realizzarsi di scambi interni all’ambito famigliare. A proiettare la famiglia verso l’esterno sono il francese Didià, il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i valenciani viceré Coloma e marchese di Quirra, gli schiavi provenienti dal Nordafrica e dalla Polonia.
A proposito di Joseph Caruso le fonti ci dicono che il suo protagonismo nel riscatto di schiavi non è circostanziale, ma una vera e propria attività “professionale”. Lo ritroviamo menzionato negli atti del consolato francese a Tunisi nel 1610, quando paga il riscatto di un uomo di Alicante schiavo a Tunisi di Ossoman Dey. Il riscatto avviene per volontà e su commissione di Miquel Vidal, mercante maiorchino residente a Cagliari. Caruso non manca, comunque, di possedere qualche schiavo: tra il 1603 e il 1608 è padrone almeno di tre.
Un’altra famiglia che emerge nel possesso schiavi è quella dei Requesens. È una famiglia catalana trasferitasi a Cagliari, presente in Parlamento almeno dal 1592-1594 con diversi esponenti della famiglia ammessi nello stamento militare, tra cui don Gaspare. Nel primo Seicento, egli possiede diversi schiavi. Amet di Algeri, per esempio, è coinvolto come garante in un atto di taglia a favore di uno schiavo di Pere Blancafort, insieme ad altri due schiavi appartenenti al defunto Joan Antoni Palou e a Miquel Calabres. Tra gli altri schiavi vi sono Maria Francesca, battezzata da Juan Pere Requesens e Angela Taria, e Antonia Ela, battezzata da Leonart Uda e Francesca Serra. Gli ultimi quattro nomi, sconosciuti, non sono collocabili in alcun ambito sociale.
Più attiva nell’ambito schiavile è donna Ysabel Requesens, o meglio Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon. Donna Ysabel, dal 1604 al 1616 possiede almeno dieci schiavi, alcuni dei quali protagonisti di eccezionali vicende personali. Tra i captivi che possiede troviamo Amet Bofetil di Biserta, il cui riscatto viene pagato a donna Ysabel dal patrone napoletano Salvator Izzo; Portia, che la donna acquista dall’arcivescovo di Arborea don Antonio Canopolo per mezzo del suo procuratore padre Hieronim Sanna, gesuita; Anastasia, la schiava poi affrancata che costruisce una famiglia con Joan Thomas de Santa Cruz: al loro matrimonio i testimoni sono Antiogo Lai e il reverendo Monserrat Baccallar, mentre a fare da padrino di confermazione alla loro figlia Catelina è chiamato Joan Miquel Carta; Anastasia ha anche un’altra figlia nata prima del matrimonio con Joan Thomas, che appartiene ai marchesi di Villasor e che viene battezzata col nome di Dionisa Isabela dal padrino Hieroni Pola e dalla madrina Maria Meli; infine, ricordiamo Axia, la schiava del commendatore Vintimilla che non risiede presso il padrone, ma nella dimora di donna Ysabel e che è implicata nella vicenda dell’avvelenamento del commendatore: questo fatto indica la sussistenza di un qualche rapporto tra la famiglia Alagon e Vintimilla.
Ultima esponente della famiglia è Donna Hieronima Carta e Requesens, che vende due schiave al dottore in diritti Anton de Tola, canonico di Cagliari. Nel 1610 Miquel Angel Carta presta uno dei propri schiavi al figlio Joan Baptista perché lo assista e lo serva in un viaggio da Cagliari alla Castiglia passando per Valencia, a bordo della nave del patrone francese Uguet Steva. Giunti nella penisola iberica, a giurare sui documenti notarili che attestano la legittimità del possesso dello schiavo sono il marchese di Quirra don Christofol Centelles e Gaspar Feo, valenciano. I Requesens possono vantare numerosi contatti altisonanti, ai quali si affiancano nomi poco o per nulla noti. La spazialità tracciata da tali relazioni mette in collegamento la Sardegna con Napoli, con Valencia, con la Francia e con il Nordafrica.
Infine, nella persona di don Melchiorr Torrella, barone di Capoterra, vediamo una chiara espressione dell’intreccio tra nobiltà, governo municipale e amministrazione cittadina, che trova nel possesso di schiavi un canale di consolidamento. Torrella, nobile, è implicato nel governo civico di Cagliari come consigliere capo nei primi anni del Seicento e rappresentante dello stamento reale nel parlamento d’Elda, abilitatore e trattatore, in cooperazione e vicinanza con i più alti rappresentanti delle istituzioni. Nella compravendita e nel possesso di schiavi troviamo interazioni con alcuni tra i principali ufficiali regi come Joan Masons, giudice della Reale Udienza, l’avvocato fiscale Joan Antoni Palou, e altri amministratori civici come Joan Francisco Jorgi, consigliere municipale. Altri contatti sono stretti con i mercanti Joan Costa, genovese, e Joan Angel Quessa, cagliaritano. Altri esponenti della famiglia Torrella, come visto precedentemente, sono implicati come padrini e madrine di schiavi e schiave della famiglia Jorgi, dell’arcivescovo D’Esquivell, del canonico Salvador Costanti, del consigliere civico Jaume Hortola e del barone di Orosei e Galtellì Fabrissio Manca e Guiso.
-
 La società cagliaritana e gli schiavi: i viceré
La società cagliaritana e gli schiavi: i viceré Come alter ego del re, il viceré è la figura governativa più importante del Regno (insieme al Procuratore Reale e al Reggente la Reale Cancelleria), soluzione all’assenza del sovrano da ciascun Regno.
I viceré di Sardegna sono grandi possessori di schiavi, agevolati dal privilegio della “joya” che gli consente di ottenere uno schiavo per ogni presa corsara a titolo di donazione.
Abbiamo potuto rinvenire notizie sull’esperienza di possesso di schiavi dei primi tre viceré del diciassettesimo secolo: si tratta di tre nobili provenienti dal Regno di Valencia, tutti di fazione lermista. Il primo è il conte d’Elda don Anton Coloma, la cui moglie è parente prossima del valido di Filippo III; il secondo, il conte del Real don Pedro Sánchez de Calatayud, espressione del partito dominante a corte; il terzo, il duca di Gandía don Carlos Borja, appartiene alla cerchia parentale di Lerma.
Don Anton Coloma possiede captivi tra il 1600 al 1604 e ottiene la maggior parte di essi in occasione dei pubblici incanti, interfacciandosi direttamente con il Procuratore Reale don Nofre Fabra e Deixar, con gli altri ufficiali implicati nella gestione delle vendite, come il Maestro Razionale Francesco de Ravaneda, e con i corsari Andreu de Lorca, maiorchino o valenzano, Andreu Gisbert, Guillelm Prevost e Jean Baptiste Lalgin, francesi. In occasione dei battesimi dei suoi schiavi, sono alcuni tra i più grandi nobili e alti prelati del Regno (spesso anch’essi nobili) a testimoniare in qualità di padrini e madrine. Ad esempio, il battesimo dello schiavo Francesch viene officiato dal vescovo di Ales, don Antoni Zureddu e il padrino è don Christofol Centelles, prima conte e poi marchese di Quirra, mentre la madrina è donna Anna di Castelvì, contessa di Laconi. In altri casi troviamo personaggi come don Juan Coloma, (parente non meglio specificato del viceré), e donna Maria de Aragall, moglie del governatore del capo di Cagliari e Gallura, don Jaume de Aragall. Compaiono anche nomi non appartenenti alla nobiltà e sui quali né la documentazione archivistica, né quella bibliografica consentono di dare maggiori informazioni, come Vincent Amador e Anna Latzara.
Gli schiavi del conte del Real don Calatayud, viceré e armatore, vengono battezzati e cresimati da padrini e madrine come Juan dela Matta, capitano delle torri, e sua moglie Maria Matta e Perser, dal dottor reverendo Matheo Ornano e il canonico della Cattedrale di Cagliari Joan Sini. Alcuni personaggi, come tre esponenti della famiglia Amelda, rimangono indefiniti e non collocabili in un preciso contesto sociale. Di alcuni dei captivi del viceré abbiamo potuto seguire alcuni momenti di vita. Luis, battezzato nel 1605, viene portato a Valencia nel 1607 dalla moglie del viceré, donna Marina Calatayud e Bou, sulla nave di un patrone francese di nome Urban de Quill per essere regalato o venduto; Hagemusa viene affrancato nel 1606 e affidato a Salem Desfachs, comprador del marchese di Quirra, per essere condotto a Biserta dove deve reperire il denaro del proprio riscatto e di quelli di altri schiavi. A rendere possibile il contatto e la collaborazione tra il viceré e Salem potrebbe essere il legame di amicizia, parentela e affari esistente tra Calatayud e il marchese di Quirra.
Per quanto riguarda il duca di Gandìa, infine, abbiamo rilevato il possesso di almeno cinque schiavi in sei anni. Per mezzo di Miquel Velasquez, suo segretario personale e procuratore nello stamento militare, acquista una schiava da don Salvador Castelvì, esponente della grande famiglia dei visconti di Sanluri e marchesi di Laconi. Gli altri legami basati sul possesso di captivi sembrano coinvolgere persone non nobili: Rusina Lopez, Pau Clua, maggiordomo del viceré, e Anna Cerisa, i quali svolgono i ruoli di padrino e madrine nei battesimi.
Anche nella seconda metà del secolo, fra il 1670 e il 1684, continuiamo a trovare i viceré tra i padroni di schiavi. Dodici dei venti schiavi che in quegli anni entrano malati nell’ospedale di Sant’Antonio di Cagliari appartengono ai viceré: tre appartengono a don Francisco de Tutavila e del Rufo, duca di San Germano, e sette a don Fernando Joaquín Fajardo de Zúñiga Requesens, VI marchese di Los Vélez.
I viceré, dunque, nelle interazioni derivanti dal possesso di schiavi, sembrano privilegiare altri grandi nobili e alti prelati. Questi interlocutori sono spesso presenti in Parlamento e implicati nella vita politica sarda. Le relazioni includono anche le loro consorti, i figli, i fratelli e altri componenti delle loro famiglie, suggerendo la presenza di canali preferenziali di comunicazione e stretti rapporti interpersonali.
Sono frequenti i rapporti diretti con chi gestisce le vendite all'asta dei bottini umani, come Procuratori Reali, Maestri Razionali e corsari, anche grazie al diritto "di prelazione" di cui godono i rappresentanti del re.
-
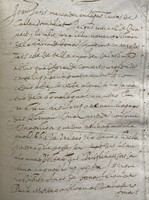 Garantire la liberazione: schiavi fideiussori
Garantire la liberazione: schiavi fideiussori
-
 Schiavi e attività creditizia
Schiavi e attività creditizia
-
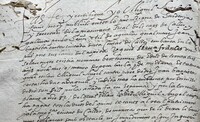 Fuori dal Regno: viaggi di schiavi tra la Sardegna e la penisola iberica
Fuori dal Regno: viaggi di schiavi tra la Sardegna e la penisola iberica
-
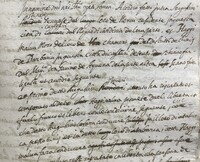 Mobilità, mediazione e riscatto
Mobilità, mediazione e riscatto
-
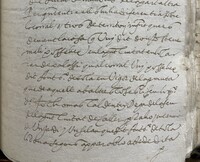 Baratto di schiavi per animali e oggetti
Baratto di schiavi per animali e oggetti
-
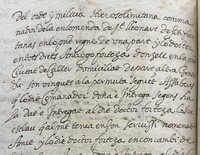 Cambiare il proprio schiavo per un altro: Joan Luis e Amet
Cambiare il proprio schiavo per un altro: Joan Luis e Amet
-
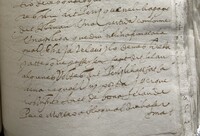 Schiavi in fuga
Schiavi in fuga
-
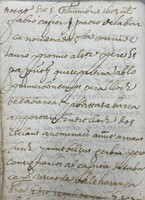 "Sono un buono a nulla ma valgo qualche cosa": scambi di schiavi
"Sono un buono a nulla ma valgo qualche cosa": scambi di schiavi
-
 Schiavi feriti
Schiavi feriti
-
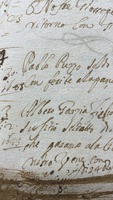 Schiavi all'Ospedale di Sant'Antonio Abate (Cagliari)
Schiavi all'Ospedale di Sant'Antonio Abate (Cagliari)
-
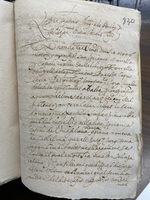 Famiglia Jorgi: lasciti testamentari e donazioni
Famiglia Jorgi: lasciti testamentari e donazioni
-
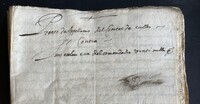 La rete criminale di Joan Luis
La rete criminale di Joan Luis
-
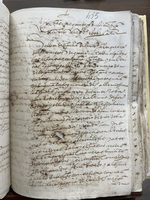 Salem Desfachs e la logistica mediterranea
Salem Desfachs e la logistica mediterranea Salem Desfachs è un liberto, ex schiavo appartenuto a don Christofol Centelles, tra i più potenti signori feudali di Sardegna, primo marchese di Quirra e grande “uomo d’affari” impegnato specialmente nella speculazione cerealicola. Salem, nel 1606, emerge come figura centrale in una dinamica serie di attività commerciali. Da solo o in collaborazione con Amet di Tripoli, forse un altro liberto, è attivo, nella circolazione di denaro, nel commercio di vino, caffè e stoffe, nei riscatti e nelle garanzie a favore di altri schiavi.
Insieme a Gusman Marsilia, un patrone di nave maltese, nel 1606 stipula un accordo con Augustina Morvillo e de Persia, residente nell’appendice della Lapola di Cagliari. La donna è sposata con Baptista Morvillo, originario di Napoli, il quale si trova in quel momento schiavo a Biserta. L’accordo prevede che Salem e Marsilia si rechino nella città tunisina per riscattare e riportare a Cagliari Morvillo. Augustina promette che, non appena i due condurranno suo marito a casa, pagherà ai due 900 lire: prezzo del riscatto e delle spese.
Alla fine del 1607, Salem stringe un nuovo accordo con il provenzale di Cassis Joan Dale, patrone di una tartana. Dale porterà fino a Biserta 40 quintali di caffè, una grande botte di vino rosso e Hegemusa, schiavo di don Pedro Sanchez de Calatayud, viceré di Sardegna dal 1604 al 1610. Una volta giunto a destinazione, Dale consegnerà la merce e lo schiavo a chi Salem indicherà. Per questa commissione riceverà 171 lire.
Non molti giorni dopo, Salem commissiona a Battista Baldo, patrone cagliaritano dell’appendice della Lapola, il trasporto a Biserta di un carico di stoffe e dello stesso schiavo prima affidato a Joan Dale. Questo fatto ci fa ipotizzare che per qualche ragione l’accordo precedente non si sia potuto realizzare. Hagemusa deve recarsi in Barberia per reperire il denaro del proprio riscatto e di quello di altri schiavi e Salem si rende disponibile a fargli da garante per il viaggio in mare, ricevendo in cambio 900 lire.
Il liberto affida a Baldo anche altri compiti: trasportare a Cagliari un carico di stoffe e un’imbarcazione, e occuparsi di un riscatto commissionato da Miquel Vidal, un mercante di Maiorca residente a Cagliari. In cambio dei servizi prestati, il patrone riceverà parte delle stoffe trasportate in Barberia, metà dell’importo ricavato dalla loro vendita e un terzo di quanto guadagnato dai quaranta quintali di caffè portati a Biserta da Joan Dale; avrà anche un terzo del guadagno ottenuto dal riscatto dello schiavo cristiano. Per assicurare il viaggio di Battista Baldo, Salem promette al patrone e ai marinai che andranno con lui, che basterà la sua parola per far sì che non siano ostacolati né catturati durante la navigazione o durante la permanenza. E se dovessero essere catturati o gli venisse causato qualche danno, Salem stesso li risarcirà; se dovessero essere catturati e venduti in Berberia li riscatterà e ripagherà i danni.
L’ultima traccia documentale delle attività commerciali di Salem riguarda un accordo col mercante cagliaritano Hieronim Brondo. Il liberto dichiara di essere debitore a Brondo per la somma di 190 lire, prezzo di un carico di stoffe che questi gli ha venduto, e promette di pagare quanto dovuto entro due mesi. Inoltre assicura che, non appena Battista Baldo tornerà dalla Barberia con il carico di lana, ne venderà cinque quintali a Brondo, se lo vorrà, a un prezzo favorevole.
Salem ha un legame con una donna, Fatima, schiava di Miquel Vidal. Si tratta dello stesso Vidal che abbiamo già visto legato a Salem da una commissione di riscatto, e proprio la previa conoscenza tra il liberto e il mercante potrebbe aver favorito l’unione con la schiava. Nel 1609 Fatima e Salem perdono un figlio neonato.
Nell'atto di morte del bambino, Salem viene definito “comprador que es del marques de Quirra”, titolo che esplicita e conferma un rapporto "professionale".
-
Morte di un neonato figlio di una schiava di donna Castaner
Muore un “albat” figlio di una schiava di donna Margalida Castaner che viene sepolto nel fossario.
-
Morte di una schiava giovane di don Dela Bronda
Muore una schiava “negra” di Joan Angel dela Bronda. Aveva ricevuto il sacramento dela penitenza e l’estrema unzione. Per la giovane età non aveva ricevuto l’eucaristia. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di una schiava della signora Anna Massons
Muore una schiava della signora Anna Massons che aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario.
-
Morte di una schiavetta
Muore una schiavetta di Hieronim Boy che aveva ricevuto il sacramento dell’eucaristia. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte della liberta Catelina
Muore Catelina, liberta, che era stata schiava del quondam Francesco Jorji (“sclava que era”). Aveva ricevuto tutti i sacramenti e con cerimonia semplice viene sepolta nella chiesa di San Francesco.
-
Morte di una neonata schiava di donna Gualbes e Castelvì
Muore una albat schiavetta di donna Seraphina Gualbes e Castelvi. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di uno schiavo del viceré
Muore uno schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Aveva ricevuto il sacramento della penitenza e l’estrema unzione. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte dello schiavo Francesco
Muore Francesco, schiavo del signor canonico Busquets. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolto dentro la sede episcopale con cerimonia semplice.
-
Morte di una schiavetta di donna Isabel Setrilles
Muore una “negretta” di donna Isabel Setrilles che aveva ricevuto il sacramento della penitenza e l’estrema unzione. Viene sepolta nella tomba delle anime del purgatorio dentro la Cattedrale di Cagliari.
-
Morte di una schiava del conte di Serramanna
Muore una schiava del conte don Anton Brundo di nome Catelina. aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario con cerimonia semplice.
-
Morte di uno schiavo del conte di Serramanna
Muore uno schiavo del conte di Serramanna don Antonio Brundo. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolto nel fossario.
-
Morte del neonato figlio di una schiava del marchese di Sanluri
Muore un “albat” di una schiava del marchese di Sanluri. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte del figlio di uno schiavo dell’arcivescovo
Muore un albat di Francesco, schiavo dell’illustrissimo reverendissimo arcivescovo di Cagliari. Viene sepolto nel fossario “per amore di Dio”.
-
Morte di uno schiavo di Sisinni Meli
Muore uno schiavo di Sisinni Meli senza alcun sacramento. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di Simoni, schiavo di don Castaner
Muore Simoni, schiavo di don Simoni Castaner. Aveva ricevuto il sacramento della penitenza e l’estrema unzione. Non può ricevere l’eucaristia e viene sepolto nel fossario.
-
Morte della schiava Juana
Muore Juana, “negra” schiava di donna Isabel Setrillas. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di una neonato figlio della schiava Luicia
Muore un albat figlio de Llussia, “negra” di donna Juana Amat. Viene sepolto nel fossario “per amore di Dio”.
-
Morte della schiava Maria
Muore una schiava di nome Maria di don Gaspar de Requesens. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario.
-
Morte di una bambina schiava di Eugenia Sanna
Muore una schiavetta della signora Eugenia Sanna. Aveva ricevuto tutti i sacramenti. Viene sepolta al Carmelo.
-
Morte di una neonata della schiava del canonico Pirella
Muore una albat della schiava dell illustre canonico Melchior Pirella. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di uno schiavo di don Barbarà
Muore uno schiavo di don Andriano Barbarà. Non aveva ricevuto nessun sacramento, viene sepolto nel fossario.
-
Morte di una schiava di donna Narro
Muore una schiava di donna Juana Narro. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta con cerimonia semplice nella sede episcopale di Cagliari nella tomba delle anime del purgatorio.
-
Morte di una schiava della governatrice
Muore una “negra” di donna Maria de Servello, governatrice. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene viene sepolta nel fossario.
-
Morte di uno schiavo
Muore uno schiavo del [_____] Sanna. Gli viene conferita l’estrema unzione e viene sepolto nel fossario della sede episcopale.
-
Morte di una schiava di don Miquel Picassa
Muore una schiava di don Miquel Picasso. Non aveva ricevuto alcun sacramento salvo il battesimo conferito in punto di morte per suo desiderio. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di un neonato figlio di una schiava del reverendo Murtas
Muore un albat di una schiava del reverendo Murtas, beneficiato della sede episcopale. Viene sepolto nel fossario “per amore di Dio”.
-
Morte di una schiava di Miquel Angel Bonfant, notaio
Muore una schiava di Miquel Angel Bonfant senza nessun sacramento. Si celebra una cerimonia semplice e viene viene sepolta nella chiesa dei frati del Carmelo.
-
Morte di Magdalena
Muore Magdalena, schiava di donna Maria de Cervello. Aveva ricevuto tutti i sacramenti e viene sepolta nel fossario con cerimonia semplice.
-
Morte di una schiava del visconte di Sanluri
Muore una schiava “negra” dell’illustre marchese e visconte di Sanluri. Aveva ricevuto tutti i sacramenti, tranne il viatico. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di una schiava del dottor Deliperi
Muore una schiava del dottor Thomas Deliperi. Riceve l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario.
-
Morte dello schiavo Antonet
Muore Antonet, schiavo del consigliere fiscale Antiogo Atçori. Riceve la confessione e non riceve altri sacramenti. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di un neonato figlio di una schiava di don Antiogo Cani
Muore un albat figlio di una schiava di don Antiogo Cani. Lo seppellisce Jjoan Francesc , prete, nel fossario.
-
Morte di uno schiavo del dottor Fortesa
Muore un “negro” del dottor Gaspar Fortesa senza alcun sacramento e con una cerimonia semplice. Lo schiavo viene sepolto nel fossario.
-
Morte di una schiava di Miquel Calabres
Muore una schiava “negra” di Miquel Calabres senza preavviso. Viene fatta una semplice cerimonia officiata dal prete Miquel Murja. La schiava viene sepolta nel fossario.
-
Morte di un neonato schiavo di Joan Francisco Jorgi
Muore un albat della schiava di Joan Francisco Jorji, Officia la cerimonia Miquel Murja, prete. Il neonato viene sepolto nel fossario.
-
Morte di uno schiavo di don Anton Brundo
Muore Joan Thomas, schiavo di don Anton Brundo. Riceve l’estrema unzione e, essendo morto senza preavviso, non vi è il tempo per conferire altri sacramenti. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte dello schiavo Joan Baptista
Muore Joan Baptista, schiavo di Ferrando Sabater. Riceve i sacramenti della “santa madre chiesa”. Viene fatta una cerimonia semplice da parte di Miquel Murja, prete. Lo schiavo viene sepolto nel fossario della sede episcopale di Cagliari dopo aver ricevuto l’Estrema unzione.
-
Morte dello schiavo Francesco
-
Morte della schiava Margalida
Muore senza preavviso Margalida, schiava di don Thomas Brundo. Non riceve nessun sacramento per mancanza di tempo: “no avisaren per ningun sacrament”. Viene fatta una cerimonia semplice e Margalida viene sepolta nella chiesa del santo sepolcro.
-
Morte di Antonico, schiavo di don Joan Naharro de Ruecas
Muore Antonico, “negro” schiavo di don Johan Naharro de Ruecas. Riceve tutti i sacramenti “della santa madre chiesa”. Officia la cerimonia Miquel Murgia, prete, dà l’estrema unzione e Antonico viene sepolto nella tomba del purgatorio della sede episcopale di Cagliari.
-
Morte di un neonato figlio di una schiava
Muore un albat figlio della schiava “negra” di donna Cathelina de Madrigal. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di una schiava di Nicolau Montelles
Muore una schiava di Nicolau Montelles che si converte “in articulo mortis” domandando il sacramento del battesimo. Battezzata da Miquel Murja, prete, riceve poi l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario.
-
Morte della schiava Juana
Muore Juana, “negra” schiava di donna Isabel Setrillas. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte del figlio neonato di Fatima e Salem
Muore un albat figlio della esclava di Miquel Vidal di nome Fatima. Viene sepolto nella Cattedrale di Cagliari. Il padre è Salem, compratore del marchese di Quirra.
-
Morte di un neonato schiavo del capitano Franco
Muore un albat, cioè un neonato, schiavo del capitano Christoforo Franco. Non è indicato il luogo di sepoltura.
-
Morte di una schiava del canonico Soler
Muore Maria, schiava del canonico Salvador Soler. Si converte nell’ora della morte e chiede il sacramento del battesimo, viene battezzata, le viene data l’estrema unzione e viene sepolta nel fossario della sede espiscopale di Cagliari.
-
Morte di un liberto
Muore Barthomeu, liberto “negro” schiavo che era del defunto Francesch Natter. Muore per un incidente e non si può dargli l’estrema unzione. Viene sepolto nella sede episcopale di Cagliari.
-
Morte di uno schiavo neonato del dottor Ferrer
Muore un albat schiavetto del dottor Ferrer e viene sepolto nel fossario.
-
Morte di uno schiavo per omicidio
Muore uno schiavo di don Anton Brundo per una pugnalata ricevuta da parte di un altro schiavo. In punto di morte si converte e chiede il battesimo, viene battezzato e chiamato Juan Baptista ma non si ha il tempo di conferirgli altri sacramenti. Viene sepolto nel cimitero.
-
Morte di uno schiavo neonato
Muore un albat, schiavetto del veguer Joan Esteve Meli. Viene sepolto nel fossario della sede episcopale di Cagliari.
-
Omicidio da parte di uno schiavo
Questo atto di morte non contiene la morte di uno schiavo ma fornisce la notizia di un delitto compiuto da uno schiavo. Infatti si tratta dell’atto di morte di Andria Garau, morte causata da una pugnalata data da uno schiavo del dottor Capay. Il testo indica “una pugnalada dona lo esclau del doctor capay”. La vittima viene sepolta nel convento di Gesù e ha ricevuto tutti i sacramenti.
-
Morte di una schiava di Melchior Andreu
Muore una schiava “negra” di Melchior Andreu. Aveva ricevuto il sacramento della penitenza. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di uno schiavo appena nato
Muore un “albat”, cioè un neonato, (albat=creatura morta prima di avere l’uso della ragione) schiavetto di don Juan Naharro. Viene sepolto al cimitero.
-
Morte di Perico
Muore Perico, schiavo del dottor Garcet. Aveva ricevuto tutti i sacramenti, riceve l’estrema unzione e viene sepolto nel fossario.
-
Morte di uno schiavo del dottor Garset
Muore Petro, “negro” schiavo del dottor Garset. Non riceve nessun sacramento perché non si ha il tempo. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di Francesco de Jorgi
Muore Francesco de Jorgi schiavo del potestà. Riceve il sacramento dell’estrema unzione solamente perché per gli altri non c’è stato il tempo. Viene sepolto nella tomba “de purgatori” e viene confessato da un padre della Santa Croce.
-
Morte di Catelina de Santus
Muore Catelina de Santus, schiava di Pere Santus. Ha ricevuto solo l’estrema unzione perché non aveva l’età di ricevere gli alti sacramenti. Viene sepolta nella tomba “de purgatori” della sede episcopale di Cagliari.
-
Morte di uno schiavo del governatore
Muore uno schiavo del governatore. Non ha ricevuto nessun sacramento. Il nome era Juan Baptista. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di uno schiavo di Phelipe Silvestre
Muore un “negro” di Phelipe Silvestre. Non ha ricevuto i sacramenti per non aver “avisat” ed essere morto improvvisamente. Viene sepolto nel cimitero (“en lo simiteri”).
-
Morte di una schiava di Pere Porta
Muore la “negra” di Pere Porta che aveva ricevuto tutti i sacramenti della santa madre Chiesa. Non viene fatta l’estrema unzione per “no aver avisat”, essere cioè morta improvvisamente. Viene sepolta nel cimitero della sede episcopale di Cagliari.
-
Morte di uno schiavo del giurista Sanna
Muore un “negro” di “miser” Sanna, giurista. Viene sepolto nel fossario.
-
Muore una schiava del dottor Joan Angel Concas
Muore una “negra” in casa del dottor Joan Angel Concas. Aveva tutti i sacramenti della “santa madre chiesa”. Viene seppellita nel santo sepolcro: “en santo sepulcre”.
-
Morte di uno schiavo di Agostino Sabater
Muore un “negro” di Agostino Sabater. Viene confessato prima di morire e viene sepolto nel fossario.
-
Morte di un neonato
Muore un neonato, figlio della “negra” del marchese di Villasor. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di Joanillo
Muore Joanillo, “negro” di don Joan Amat. Ha ricevuto tutti i sacramenti della “santa madre Chiesa” e l’estrema unzione. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di uno schiavo di Francesch Mello
Muore un “negro” di Franchesch Mello senza ricevere sacramenti “per non aver avisat”. Viene sepolto nel fossario.
-
Muore una schiava di Joan Angel Concas
Muore una “negra” di Joan Angel Concas. Viene confessata e, per non aver “avisat”, cioè per essere morta improvvisamente, non riceve gli altri sacramenti. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte dello schiavo Bartomeu
Muore Bartomeu, schiavo che era di don Antonio Cardona “virrey de Caller”. Senza sacramenti perché muore improvvisamente. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di una schiava di Francesch Estallo
Muore una “negra” di Franchesch Estallo senza sacramenti. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di una schiava di Gabriel Blancafort
Muore una “negra” di Gabriel Blancafort senza sacramenti. Viene sepolta nel fossario.
-
Morte di uno schiavo del barone di Capoterra
Muore un “negro” del barone di Capoterra Portugues. Viene sepolto nel fossario.
-
Morte di una schiava del podestà di San Gavino
Muore una “negra” del podestà di san Gavino che aveva tutti i sacramenti. Viene viene sepolta nel fossario.
-
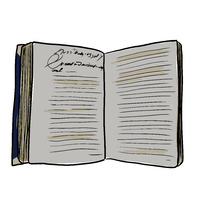 Morte di una schiava di Hieroni Sanna
Morte di una schiava di Hieroni Sanna Muore una schiava di Heroni Sanna. Viene sepolta nel fossario (“al fossar”).
-
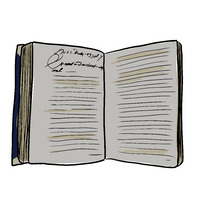 Morte di una schiava del viceré
Morte di una schiava del viceré Muore una schiava del viceré che aveva ricevuto tutti i sacramenti. Viene viene sepolta “en jesus”, cioè nella chiesa di Nostra Signora del Gesù.
-
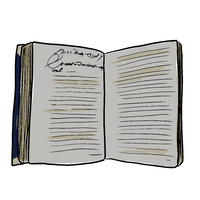 Battesimo di una schiava nella Diocesi di Sassari
Battesimo di una schiava nella Diocesi di Sassari Viene battezzata la schiava del signor don Henrigues de Sena. Le viene dato il nome di Caderina Antonia Joanna. Padrino è il reverendo Marcu Barra e madrina Antonia Corriga.
-
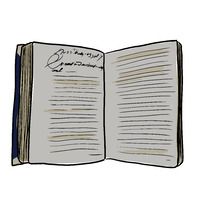 Battesimi di due schiavi nella Diocesi di Sassari
Battesimi di due schiavi nella Diocesi di Sassari Vengono battezzati dall’arcivescovo di Bosa don Gavino Manca lo schiavo del monsignor di Arborea don Antonio Canopolo e un altro del signor don Pedro de Mulines. Si chiamano uno Joan Antonio e l’altro Joan Pedro. Padrini per entrambi sono il governatore e la governatrice di questa città.
-
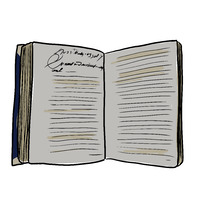 Abraam lascia in Sardegna Juaneta, sua figlia
Abraam lascia in Sardegna Juaneta, sua figlia Un musulmano di nome Abraam, ora liberto e prima schiavo di Miquel Comprat, dovendo tornare in Barberia, deve lasciare una sua figlia cristiana di 4 anni, chiamata Juaneta. Perché la figlia non resti senza protezione, la affida alla signora Gracia Cavalier y Comprar affinché stia per venti anni a servizio della signora che dovrà provvedere a farla sposare. La signora Gracia, l'accetta come serva alle condizioni abituali per il servizio domestico: promette di tenerla da sana e malata, di provvederla di vestiti e di scarpe, di mangiare e bere e di darle per il matrimonio 100 lire, 50 in soldi e 50 in roba.
-
Fatima e Monsor lasciano la loro figlia Juana in Sardegna
Due schiavi liberati, Fatima de Carbonell e Monsor de Gaspar Blancafort, marito e moglie, devono tornare in Berberia e non possono portare con sé la figlia Juana poiché battezzata e quindi cristiana (“per esser aquella crestiana”). Per questo la affidano all’ex padrone della madre, affinché la tenga presso di sé come una figlia finché non prenderà marito. E nell’ottica di aiutarla in tal senso i genitori lasciano all’ex padrone del denaro da far fruttare a favore della bambina. Qualora la bambina morisse, chiedono che il denaro con gli interessi venga dato ai nipoti Paolo e Girolamo, figli di Fatima Oxa e Abdalà.
-
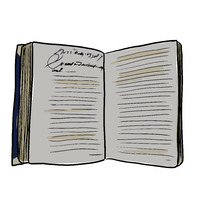 Atto di taglia stabilito in nove anni e mezzo
Atto di taglia stabilito in nove anni e mezzo Lo schiavo deve versare al padrone 120 ducati, 5 al momento della stipula dell’atto e 115 nel corso del tempo per un ducato al mese. Gli anni previsti sono dunque 9 e mezzo: anche se la somma fosse stata pagata prima, il tempo non sarebbe diminuito.
-
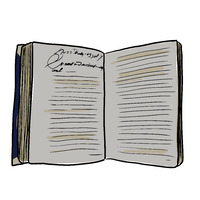 Atto di taglia di Alì
Atto di taglia di Alì L’atto di taglia di Alì prevede che egli versi 80 ducati, valenti 224 lire di Cagliari. L’atto precisa che un ducato vale 56 soldi e cioè 2,8 lire. Alì dovrà versare un ducato al mese e quindi la durata della taglia è prevista in sei anni e sei mesi. È stabilito che, qualora ne sia in grado, potrà versare più di un ducato al mese facendo così accorciare la durata della taglia.
-
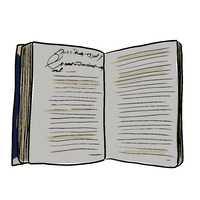 Taglia di Amet
Taglia di Amet Allo schiavo Amet viene accordato il riscatto per taglia e il padrone concede che egli, insieme alla moglie Fatima, già liberta, possa dormire fuori da Cagliari: “fora de Caller”.
-
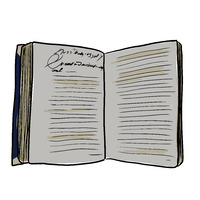 Atto di taglia di uno schiavo di Bona
Atto di taglia di uno schiavo di Bona Due coniugi di Lapola di Cagliari stipulano accordo di taglia con il loro schiavo di Bona. Gli impongono di dormire a casa loro per svolgere i servizi dovuti di notte e di giorno, ma concedono che possa dormire fuori casa una o due notti, nel Castello di Cagliari, per poter provvedere alle sue necessità.
-
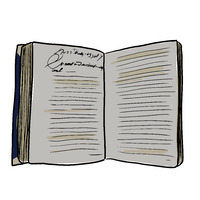 Taglia di uno schiavo di Bona
Taglia di uno schiavo di Bona Due coniugi di Lapola di Cagliari stipulano accordo di taglia con il loro schiavo di Bona. Si impegnano a consegnargli un “gonell” di orbace e una berretta sarda. Gli consentono inoltre di poter lavorare e servire altrove per guadagnare per se stesso e per il proprio riscatto, dopo aver adempiuto ai compiti che come schiavo è tenuto a fare a casa del padrone.
-
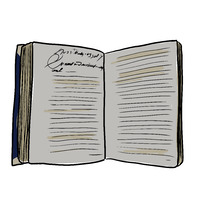 Taglia di Sebastiano, nero convertito
Taglia di Sebastiano, nero convertito Mossen Nicolò Pintor sprona il suo schiavo nero convertito, Sebastiano, a lavorare. Secondo lui lo schiavo non si curava di procurarsi la libertà. I due stipulano un accordo di taglia a condizioni molto vantaggiose per Sebastiano: avrebbe potuto dormire in casa del padrone e avrebbe ricevuto indumenti e scarpe.
-
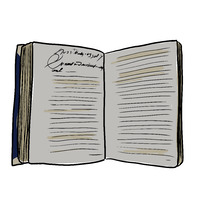 Taglia di Fatima, sessantenne di Tunisi
Taglia di Fatima, sessantenne di Tunisi Una donna residente nel quartiere di Lapola, a Cagliari, permette alla sua schiava sessantenne Fatima di Tunisi, di poter lavorare per guadagnare il denaro necessario a pagare la propria taglia.
-
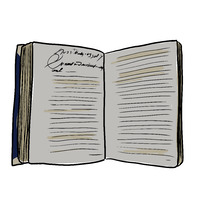 Taglia di Bartolomeo de Pintor
Taglia di Bartolomeo de Pintor Bartolomeo de Pintor, schiavo convertito, viene sottoposto a taglia.
-
Liberazione gratuita dello schiavo Tommaso
Nel 1563 Margherita Masala e Baquer, vedova del maghifico Giovanni Masala, mossa da benevolenza e per salvezza della propria anima, perdono dei propri peccati, e in riconoscenza dei servizi resi durante il periodo di schiavitù da Tommaso, suo schiavo cristiano di origine africana. La libertà viene accordata anche alla figlia di lui, nata da una relazione con una donna libera di Neoneli, Pintada Murgia. Specifica l’atto che l’emancipazione dei due viene conferita liberamente e senza alcuna condizione.
-
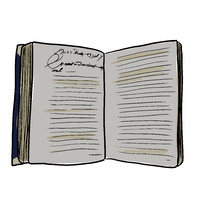 Una conversione complicata
Una conversione complicata Una schiava di Tunisi, poco dopo essere stata battezzata, venne processata dall’Inquisizione sarda nel 1593 perché i padroni la accusarono di aver maledetto il giorno in cui aveva ricevuto il battesimo, affermando che sebbene un musulmano non fosse battezzato, andrebbe lo stesso in paradiso come un cristiano se rispetta la sua legge; che la religione islamica è migliore di quella cristiana, che il battesimo ricevuto era solo stato accettato con la bocca ma non col cuore; e che alla fine dei conti mori e cristiani sono tutti uniti.
Cercò di giustificarsi dicendo che aveva detto quelle cose perché le avevano promesso la libertà se si fosse battezzata, senza mai dargliela. In verità, tra le poche righe riassuntive del suo processo , si scorgono le sue intime convinzioni: disse che "era vissuta da musulmana per 50 anni e aveva spesso dubitato delle dottrine della santa fede cattolica e dubitava spesso delle cose di cui la si accusava e creduto ciò di cui era accusata". Alla fine fu riconosciuta colpevole e condannata a tre anni di prigione e a portare per lo stesso periodo l'abito penitenziale, chiamato sambenito. Nel frattempo era stata liberata, giacché durante il processo viene chiamata liberta. Di lei non si sa altro. Tornò alla terra dei moroso restò nell'isola? Molto probabilmente continuò a credere che "chi osserva la sua religione" si salva e a sperare che "alla fine, musulmani e cristiani saremo tutti uniti"
-
Da schiava a nipote
Una vedova del quartiere cagliaritano di Stampace, Caterina Corelles, dopo la morte del marito, il mercante Mariano de lo Frasso, si trovò in ristrettezze economiche e fu spinta a vendere prima una sua schiava cristiana bianca di nome Giovanna che aveva portato in dote al marito e, in un secondo momento, anche la figlia di questa schiava, chiamata Annetta. Mentre era in trattative per la cessione della bambina di 4 anni a un altro padrone, il figlio Peroto de lo Frasso le confessò che la bambina era sua figlia nata da una relazione con la madre prima che fosse venduta. Dopo la rivelazione del figlio, la vedova Corelles-de lo Frasso ruppe le trattative per la vendita della nipote e preferì tenere la bambina e liberarla, affidandola alle cure di una figlia di 24 anni. «Non volli – così fece scrivere al notaio rendere la bambina schiava di altri né vendere il mio stesso sangue». Annetta ebbe probabilmente una vita agiata assieme al padre, alla zia e alla nonna. Visse, però, senza la madre che l’aveva portata in grembo, allattata e curata nei primi anni e aveva dovuto abbandonarla per servire altri padroni.
-
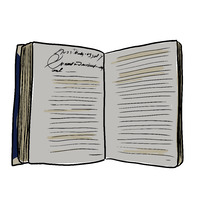 Una conversione in punto di morte
Una conversione in punto di morte Il rifiuto del battesimo da parte di uno schiavo veniva visto come un’insensatezza e opera del demonio. In questo senso si esprime una fonte gesuitica che riferisce la conversione di un turco avvenuta a Sassari nel 1601. Il turco in questione era stato condannato a morte e non voleva in nessun modo farsi battezzare. Quando vedeva uno dei gesuiti entrare nella sua cella, abbassava gli occhi a terra per non ascoltare quanto gli veniva detto, desiderando, come diceva, morire nella setta di Maometto per salvarsi. Decise di impiccarsi nella cella, ma accorsero i custodi e lo soccorsero, slegando il cappio. Il turco tornò in sé e si arrese a Dio. Fece chiamare i padri, dicendo che non c’era altra legge al di fuori di quella dei cristiani e voleva essere uno di loro. Fu battezzato. Per tre giorni perseverò nella sua saggia scelta con molta devozione e pietà. I padri non lo lasciarono fino alla esecuzione capitale, dopo la quale fu sepolto come un cristiano.
-
Da schiavo a figlio
Il 2 febrbaio 1605 Michele Calabres e Teodora Bacallar, coniugi, liberano uno schiavo bambino che avevano come schiavo dopo averlo battezzato nella Cattedrale di Cagliari col nome di Blay Antiogo. I due prendono il bambino come “figlio di anima” e come tale lo terranno e lo faranno considerare da tutti.
-
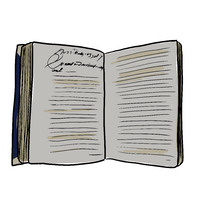 Risarcimenti ai padroni per gli schiavi attallati convocati per le regie galere
Risarcimenti ai padroni per gli schiavi attallati convocati per le regie galere Nella lista del 1564 per l’arruolamento degli schiavi di Sardegna nelle regie galere di Spagna, gli schiavi sottoposti a taglia vengono considerati schiavi a tutti gli effetti e giudicati idonei al servizio, differentemente dagli schiavi già definitivamente affrancati. Come risarcimento, al padrone viene corrisposta la somma di denaro che al captivo restava ancora da pagare in quel momento e lo sfortunato tornava irrimediabilmente in condizione di schiavo, finendo al remo. Nell’Archivio Generale di Simancas sono riportati alcuni ordini di pagamento per gli schiavi attallati: Abdalà di Donato Satta, Amet di Sebastiano Dessì, Amet di Antonio Silvestre, Marjan – nero – di Giovanni Sisto. Il contenuto dell’ultimo è il seguente: si pagheranno a Giovanni Sisto 55 scudi e 4 reali equivalenti a 144 lire di cui il detto Sisto è creditore da Marjan, suo schiavo, come completamento dei 60 scudi totali previsti dall’atto di taglia redatto davanti al notaio Melchiorre de Silvia il 24 gennaio 1562. La taglia di Marjan doveva essere pagata con uno scudo al mese.
-
Schiavi per le galere regie
Nel 1564 il comandante in capo della flotta spagnola, don Garcia de Toledo, aveva necessità di rafforzare le ciurme dell’armata navale in vista del temuto scontro con i turco-barbareschi. Per questo inviò in Sardegna il capitano Domingo Ochoa per far sì che, in concerto col viceré di Sardegna, comprasse schiavi residenti nell’isola per inviarli al servizio delle galere regie. Il re aveva infatti inviato due lettere ordinando che venissero acquistati 300 schiavi. Per ottemperare alla prescrizione regia la procurazione reale predispose bandi pubblici a Cagliari e nelle altre città regie affinché chi possedeva schiavi lo notificasse al viceré e agli ufficiali dediti alla faccenda. Solo per Cagliari è documentata l’esecuzione dell’ordine regio. Nell’Archivio Generale di Simancas esiste infatti l’elenco degli schiavi presenti a Cagliari nel mede di aprile di quel 1564. Il viceré rispose alle lettere del re facendo notare che le previsioni di acquisto di 300 schiavi erano basate su informazioni errate su un gran numero di schiavi presenti in Sardegna. Il provvedimento regio ordinava che tutti, schiavi, liberti bianchi, neri, mori, sposati o celibi, battezzati al cristianesimo o musulmani, attagliati o no venissero indicati nella comunicazione del viceré. Nell’elenco sono presenti 126 individui di cui 86 già affrancati. Tra loro quelli ritenuti idonei al lavoro di galera furono 17, acquistati per prezzi variabili in base alla condizione e all’età di ciascuno: da 45 a 75 scudi, in linea coi prezzi generali del mercato cagliaritano. I fattori di esclusione erano l’essere affrancato, essere troppo vecchio o troppo giovane, essere negre (anche se uno schiavo nero fu comunque preso), e infine – mai esplicitato ma intuibile – l’essere schiavi delle più alte autorità del regno. Gli schiavi sottoposti a taglia rientravano nei casi di idoneità: al padrone viene versata la cifra rimanente della taglia dal fisco regio, così che egli sia del tutto risarcito ma lo schiavo perde quanto versato fino a quel momento e perde ogni possibilità di essere liberato, finendo al remo.
Negli stessi mesi vennero catturati nuovi schiavi da mandare alle regie galere come richiesto dal re Filippo II. Nel mese di aprile 1564 venne catturato uno schiavo sulle spiagge di Iglesias e consegnato al re, nel febbraio dell’anno successivo altri schiavi finirono sulle coste sarde per il naufragio di una galeotta e furono anch’essi mandati alle regie galere. Come avvenne per il grande acquisto precedente però alcuni furono lasciati a Cagliari andando ad aumentare in numero degli schiavi lì residenti.
-
Prese del patrone Virgilio Maltrachea
Le modalità delle catture dei corsari cristiani sono registrate nell'interrogatorio di un moro di Tunisi catturato dal comandante (patron) napoletano Virgilio Maltrachea e portato a Cagliari nel settembre 1597. Dopo aver giurato al suo Dio Allah, rispose alle domande postegli tramite un interprete. Disse che era stato preso un porto della Barberia da un raìs vecchio e basso di statura chiamato Virgilio. Egli si trovava in quel posto con un barcone da trasporto carico di orzo e assieme a lui viaggiavano nove uomini e una donna con una piccolina. Dopo questa presa il Maltrachea portò a Cagliari altre 23 persone.
-
Tornare in libertà: acquisti e scambi
Talvolta, il riscatto delle persone avveniva subito dopo la cattura, nelle ore o nelle giornate successive. In castigliano tale tipo di riscatto veniva chiamato alafia. I corsari turco-barbareschi si fermavano vicino alla costa o nell'entroterra presso il litorale e iniziavano le trattative per il riscatto dietro versamento di denaro o tramite scambi con schiavi moros e turchs caduti prigionieri o detenuti nei territori attaccati. In Sardegna tale prassi è poco documentata, ma sicuramente era messa in atto. In un breve atto notarile, redatto il 3 giugno 1553, un abitante del paese di Villanovaforru si riconosce debitore nei confronti di un cagliaritano dal quale aveva acquistato uno schiavo turch per scambiarlo con qualche persona del posto catturata, visto che c'era l'opportunità di farlo per la presenza di "certes futes que fon rescat”.
-
Atti di morte di schiavi nel 1583
Il 21 febbraio 1583 nei Quinque Libri della diocesi di Cagliari, parrocchia di Santa Cecilia di Castello, si attesta che muore un figlio di una schiava; il 23 maggio muore un negro del conte di Villasor; l’8 giugno muore uno schiavo di Jaume Roca; il 13 dello stesso mese uno schiavo della signora Positana; il 1 agosto un negro di don Renyer.
-
Vendite di schiavi tra il 1502 e il 1598
Nel XVI secolo tra il 1502 e il 1598 vengono venduti in Sardegna approssimativamente 500 schiavi. Gli acquirenti sono farmacisti, nobili come conti, marchesi, alti prelati, ufficiali del regno come gli alcaidi, maestri razionali, notai, viceré, reggenti la real cancelleria, giudici della reale udienza, mercanti. I prezzi possono variare da 12-20 scudi per gli schiavi in condizioni fisiche più precarie o di età più avanzata ai 130 scudi per uno schiavo nel pieno delle forze. Si nota anche un andamento crescente dei prezzi dall’inizio alla fine del secolo. Alcune medie: nel 1503 la media per sei schiavi fu di 22,5 ducati; nel 1545 per 13 schiavi fu di 27,9 ducati; nel 1588 per 8 individui la media fu di 86,13 ducati.
-
 Crida sui mori e i turchi
Crida sui mori e i turchi l consigliere e governatore del capo di Cagliari e Gallura Miquel de Aragall fa sapere a nome del re che in quei tempi i turchi e mori infedeli e nemici della santa fede cattolica hanno aumentato la loro temerarietà e audacia e vengono nel regno ogni giorno con le loro armate e imbarcazioni, e prendono e fanno schiavi i cristiani oltre a distruggere e rubare quello che possono. Ordina dunque che si voglia provvedere all’indennità del regno e che i mori e turchi siano perseguiti ed estirpati, previa deliberazione degli ufficiali del regio consiglio al riguardo effettuata con l'intervento e la conoscenza del magnifico reggente la procurazione reale a supplica dei magnifici consiglieri della città di Cagliari. Per il tenore della presente crida pubblica, notifica a tutti quelli che vanno per mare o per terra che dovranno perseguire e cacciare dal regno i mori e i turchi e potranno fare di loro e delle loro cose quello che vorranno, tenendo per sé tutto eccetto la decima parte di tutto quello che prenderanno, che dovranno pagare al re tramite il reggente della procurazione reale.
-
Antonio Adinus ricoverato per ferite
Antonio Adinus, figlio del quondam Mustafa,di 25 anni, di Algeri. Schiavo fatto cristiano. Viene con ferite e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Muore il 28 del mese.
-
Mametillo ricoverato per una ferita alla coscia
Viene ricoverato Mametillo figlio del quondam Mamet, di Biserta, di anni 25. Viene per una ferita a una coscia e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Muore il 22 settembre.
-
Gioccu Felipo ricoverato per febbre
Si ricovera Gioccu Felipo, schiavo fatto christiano, figlio di Majamet, di 25 anni circa, di Tunisi. Viene con calentura e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano l’8 settembre
-
Amet ricoverato per un tumore
Si ricovera Amet figlio di Amet, di Algeri, di anni 23. Schivo di Sua Eccellenza. Viene con un tumore e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 9 giugno.
-
Zamar Benzatar ricoverato per febbre
Viene ricoverato Zamar Benzatar, figlio de quondam Zalà. di Scheg?, di anni 30. Schiavo di Giuseppe Carnizer. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 27.
-
Issa ricoverato per febbre
Si ricovera Issa figlio di Ameto, di Biserta, di anni 24. Schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 9 di dicembre.
-
Neg ricoverato per febbre
Si ricovera Neg figlio del quondam Casmo, di Tripoli, di anni 25. Schiavo di don Giovanni Battista Carnizer. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano l’8 di novembre.
Per le pessime condizioni di conservazione non è possibile leggere l'anno e il giorno di ammissione nell'ospedale.
-
Ametillo ricoverato per febbre
Si ricovera Ametillo figlio del quondam Moret, di Biserta, di anni 25. Schiavo del viceré. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 25
-
Casmo ricoverato per febbre
Si ricovera Casmo figlio di Ametillo di Biserta, di anni 17, schiavo di Sua Eccellenza. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 29.
-
Soliman ricoverato per febbre
Ricovero di Soliman figlio di Ameto di Gerba, di anni 19, schiavo di Sua Eccellenza. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano a 4 di ottobre.
-
Buasis ricoverato per febbre
Ricovero di Buasis, figlio di Daianir, di Gerba, anni 26, schiavo di Sua Eccellenza. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano l’11.
-
Aly ricoverato per febbre
Viene ricoverato Aly figlio di Ameto di Tunisi, di anni 21, schiavo di Sua Eccellenza. Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 21. Dopo pochi giorni, il 30 settembre torna all’ospedale nuovamente con la febbre, portando con sé ancora panni vecchi e nessun denaro. Parte sano a 4 di ottobre
-
Ametto ricoverato per febbre
Viene ricoverato Ametto figlio del quondamm Ali di Tetuan, 33 anni, schiavo di don Antonio Genoves.Viene con febbre e porta con sé panni vecchi e 63 soldi. Parte sano il 21.
-
Alì ricoverato per una piaga
Ricoverato Alì figlio di Ametiglio di Tunisi, di anni 25 schiavo di Sua Eccellenza. Viene con una piaga e porta con sé panni vecchi e nessun denaro.. Parte sano il 29.
-
Ametiglio ricoverato per dolori
Viene ricoverato Ametiglio figlio del quondam Sein di Algeri, di 30 anni, schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Venne con dolori e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano a 30 di maggio
-
Amet ricoverato con dolori
Ricovero di Amet di Algeri, moro di Sua Eccellenza il viceré, giocolatero, di anni 30. Viene con dolori e porta di contanti scudi 13 e cinque doppie di Spagna. Porta panni buoni e parte sano il 22.
-
Ametto ricoverato per febbre
Viene ricoverato Ametto di Tunisi di anni 38 schiavo che deve darsi a don Francesco Brunengo, entra con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano l’11 novembre.
-
Abrahim ricoverato per febbre
Si ricovera Abrahim turco figlio del quondam Ali di Costantinopoli di anni 25, schiavo della fabbrica del Duomo. Entra con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro.. Parte sano il 30 del mese.
-
Dagali ricoverato per rogna
Viene ricoverato Dagali, figlio di Ali di Tetuan, anni 28, schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Entra con rogna e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 9 luglio di detto anno
-
Alì ricoverato per febbre
Viene ricoverato Ali, figlio di Xerif di Tetuan, 21 anni, schiavo di Sua Eccellenza il viceré. Entra con febbre e porta con sé panni vecchi e nessun denaro. Parte sano il 6 luglio di detto anno.
-
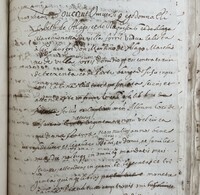 Liberazione di Amet Bofetil che ha servito e pagato secondo gli accordi
Liberazione di Amet Bofetil che ha servito e pagato secondo gli accordi Elisabetta Alagon y Requenses, marchesa di Villasor, vedova di don Martino de Alagon libera il suo schiavo bianco di nome Amet Bofetil, proveniente da Biserta, di 30 anni e di statura media. Afferma che lo schiavo da anni ha servito bene lei, la sua casa e la sua famiglia, fedelmente e legalmente, giorno e notte, obbedendo a tutti i suoi ordini. In considerazione delle 335 lire di denaro cagliaritano, prezzo dell’acquisto di Amet, che egli stesso le ha restituito e pagato, donna Elisabetta per propria volontà e per la remissione dei peccati libera Amet Bofetil e tutta la sua prole, liberandoli da qualunque dominio e imposizione. Potranno recarsi dovunque vorranno e dimorare ovunque vorranno, potranno testimoniare, contrattare e stipulare in giudizio come qualsiasi cittadino e persona libera. Potranno scegliere il padrone che vorranno senza impedimento. Amet riconosce al patrone Salvador Izzo, napoletano di Torre del Greco, che gli deve 170 pesses da 8 reali castigliani del valore di 340 lire cagliaritane per altrettante che il detto Izzo gli ha prestato graziosamente per pagare il prezzo del riscatto alla marchesa Alagon e Requesens. Amet promette di pagare il suo debito una volta che arriverà in Berberia.
-
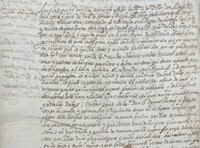 Provvedimenti per evitare che gli schiavi fuggano con barche
Provvedimenti per evitare che gli schiavi fuggano con barche Pochi mesi dopo la pubblicazione del pregone precedente, nella necessità di stabilire maggiore controllo, un altro avviso indica che i proprietari di barche non siano più gli unici responsabili delle fughe ma, insieme a loro, anche le corporazioni di cui facevano parte (San Pietro e Sant’Elmo) e, inoltre, che tutte le barche vengano iscritte a un registro: 200 ducati di multa e l’imputazione della colpa delle fughe sarebbero le pene comminate in caso di mancato rispetto della norma.
-
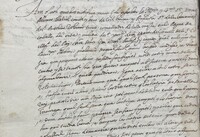 Pregone del viceré sulla fuga degli schiavi
Pregone del viceré sulla fuga degli schiavi Il viceré de Erill pubblica un grida urgente, immediatamente dopo che numerosi schiavi sono fuggiti nella notte del 6 giugno. Tale ordinanza ripropone gli obblighi di sorveglianza e custodia delle barche emessi precedentemente e inasprisce di gran lunga le pene per chi non denunci – pur essendone a conoscenza – notizie su schiavi fuggitivi: si prescrive la pena di morte.
-
 Pregone del viceré sugli schiavi
Pregone del viceré sugli schiavi Il viceré de Erill ordina tutti i moriscos affrancati che vivono e abitano nella città di Cagliari si presentino davanti a lui entro due giorni dalla pubblicazione del pregone, sia uomini che donne. Chi si trova nel resto del Regno di Sardegna ha otto giorni di tempo per fare lo stesso. La pena in caso di mancato rispetto sarà la galera perpetua per gli uomini e 200 frustate e la confisca dei beni per le donne. Impone ancora che nessuno abbia alcun tipo di rapporto con gli schiavi o li ospiti o li nutra; ai padroni di imbarcazioni ancora si intima di non imbarcarli. La punizione per qualunque abitante del Regno che trasgredisca sarà due anni nelle galere e per i comandanti e proprietari di barche la morte e la confisca dei beni. Non solo pene severe ma perfino incentivi alla denuncia: il viceré promette che, chiunque fornisca alle autorità informazioni su schiavi fuggitivi tenuti nascosti o imbarcati o qualunque notizia in merito a tentativi di protezione o favoreggiamento, otterrebbe un terzo dei beni dei trasgressori.
-
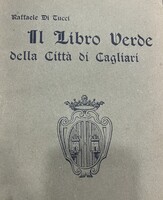 Limitazione alla concessione di salvacondotti agli schiavi mori
Limitazione alla concessione di salvacondotti agli schiavi mori Il re Filippo III scrive ai Consiglieri, al Presidente del Regno, al Reggente la Real Cancelleria e ai dottori della Reale Udienza del Regno di Sardegna. Afferma di comprendere i disagi e i danni (prigionie, rapine, disgrazie e morti) dovuti ai salvacondotti che finora sono stati concessi e vengono concessi agli schiavi mori e turchi che vengono riscattati in questo Regno e ritornano alle loro terre. Infatti essi, come ladri di case e persone, conoscono i territori, avvertono e accompagnano gli infedeli a sbarcare e compiere i delitti già menzionati a danno degli abitanti di questo Regno. Per questo saranno puniti severamente e saranno ritenuti responsabili.
-
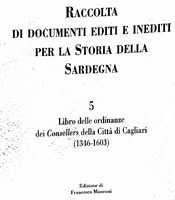 Crida del Veguer real Antioco Barbarà sul buon governo della città e sull'amministrazione della giustizia.
Crida del Veguer real Antioco Barbarà sul buon governo della città e sull'amministrazione della giustizia. Il veghiere reale Antiogo Barbarà informa che per volontà dei consiglieri di Cagliari sono state emesse le seguenti ordinanze che chiunque deve rispettare per provvedere al buon governo e amministrazione della giustizia e tranquillità della città e ovviare ai disordini, sinistri e pericoli che possono capitare.
Ordina che nessuno possa andare in giro di notte dopo il suono della campana senza luce. Chi sarà trovato dovrà passare tre giorni in prigione, e se sarà uno schiavo riceverà 50 frustate.
Ordina che gli schiavi, le schiave e i giovani in età da matrimonio di età inferiore o uguale a 15 anni non vengano accolti in nessuna taverna o casa né di notte né di giorno, sotto la pena di cinque lire.
Ordina che nessuno possa acquistare da schiavi o servi di età inferiore ai 15 anni nessuna merce, né possano tenere loro merce nelle proprie case né prendere ordini da quelli. La pena in caso di disobbedienza è di 25 lire.
Ordina che nessun proprietario di barche osi tenerle slegate e con gli arnesi da navigazioni e le armi all’interno, né di notte né di giorno. La pena in caso di contravvenzione dell’ordine sarà di 25 lire più il risarcimento ai legittimi proprietari del valore degli schiavi che con dette barche saranno fuggiti. Si fa eccezione per le barche grosse più di 120 quintali in su, le quali possono stare senza catena e non incorrere in nessuna pena.
Infine ordina che nessun moro affrancato, che sia sposato o celibe, entro 15 giorni dalla pubblicazione di queste ordinanze, possa risiedere in una casa dentro la città e il castello di Cagliari sotto pena di 10 lire e 100 frustate; inoltre non possono essere accolti in nessuna casa o taverna da nessuno sotto pena di 5 lire per ogni volta che l’ordine sarà contravvenuto.
-
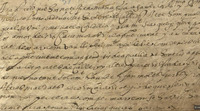 Sulla fuga degli schiavi
Sulla fuga degli schiavi L’Arcivescovo Lasso Sedeño con questa ordinanza riprende precedenti prescrizioni in merito agli schiavi e torna a proibire che essi girino di notte liberamente per Castello e per le appendici di Cagliari in quanto porebbero commettere furti e altri delitti o perfino fuggire. Dopo il suono della preghiera della notte gli schiavi di Castello dovevano rientrare nel Castello e quelli delle tre appendici non potevano lasciare la propria abitazione a eccezione di trovarsi in compagnia del padrone. La pena sarebbe di cento frustate per la prima trasgressione, 200 per la seconda ed essere mandati alla Galera nella squadra del re, perpetuamente, per la terza.
Per la stessa ragione si afferma che gli schiavi non possano andare in giro in gruppo ma al massimo in due, con eccezione di quando si recano alle fontane per compiere servizio al proprio padrone portandogli l’acqua. In caso di contravvenzione alla norma sarebbero puniti con 100 frustate e la condanna ai servizi per la costruzione di opere regie. Ancora l’ordinanza dell’arcivescovo sottolinea, nell’ottica di prevenire le fughe degli schiavi dal Regno, l’obbligo dei padroni di imbarcazioni di tenerle ben legate e custodite e senza armi o utensili da navigazione a bordo. La pena, in caso di mancato rispetto, sarebbe la confisca della barca e l’esilio perpetuo per i padroni delle barche e, per gli schiavi trovati a fuggire con le stesse, la condanna perpetua al remo nelle galere di Sua Maestà. Ancora viene proibito agli schiavi mori di portare con sé armi poiché, si dice, sono soliti affrontarsi in risse e aggredire altri schiavi o perfino cristiani. Si ripropone la norma già più volte emanata per la quale nessuno schiavo, musulmano o convertito, possa recarsi nelle taverne e nessun taverniere, dal canto suo, possa accoglierli: si vuole impedire che si ubriachino, omettendo i propri compiti o perpetrando atti delittuosi.
-
 Sul maltrattamento degli schiavi
Sul maltrattamento degli schiavi L’arcivescovo di Cagliari Alonso Lasso Sedeño, reggente della carica vicereale nel Regno di Sardegna, afferma che molti abitanti del Regno trattano molto male gli schiavi, con violenze fisiche e verbali. Sia gli schiavi musulmani che quelli convertiti al cristianesimo ne sono vittima. Ritiene che queste violenze siano la causa dell’allontanamento dei convertiti dalla religione cattolica e il mancato avvicinamento ad essa dei mori. Ordina, perciò, che nessuno osi più praticare nessun tipo di violenza e che solamente i padroni degli schiavi possano, personalmente e per giusta causa, punire i propri schiavi.
-
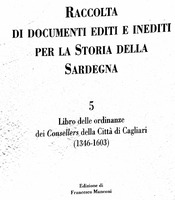 Crida del veghiere reale relativa all'osservanza di varie ordinanze
Crida del veghiere reale relativa all'osservanza di varie ordinanze Il veghiere reale di Cagliari Hieroni Vigili de Alagò annuncia, per volontà dei consiglieri di Cagliari, che sono state prescritte le seguenti ordinazioni per provvedere al buon governo e all'amministrazione della giustizia, alla tranquillità e al riposo degli abitanti della città e delle sue appendici e per ovviare ai disordini, ai sinistri pericoli e agli inconvenienti che potrebbero derivare. Tutti dovranno obbedire a quanto indicato.
Ordina che nessuno possa andare in giro di notte dopo il suono della campana senza luce. Chi sarà trovato dovrà passare tre giorni in prigione, e se sarà uno schiavo riceverà 50 frustate.
Ordina che gli schiavi, le schiave e i giovani in età da matrimonio di età inferiore o uguale a 15 anni non vengano accolti in nessuna taverna o casa né di notte né di giorno, sotto la pena di cinque lire.
Ordina che nessuno possa acquistare da schiavi o servi di età inferiore ai 15 anni nessuna merce, né possano tenere loro merce nelle proprie case né prendere ordini da quelli. La pena in caso di disobbedienza è di 25 lire.
Ordina che nessun proprietario di barche osi tenerle slegate e con gli arnesi da navigazioni e le armi all’interno, né di notte né di giorno. La pena in caso di contravvenzione dell’ordine sarà di 25 lire più il risarcimento del valore degli schiavi che non dette barche saranno fuggiti ai legittimi proprietari.
Infine ordina che nessun moro affrancato, che sia sposato o celibe, entro 15 giorni dalla pubblicazione di queste ordinanze, possa risiedere in una casa dentro la città e il castello di Cagliari sotto pena di 10 lire e 100 frustate. Infine stabilisce che i mori non possano accogliere nessuno in casa propria, sotto pena di 5 lire per ogni volta che l’ordine sarà contravvenuto.
-
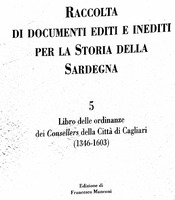 Crida del veghiere di Cagliari sull’igiene pubblica.
Crida del veghiere di Cagliari sull’igiene pubblica. Miquel Serra, Veguer reale della città e castello di Cagliari, emana le seguenti ordinazioni per volere dei consiglieri della città in merito all'igiene pubblica di Cagliari e delle sue appendici. Per evitare lo stato indecoroso della città e il diffondersi di malattie e morbi è ordinato a tutti di tenerla pulita da ogni immondizia e sporcizia. Nessuno dovrà più gettare rifiuti nelle strade, negli angoli e nelle piazze ma vengono predisposti luoghi appositi della città adibiti al conferimento degli stessi.
Il Veguer precisa anche l'ammontare delle pene stabilite per chi non rispetterà le prescrizioni e specifica che, se saranno schiavi a contravvenire alle norme, la pena per loro non sarà pecuniaria ma consisterà in cento frustate.
-
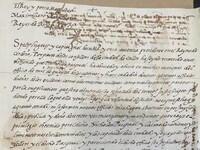 Sugli abusi perpetrati dal Mestre de Guayta Nicolau Pasqual
Sugli abusi perpetrati dal Mestre de Guayta Nicolau Pasqual Massimiliano di Boemia scrive, in nome del re Carlo V, al luogotenente e capitano generale del Regno da parte dei Consiglieri della città di Cagliari in merito alla condotta del Mestre de Guayta Nicolau Pasqual.
Egli, in base a quanto riferito, abusa e ha abusato in molte maniere del proprio ufficio di Mestre de Guayta degli schiavi. Ogni giorno fa diversi torti sia ai padroni di schiavi e agli schiavi stessi. Pertanto il re ordina che si verifichi il privilegio ottenuto da Pasqual e le moderazioni e le limitazioni che esso contiene. Il suddetto ufficio, inoltre, pare essere infruttuoso e dannoso per il Regno. Col previo consenso del Reggente la Reale Cancelleria, chiamate e ascoltate le parti, prega di stabilire quello che si riterrà opportuno per il migliore servizio al Re e per la buona amministrazione della giustizia e del Regno.
-
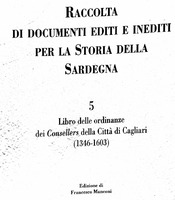 Crida generale del veghiere di Cagliari: provvedimenti sugli schiavi.
Crida generale del veghiere di Cagliari: provvedimenti sugli schiavi. Il veguer reale, per volontà dei consiglieri di Cagliari nella volontà di preservare la sicurezza della città, visti i molti pericoli che vi si possono incontrare, ordina quanto segue:
nessuno si trovi in giro per la città senza luce dopo il suono della campana, sotto pena di tre giorni di prigione. Se sarà uno schiavo a contravvenire, gli verranno date 50 frustate.
Ancora ordina che gli schiavi non siano accolti in nessuna taverna né casa, né di notte é di giorno sotto pena di 5 lire.
Nessuno possa comprare da schiavi alcuna mercanzia, né nascondere mercanzie di schiavi nella propria casa, né prendere ordini dagli schiavi. Pena 25 lire.
Infine si ordina che chiunque possieda barche debba custodirle attentamente, mai lasciarle slegate o con a bordo gli strumenti per la navigazione. La pena è di 25 lire, aggiunte all’obbligo di ripagare i padroni degli schiavi che avranno usato quelle imbarcazioni per fuggire del valore degli schiavi.
-
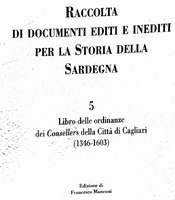 Ordinanza sul Mestre de Guayta degli schiavi
Ordinanza sul Mestre de Guayta degli schiavi Per volontà dei consiglieri e in virtù del privilegio concesso loro di ordinare in materia civile e penale sopra gli schiavi mori, turchi e cristiani che si trovano a Cagliari e nelle sue appendici, viene costituito l'ufficio di Mestre de Guaita, guardiano e custode degli schiavi musulmani e non, per evitare i molti danni che di solito vengono arrecati.
Il Mestre de Guayta dovrà controllare gli schiavi sia di notte che di giorno, mentre sono riuniti o giocano, e può confiscare il denaro con cui giocano e punirli con 50 frustate nella cella della dogana.
Nessuno schiavo moro, né turco o cristiano possa recarsi di notte dopo le nove di sera in giro per Cagliari, se non mandati dai propri padroni, o se saranno trovati dal Mestre de Guayta li dovrà prendere e l’indomani fargli dare 50 frustate.
Nessun locandiere o locandiere dia cibo o bevande nell'osteria a schiavi mori, turchi o cristiani, sotto pena di quaranta soldi. E agli schiavi che si troveranno in dette taverne si daranno cinquanta frustate. Della pena 10 soldi andranno all'ospedale e il resto al detto Mestre de Guayta.
Tutti gli schiavi mori, turchi o cristiani devono obbedire al Mestre de Guayta sotto la pena di 100 frustate.
Se qualche schiavo fuggirà dai suoi padroni, il Mestre de Guayta dovrà cercarlo e prendere le dovute misure per catturarlo e dovrà avvisare le guardie dei capi di Sant’Elia, Pula e Carbonara, raggruppare le barche sia dal mare che dallo stagno, e avvisare Uta, Assemini e Quartu, e restituirli ai loro proprietari. Le spese saranno a carico del suddetto Mestre de Guayta, che se le avrà fatte non sarà obbligato a fare nient'altro.
I consiglieri ordinano ancora che qualsiasi schiavo sia trovato a rubare, perderà la taglia se ha rubato al suo padrone. Se non sarà attallato sarà punito secondo la sua colpa.
Inoltre, se il Mestre de Guayta troverà al porto di Cagliari barche che non siano legate con la catena o chiave o se troverà remi, timoni, vele e materiale da navigazione, i padroni delle barche dovranno pagargli ogni volta cinque lire.
Ancora si ordina che ogni padrone di schiavo debba versare per il compenso che spetta all'ufficiale 20 soldi in moneta cagliaritana per ciascuno schiavo che possiede. Il re precisa che pagheranno solo quelli che vorranno pagare, e altrimenti paghino gli schiavi.
Ordinano che il Mestre de Guayta venga eletto dal viceré e debba giurare di osservare queste ordinanze, di girare per Cagliari ogni notte e giorno facendo la perlustrazione e portando con sé l’insegna del suo titolo.
Il viceré elegge Nicolau Pasqual come Mestre de Guayta degli schiavi.
-
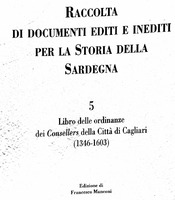 Grida del Mostazzaffo
Grida del Mostazzaffo Si ordina che, da ora in avanti, chiunque sia stato schiavo o sia schiavo non possa vendere né vino, né olio e né altre cose da mangiare nella sua casa o bottega di Cagliari e nelle sue appendici. La pena è di 25 lire. Si fa eccezione per coloro che avranno una moglie e figli: costoro sono esenti da questo capitolo.
-
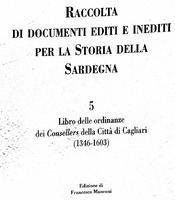 Ordinanza sugli schiavi mori e turchi
Ordinanza sugli schiavi mori e turchi Il Veghiere di Cagliari Francesch Decena informa tutti delle ordinazioni sui mori e turchi fatte dai consiglieri e probi uomini di Cagliari Arnau Vicent Roca, Pau Comelles, Joan Seguarra, Sabestia del Seu e Pere Desì, e i probiviri Joan Nicolau Aymerich, Miquel Benaprés, Nicolau Marquet, Nicolau Torrella, Antoni Sabrià e altri.
In primo luogo si comanda e si ordina che chiunque, di qualsiasi rango o condizione, che abbia o avrà uno o più schiavi mori o turchi, metta una catena del peso di venti libbre di ferro alla gamba di quello o quelli.
Successivamente ordinano che chiunque voglia avere o avrà uno o più schiavi mori o turchi, dovrà tenerli ben custoditi e chiusi a chiave dal suono della campana in avanti perché non se ne vadano in giro e per evitare mali e scandali che potrebbero verificarsi. Se gli schiavi verranno trovati in giro per la città fuori orario, subiranno cento frustate e i loro padroni dovranno pagare ogni volta 10 lire.
Inoltre ordinano che gli schiavi cristiani e gli schiavi neri, suonata la campana, tornino a casa e non si facciano trovare in giro, sotto pena di 10 lire e di 5 giorni in prigione.
I consiglieri ordinano inoltre che qualunque persona che da ora in avanti comprerà schiavi mori o turchi dovrà, entro tre giorni, mettergli la catena al piede come sopra indicato.
Comandano ancora che venga nominato Antoni Xarra come Mestre de Guayta della città, col compito di sorvegliare gli schiavi e prevenire comportamenti scorretti da parte loro. Gli schiavi dovranno obbedire all'ufficiale e se non lo faranno la pena sarà di 100 frustate per loro e dieci lire per i padroni. Inoltre il Mestre de Guayta sarà autorizzato a confiscare il denaro, fino a tre soldi, degli schiavi che sorprenderà a giocare. Antoni Xarra è anche corridore pubblico della città.
Poiché è necessario che il detto Antoni Xarra sia soddisfatto e debitamente pagato per il suo lavoro, si comanda che ogni proprietario di schiavi mori e turchi paghi in due rate ogni anno per ogni schiavo turco o moro che possiede 12 soldi, per ogni cristiano 10 soldi e per ogni nero 5 soldi e per i bambini 3 soldi.
Inoltre, i consiglieri ordinano che se qualcuno degli schiavi mori o turchi sarà assente o fuggirà, i padroni di tali schiavi lo dovranno denunciare ad Antoni Xarra, il quale, a sue spese, dovrà occuparsi di ritrovarli e riconsegnarli ai proprietari.
Ancora, ordinano che le barche siano tenute incatenate e ben chiuse a chiave dai loro proprietari che altrimenti saranno passibili di 10 lire di multa per ogni barca trovata sciolta.
Inoltre i detti magnifici consiglieri ordinano che nessun proprietario di barche da commercio o da pesca o qualunque altra persona di qualsiasi condizione osi lasciare le vele, i remi, il timone o qualsiasi utensile senza due uomini armati, sotto la pena di lire dieci e perdita della barca.
-
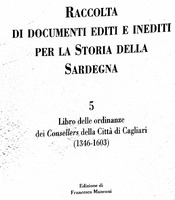 Crida del viceré Fernando de Rebolledo per spronare il Regno a catturare e cacciare i mori
Crida del viceré Fernando de Rebolledo per spronare il Regno a catturare e cacciare i mori Don Ferrando Girón de Rebolledo, viceré di Sardegna, emana questo avviso a causa del fatto che turchi, mori e infedeli, nemici della santa fede cattolica, si recano nel Regno di Sardegna su imbarcazioni, sia in estate che in inverno, per riparare nei porti e insenature e uscire sulla terraferma in flotte armate prendendo e catturando la popolazione, predando e distruggendo tutto ciò che possono, facendo male e danno con crudeltà.
Il viceré con il presente appello incoraggia gli abitanti del Regno a sollevarsi contro gli infedeli, informa tutti gli individui del Regno che, chiunque vada per mare o per terra a inseguire, espellere e cacciare dal Regno i mori, e chiunque li catturi otterrà i beni del catturato. Del valore di questi dovrà pagare al re solo una parte e il resto sarà legittimamente suo. Potrà fare quello che vorrà delle persone catturate come se fossero cose proprie guadagnate “de bona guerra”, purché non vada contro i diritti e gli interessi del re.
-
 Crida dei Veghieri di Cagliari Scarper, de Monpalau e Torrella dal 1488 al 1491: ordini sopra gli schiavi.
Crida dei Veghieri di Cagliari Scarper, de Monpalau e Torrella dal 1488 al 1491: ordini sopra gli schiavi. I Veghieri di Cagliari ordinano che ogni schiavo e schiava che verrà trovato di notte dopo il suono della campana riceva il castigo di 26 giorni di prigione senza luce oppure 50 frustate alla pietra della vergogna. Inoltre nessun locandiere o locandiera deve osare accoglierli né di notte né di giorno, sotto pena di tre lire.
Ordinano ancora che nessuno acquisti alcun bene dagli schiavi e che nessuno li ospiti nella propria casa o in nessun altro modo, a pena di pagare 26 lire, di perdere la roba e di restituire ciò che ha ricevuto o comprato.
Infine ordinano che nessuno, né pescatore né chiunque possieda barche, tenga durante la notte i remi e le vele dentro la sua imbarcazione, sotto la pena di 25 lire. Le imbarcazioni devono essere tenute incatenate. A chi non obbedirà sarà comminata una multa dello stesso ammontare. Se uno schiavo dovesse fuggire per aver trovato barche non legate, i proprietari delle stesse imbarcazioni saranno tenuti a pagare la pena pecuniaria indicata sopra e a pagare il valore dello schiavo al padrone di questo.
-
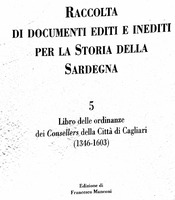 Ordinanza sull’elezione dei consiglieri di Cagliari
Ordinanza sull’elezione dei consiglieri di Cagliari Nell’ordinanza sull’elezione dei consiglieri della città si precisa che nessun ebreo o moro possa avere incarichi o benefici nella città di Cagliari e possa essere consigliere o giurato della stessa.
-
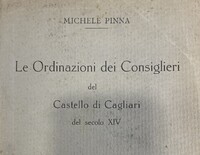 Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari dal 1422 al 1603: provvedimenti sopra gli schiavi
Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari dal 1422 al 1603: provvedimenti sopra gli schiavi Tra le numerose ordinanze dei Consiglieri si leggono le seguenti in merito agli schiavi:
ogni persona nel Castello che ha o d'ora in avanti avrà schiavi saraceni, tartari o turchi, siano essi sottoposti a taglia o no, dovrà chiuderli a chiave in casa entro il suono della campana della sera, cosicché non possano uscire senza il permesso del padrone. Ogni volta che, suonata campana, gli schiavi verranno trovati senza catena o senza guardiano, riceveranno 50 frustate e il loro padrone pagherà 5 soldi. In questa disposizione non sono compresi gli schiavi posseduti per servizio personale;
nessuno può ricevere mercanzie o denaro dagli schiavi, portati o dati in pegno, palesemente o segretamente. E se le cose rubate saranno del valore di 5 lire in giù, si pagheranno 10 lire di pena, invece se sarà più di 5 lire paghi 25 lire;
chiunque sia autore od organizzatore di evasioni, per terra o per mare, se sarà cristiano sarà appeso per il collo affinché muoia, se sarà schiavo o ebreo sarà trascinato per terra affinché muoia. E se uno schiavo che per detta ragione verrà trascinato, sarà saraceno, si risarcirà il suo padrone con uno schiavo scelto tra tutti gli altri schiavi saracini; e se sarà schiavo greco, battezzato, o di altra nazione, il padrone verrà risarcito da parte di tutti gli altri schiavi del prezzo che gli era costato;
ogni capitano di imbarcazione deve tirare a terra e rimuovere i remi, le vele e il timone appena avrà toccato il porto. E i remi, vele e timoni devono essere riposti in luoghi sicuri affinché che i mori o gli schiavi non abbiano possibilità di utilizzarli per scappare. Se faranno diversamente incorreranno nella multa di due lire per ogni volta nel tribunale Veghiere di Cagliari. E se, per caso, uno o più schiavi scapperanno con una barca nella quale sono stati lasciati gli attrezzi, il padrone della barca dovrà pagare ai padroni il prezzo degli schiavi oltre che i danni e le spese che dovranno affrontare, oltre a incorrere nella pena prevista;
ogni uomo che sarà trovato in congiunzione carnale – e il fatto sarà provato in forma legittima – con schiava, balia o serva del padrone, sarà impiccato e, allo stesso modo, ogni uomo che ingraviderà una schiava d’altri con cui non conviva, sia tenuto a pagare il prezzo della detta schiava al padrone della medesima se per caso la schiava abortisca il bambino o esso muoia dopo la nascita. Se colui che compie il misfatto è uno schiavo, si stabilisce che esso venga diviso in parti uguali tra il padrone della schiava morta e del proprio padrone. E qualora sorga dubbio da chi sia stata ingravidata la schiava, si dovrà credere alla sua parola e al suo giuramento. Il padrone della schiava sia tenuto a rilasciare il bambino avuto dalla schiava con beneficio di libertà e franchigia per 10 lire di moneta corrente. Se però, entro tre giorni dalla sua nascita, il padre del bambino non lo avrà riscattato, il padrone della schiava potrà tenerlo per sé ed averne il prezzo che potrà ricavarne.
-
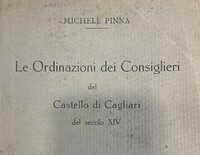 Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del 1346-1347: provvedimenti sopra gli schiavi
Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del 1346-1347: provvedimenti sopra gli schiavi Tra le ordinanze per la città di Cagliari si rilevano quelle in merito agli schiavi: che nessuno schiavo saracino che faccia settimana (turno di servizio settimanale) non possa andare sprovvisto di ferri nelle gambe, che pesino sei libbre, né passare nel Castello senza guardia dopo il suono della campana, ogni sera al vespro. E se si contravverrà a queste cose il padrone del detto schiavo pagherà la pena di 20 soldi per ogni contravvenzione della norma; che alcuna persona non osi trattare né dar mano a che alcuno schiavo saracino o greco o battezzato o schiava fugga per mare o per terra. E chi contravverrà, se è cristiano sarà impiccato in guisa che muoia e se sarà saracino, battezzato o greco, sarà trascinato per terra in guisa che muoia. E ciò che quello schiavo sarà costato, verrà risarcito e pagato al suo padrone da tutti gli altri schiavi del detto Castello e dai loro padroni; che nessuna persona osi né presuma comprare roba da alcuno schiavo o schiava, né a quello schiavo o schiava concedere prestiti di alcun tipo. E chi contravverrà pagherà ogni volta 100 soldi e perderà quel che avrà prestato e la roba che avrà comprato; che nessuna persona cristiana, ebrea o di altra religione presuma fare dei prestiti a schiavi o schiave altrui. Chi contravverrà dovrà pagare 20 soldi e perderà ciò che ha prestato.
-
 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Miquel Mitzavila
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Miquel Mitzavila Il patrone Miquel Mitzavila, maiorchino, afferma di aver venduto e consegnato al pubblico incanto gli schiavi che ha catturato nei giorni passati col suo brigantino nei mari di Sant’Antioco. Riconosce che il prezzo di questi schiavi gli è stato pagato in denaro contante.
Le vendite sono state le seguenti: a don Gaspar Pira per 265 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Ali; a don Juseph dela Mata per 282 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo canonico Augusti Murtas per 125 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di cui non è scritto il nome; a don Hieroni Fadda per 270 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Muda; a Marco Furnels per275 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Francesch Taxillo per 288 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo canonico Llorens Sampero per 302 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Bernardo Paulins per 280 lire e un reale di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo don Pere Folgiari per 300 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Cassam; a Antonio Caneu per 300 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Dionis Capai per 252 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Antonio Sauni per 295 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Matheo Benedeto per 275 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a don Gavi Capai per 287 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a padre frate Joan Baptista Leande, vicario generale del convento della santissima trinità, per 256 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Gregori Odger per 175 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Adalla; a Melchior de Castro per 181 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a don Melchior Pirella per 250 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al magnifico don Silverio Bernardi, reggente la reale cancelleria, per 230 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Cassam; a don Pau de Castelvì procuratore reale e giudice del real patrimonio, per 500 lire di moneta di Cagliari, due schiavi di cui non è scritto il nome; al magnifico don Juseph dela Matta per 81 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet.
Testimoni sono il dottor Juan Baptista Masons e Pere Sanna, abitanti di Cagliari; Diego Carreli e Francesch Fadda abitanti di Cagliari; Juan Leoni e Andrea Paulis abitanti di Cagliari.
-
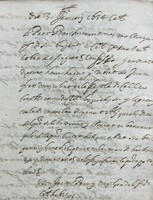 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Barthumeu Torres
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Barthumeu Torres Il patrone Barhumeu Torres Maiorchino, patrone del suo brigantino, trovandosi personalmente a Cagliari, afferma di aver venduto al pubblico incanto alcuni schiavi catturati col suo brigantino nei mari di Barbaria.
Riconosce di aver ricevuto da Juan Font, domiciliato nella Lapola di Cagliari, 100 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Ali; da Juan Lluis Fiorillo 230 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Amor; dal reverendo canonico Thomas Rachis, vicario generale, 200 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Amet.
Testimoni sono Jacinto Peiz e Diego Gandulfo abitanti di Cagliari
-
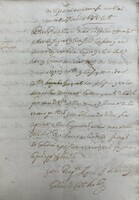 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Barthomeu Didià
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Barthomeu Didià Il patrone Barthumeu Didià afferma di aver venduto al pubblico incanto alcuni schiavi catturati nei mari di San Pietro.
Riconosce di aver ricevuto da Sisinni Geruna, mercante domiciliato a Cagliari, 327 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari prezzo e valore di uno schiavo di nome Cassam, che gli è stato venduto e consegnato nel pubblico incanto il 26 ottobre; da Grabriel Picarall di Stampace, 300 lire di moneta di Cagliari, prezzo di uno schiavo di nome Ali acquistato il 28 di ottobre; da Diego Alonço, negoziante, 255 lire li moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Cassam che gli ha venduto e consegnato nel pubblico incanto il 26 del mese; dal nobile don Gironi Torrella 280 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dall’illustrissimo e reverendissimo signor arcivescovo di Cagliari 278 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; don Gironi Soliman 294 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Mamet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Simoni Montanacho 300 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Augustì Boi 282 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Yaya che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre;dal nobile don Joan Dexart, dottore della reale udienza, 287 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Francesco Abella 308 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Anton de Robles 275 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Augustì Boi 276 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Baptista Murteo 350 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly di Algeri che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Gabriell Picanell 228 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joseph de Taragona 250 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Sisini Adseni 325 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Jeronimo Montañer, segretario di Sua Eccellenza, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi 29 ottobre; da Juan Battista Montanio 75 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet consegnato nel pubblico incanto nella giornata odierna; dal magnifico don Michel Bonfant, giudice di corte per Sua Maestà, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico; dal nobile don Paulo Castelvì, procuratore reale e giudice del real patrimonio, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico; dal magnifico don Antonio Caneles de Vega 250 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Ali che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico.
Testimoni sono Baptista Agus e Sisinni Gallus, abitanti di Cagliari.
-
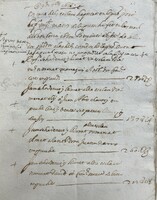 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Miquel Matos
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Miquel Matos Vendita al pubblico incanto degli schiavi che ha portato nel porto di Cagliari il patrone Miquel Matos, catturati nella presa che egli ha fatto nei mari di Barberia col suo brigantino per istanza di Salvador Puddo, altro dei corridori della città.
Della presa il patrone non paga diritto alla regia corte secondo una determinazione del regio patrimonio.
Primo si vende uno schiavo bianco di nome Marraquis a don Francesco Corts per 250 lire
Un altro schiavo di nome Ali a Juan Abros Chavari per 137 lire e 10 soldi
Un altro schiavo di nome Amet a donna Juana Narro per 260 lire
Un altro schiavo di nome David a Francesch Manca sabater per 202 lire e 15 soldi
Un altro schiavo di nome Asach a don Gaspar Pira, dottore della reale udienza, per 161 lire
Un altro schiavo di nome Ali a don Juan de Andrada per 120 lire.
Nelle sei carte successive si trovano i singoli atti di vendita degli schiavi e i nomi dei testimoni che sono gli stessi per tutte le vendite: Jacinto Peris e Diego Cau, abitanti di Cagliari.
-
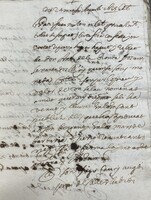 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Juan Maltes
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Juan Maltes Patrone Juan Maltes ha venduto al pubblico incanto alcuni schiavi che ha catturato nei mari di Barbaria col suo brigantino.
Afferma di aver ricevuto da don Anton de la Bronda 262 lire e 15 soldi di moneta cagliaritana per uno schiavo di nome Amet; da Salvator Fontana 162 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari prezzo di uno schiavo di nome Monsor; da Guillem Visent 175 lire e 10 soldi di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Saim; da Pere Vaquer 250 lire e 5 soldi di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Famut; dal reverendo Antoni Quensa, canonico della sede di Cagliari, 300 lire di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Ali.
Testimoni sono Diego Cau e Augusti Pixi, abitanti di Cagliari.
-
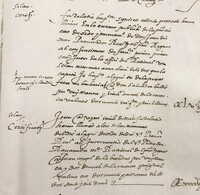 Incanto di schiavi svolto nell’agosto 1605
Incanto di schiavi svolto nell’agosto 1605 Il giorno 23 agosto del 1605 a Cagliari Baptista Squirro afferma di aver venduto nel pubblico incanto della città nei giorni precedenti, per ordine del procuratore reale Joan Deixar, e con autorizzazione di Francisco Pinna, primo coadiutore del maestro razionale, uno schiavo di nome Amet Charì dei due che il capitano Johannes Baptista Alaqui (Loqui) aveva preso in Berberia, a don Salvador Bellit per 255 lire.
Due giorni dopo, il 25 agosto, ancora afferma di aver venduto uno schiavo di cui non scrive il nome, sempre catturato dal detto Alagui, a Joan Angel dela Bronda per 296 lire, 2 soldi e 6 denari.
Sul prezzo degli schiavi venduti si deve prelevare il sei percento da consegnare al regio patrimonio.
Firma Miquel Angel Bonfant, notaio.
-
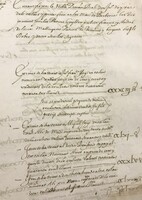 Incanto di schiavi svolto dal 9 al 18 febbraio 1605
Incanto di schiavi svolto dal 9 al 18 febbraio 1605 Incanto degli schiavi presi dai capitani Andres de Lorca, maiorchino, e Guillelm Prebost, francese, patroni di un brigantino e una tartana, nei mari di Berberia.
L’incanto si fa per ordine del procuratore real Joan Deixar e la prima giornata di vendite è il 15 febbraio.
Si vendono i seguenti schiavi: a Joan Francisco Jorgi uno schiavo di nome Xaban per 393 lire; a Miquel Jorji uno schiavo piccolo (xich) di nome Ali de Madi per 261 lire; al dottor Bonifacio Capay uno schiavo nominato Amet per 345 lire; don Antonio Brondo acquista un altro schiavo piccolo di nome Ali per 273 lire; il dottor Francesch Adceni compra una schiava di nome Axa per 153 lire; Phelipe Sylvestre acquista uno schiavo di nome Morat de Amet proveniente da Bona per 123 lire; uno schiavo il cui nome non è indicato è venduto a Dionis Bonfant per 189 lire e 5 soldi.
Il giorno successivo, 16 febbraio, si prosegue l’incanto e vengono venduti i seguenti schiavi: Amet al dottor Angelo Giagarachio per 348 lire; Say al capitano Andres de Lorca per lo stesso prezzo; uno schiavo di nome Sayeta a Julia’ Tola per 333 lire; a Pere Blancafort si vende uno schiavo di nome Amet per 339 lire e 5 soldi; al reverendo Antonio Marti uno schiavo di nome Sanson, ebreo, per 400 lire.
Due giorni dopo continua l’incanto, il 18 febbraio. Pau Orda acquista Ali per 180 lire; Gaspar Bonato acquista Abraim per 360 lire e 5 soldi; Andreu Ramassa compra Amet per 201 lire; Andreas de Lorca compra un altro schiavo di cui non viene specificato il nome per 90 lire e 5 soldi; Catalina Alemania compra uno schiavo di cui non viene indicato il nome per 161 lire e 5 soldi; Thomas Brondo acquista Ambarch per 360 lire e 5 soldi; Nicolao Cachuto compra uno schiavo senza indicazione del nome per 90 lire e 5 soldi; il dottor Soler compra un altro schiavo senza nome per 192 lire e 5 soldi; Antonio Molarja un altro schiavo senza nome per 303 lire; la viceregina acquista una schiava con un figlio per 200 lire.
Il 16 marzo dello stesso anno si legge la testimonianza di Antonio Trino, genovese, testimone che giura di dire tutta la verità. Egli riferisce che il viaggio di Prebost è avvenuto nel dicembre del 1604 e si è concluso con una presa di mori. Di questi mori uno, di nome Ambarch, è morto. Inoltre dell'ultima presa, fatta nel mese di febbraio, ne sono morti tre: uno che si chiamava Ali e degli altri due riferisce di non sapere il nome. Il testimone dice di essere a conoscenza di queste cose per aver visto morire quegli uomini in prima persona.
Lo stesso giorno viene interrogato un secondo testimone, Sebastianus Palermo di Consevera, che, come il precedente, giura di dire tutta la verità di sua conoscenza. Afferma che dei mori catturati nella presa fatta nel dicembre 1604 dal patrone Guillelm Prebost, ne morì uno che si chiamava Ambarch. Inoltre di quelli catturati nell'ultima presa fatta lo scorso febbraio ne ha visti morire tre, che tuttavia non ricorda. Afferma di avere questa informazione perché li ha visti morire lui stesso.
-
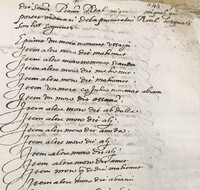 Inventario di schiavi del 3 e 4 febbraio 1605
Inventario di schiavi del 3 e 4 febbraio 1605 Inventario degli schiavi, del brigantino e delle robe che Guglielmo Prevost ha preso nei mari di Berberia. Inventario fatto per ordine del signor don Juan Deixer procuratore reale e giudice del reale patrimonio del regno.
Dopo aver inventariato il brigantino e gli oggetti il 3 febbraio, gli schiavi vengono inventariati il 4 febbraio alla presenza di Miquel Guasch portiere ordinario della procurazione reale. Gli schiavi catturati sono i seguenti: un moro di nome Ussayn; un altro moro di nome Mahomet; un altro nominato Scander; Mahomet; un altro di nome anch’esso Mahomet; un moro ebreo di nome Abram; Assanam; Abdalla; Ali; Amida; Ali; un altro Ali; Amet; Mahomet; Abraim; Ali; Mahomet; Ali; Ali; Ali; una mora di nome Aissa; Ali; un’altra Aissa; uno schiavetto di nome Mahomet; un ebreo detto Sanson; un altro moro detto Mahomet; Sayte; Charif; Mahomet; Belassem; un moro detto Raban; un altro chiamato Mahomet; un altro moro chiamato Abdalla; Ambarch; Sayt; Ansa Cego; Ambarch; un altro Ambarch; un moro di nome Moratanebi; Sabrit; Mostafa; Ambarch; Mahomet; un moro detto Abraim e un moro ebreo detto Abram; un moro di nome Ali.
Si fa nota che sono stati presi due schiavi per il diritto di joya per essere capitani di due diversi vascelli. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.
Firma il notaio Bonfant.
-
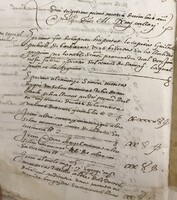 Incanto di schiavi del 31 dicembre 1604
Incanto di schiavi del 31 dicembre 1604 Incanto della presa fatta da Guglielmo Prevost in Berberia, verso Biserta. Incanto fatto per ordine del nobile signor procuratore reale don Nofre Fabra e Deixer.
Sono stati venduti: al canonico Simon Montanagio uno schiavo di nome Reba de Ambarch per 240 lire e un altro schiavo di nome Amar de Abdalla per 300 lire; a don Angel Manca Ali de Abraim per 300 lire; al magnifico egregio Monserrat Rossello, dottore della reale udienza, una moretta di nome Bengaida per 300 lire e una schiava di nome Salima de Ali per 357 lire e 5 soldi; a Nicholau Montelles uno schiavo di nome Califi per 171 lire; a Miguel Calabres Tamalla per 150 lire; al viceré uno schiavo di nome Ali per 275 lire, un altro di nome Ottoman per 263 lire; a Nicholau Ventallols una mora con due figli per 363 lire; al canonico Baccallar uno schiavo di nome Amet per 150 lire; al patrone Baptista Frances una schiava nominata Massauda per 30 lire; al marchese di Quirra uno schiavo di nome Sarch per 213 lire; al capitano Christofol Franco Rach per 150 lire.
-
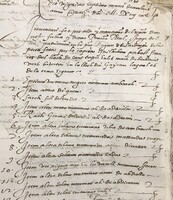 Inventario di schiavi del 27 dicembre 1604
Inventario di schiavi del 27 dicembre 1604 Inventario della presa fatta da Guglielmo Prevost, francese di Sant Torpè, nei mari di Berberia, a Biserta nel luogo di Gayram. L’inventario è fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio don Nofre Fabra y Deixer.
Sono inventariati: un moro negro di nome Ambarch; Amet di Quem; Sarch figlio di Amet di quem; noro di nome Ali di Adarailm; Raih, fratello di Ali de Adraim; Reba de Ambarch; schiava di nome Massauda; altra schiava di nome Atega di Nasar; schiava di nome Sada; un bambino piccolo nato sul vascello di nome Joan; un altro schiavo di nome Amar de Abdalla; un altro di nome Ali di Abdicarim; un altro di nome Calif; un altro schiavo di nome Tomalla di Naser; una mora di nome Taila; un’altra mora di nome Salima; un’altra di nome Mangaida; un altro schiavo di nome Ottoman de Ali.
Si specifica che di questi ne ha preso alcuni – non si indica quanti né quali – il viceré per il diritto di joya: questo diritto o privilegio consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.
Tutti i mori catturati vengono affidati al capitano Prevost. Testimoni sono Miguel Guasch, portiere ordinario della procurazione reale e Pere Pau Bonfant, mercante abitante in Cagliari.
-
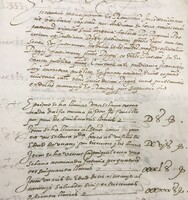 Incanto di schiavi del 21 e 22 ottobre 1604
Incanto di schiavi del 21 e 22 ottobre 1604 Incanto degli schiavi presi da Andream de Lorca, maiorchino, nei mari di Berberia con suo brigantino. Incanto fatto per ordine del procuratore reale del regno alla presenza del corridore pubblico Francesco Loi, giurato della curia della città di Cagliari.
Sono venduti i seguenti schiavi: Daifa, morena, a don Joan Carillo per 500 lire; al conte di Quirra una schiava di nome Barca con un figlio di un anno per 606 lire; a Miquel Rocca una schiava di nome Fatima per 450 lire; un bambino di sei o sette anni al canonico Salvador Sini per 330 lire.
Seconda giornata dell’incanto, 22 ottobre.
Si vende uno schiavo moreno a Francesco Volo per 408 lire; uno schiavo di nome Belgassan a Joan Antoni Marti per 462 lire; Odiguit a Miguel Angel Bonfant, notaio, per 347 lire; Belgassan a don Thomas Brondo per 447 lire; al dottor Salvador Carcassona uno schiavo di nome Ali per 501 lire; una schiava di nome Asseminidia con un figlio per 600 lire al dottor Joan Francesco Fundoni; un’altra di nome Amada a Pedro de Ravaneda per 522 lire; uno schiavo mulatto di nome Adalla ad Antoni de Tola per 339 lire insieme ad un altro schiavetto mulatto per 270 lire; una schiava di nome Axia con un figlio a donna Maria Cani per 511 lire; Monsor a Bernard Concas per 33 lire e 5 soldi; Amor a Pedro de Ravaneda per 500 lire e 5 soldi; Adalla a don Joan Naharro de Ruecas, reggente la real tesoreria, per 375 lire; a Francesco Terreros, tesoriere della crociata (thesorer dela crusada), uno schiavo di nome Soliman per 375 lire; al visconte di Sanluri Francesco di Castelvì uno schiavo di nome Abraim per 360 lire e 5 soldi; al maestro Pere Garau del Burgo una schiava di nome Embarca per 600 lire; al magnifico Francesco Pinna (primo coadiutore del razionale) uno schiavetto di nome Ali per 290 lire e 5 soldi; il magnifico Francesco Giagarachio compra un bambino di circa due anni per 172 lire; il patrone Andres de Lorca compra una schiava nera di nome Gemar per 253 lire e una schiava di nome Fatima per 500 lire; Miguel Angel Bonfant, notaio, compra una schiava detta Maria Negra per 282 lire e 5 soldi; il canonico Soler compra una schiava con una figlia di nome Tunes per 679 lire e 5 soldi; il canonico Spiga compra una schiava non identificata per 130 lire; il signor presidente del regno compra un’altra schiava per 500 lire.
-
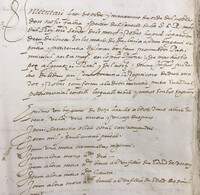 Inventario di schiavi del 18 ottobre 1604
Inventario di schiavi del 18 ottobre 1604 In data 18 ottobre 1604, nel luogo detto La Gruta del Rey a Cagliari, si stila l'inventario della presa fatta da Andreu de Lorca nei mari di Berberia col suo brigantino.
L’inventario è fatto per ordine del procuratore reale don Nofre Fabra y Deixer, in presenza di Joan Bonfant procuratore patrimoniale e dell’alcaide reale Matheo Lopez e del notaio e scrivano della procurazione reale. Di questa presa spetta alla regia corte il 2%.
L’inventario riporta: una mora di nome Nigenim, una mora di nome Dia, una mora di nome Barca e suo figlietto di un anno, una mora nominata Gauta, una di nome Tunes con sui figlietto di 5 anni, una nominata Aixa, una nominata Fatima, un’altra di nome Fatima con due figli di un anno e di tre anni, una nominata Barca, un’altra Fatima, una mora nominata Deifa, un’altra detta Maria Negra; una mora di nome Gemar; due bambini piccoli di 4 e 8 anni; altri due bambini piccoli di 5 e 7 anni; altri 4 bambini piccoli di 8, 2, 12 e 13 anni; uno schiavo di nome Soliman; un altro di nome Monsor; un altro di nome Oguidet; un altro di nome Ali, un altro di nome Barc; due schiavi chiamati entrambi Belgassan; un altro di nome Abraim. Di questi schiavi alcuni sono stai presi dal viceré per il diritto di joya, ma non viene specificato né quanti né quali. Tutti loro vengono affidati ad Andres de Lorca. Testimoni sono Miguel Vidal, mercante maiorchino e un marinaio abitante di Cagliari di cui non si legge il nome. Il totale è di 33 schiavi inventariati.
-
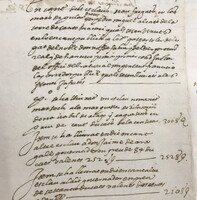 Incanto di schiavi del 25 maggio 1604
Incanto di schiavi del 25 maggio 1604 Incanto degli schiavi catturati nei mari di Pula da Pedro Miquel, alcaide della torre di San Macario, fatto per ordine di Gaspar Soler, delegato del procuratore reale Fabra y Deixer, e del primo coadiutore del maestro razionale, Francesco Pinna, e alla presenza del corridore pubblico Francesco Loi.
Sono state vendute le seguenti persone: uno schiavo di nome Marsoch alla marchesa di Villasor donna Isabel de Alagon e Requenses per 300 lire sarde; due schiavi a don Jaime de Aragall, governatore, uno per 252 lire sarde e l’altro per 210 lire sarde; a Pedro Virde Melone è stato venduto uno schiavo per 279 lire.
Si segnala che l’inventario che per prassi avrebbe preceduto questo incanto è assente nel registro BC 31.
-
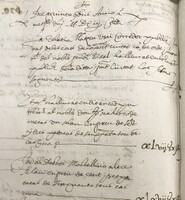 Incanto di schiavi del 5 novembre 1603
Incanto di schiavi del 5 novembre 1603 In data 5 novembre 1603 il pubblico corridore Matheo Usai stila la relazione del pubblico incanto fatto per ordine del procuratore reale nella città di Cagliari.
Sono stati venduti: al nobile don Johan Naharro de Ruecas uno schiavo per 262 lire sarde; un altro schiavo al dottor Mostellino per 267 lire sarde; a Joan Antonio Marti un altro schiavo per 270 lire sarde.
Il 4% del valore delle vendite spetta alla regia corte.
-
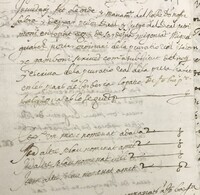 Inventario di schiavi del 17 agosto 1603
Inventario di schiavi del 17 agosto 1603 Inventario della presa realizzata dal patrone Joan Baptiste Lalgiu nei mari di Berberia, fatto per ordine del nobile procuratore reale e giudice del reale patrimonio alla presenza del portiere ordinario della reale procurazione e dello scrivano sostituto del notaio e scrivano della procurazione reale.
L’inventario registra un moro di nome Adalla, uno schiavo di nome Amet, un altro di nome Ali e un altro di nome Amet. Tutti gli schiavi sono affidati a Johan Baptista Loqui.
Testimoni: Damia de Ziruli di Sassari e Francesco Guasch, scrivano e abitante di Cagliari. Si fa nota che il viceré ha preso un moro per il diritto di joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.
-
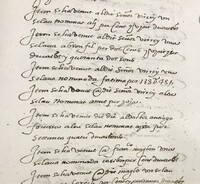 Incanto di schiavi del 2 aprile 1603
Incanto di schiavi del 2 aprile 1603 Incanto degli schiavi predetti, fatto per ordine del procuratore reale con il consenso del maestro razionale. Il 4% della vendita spetta alla regia corte.
Il viceré acquista 7 schiavi: Turquis e Embargua per 220 ducatoni, Ali per 120 ducatoni, una schiava con figlioletto per 227 ducatoni e 42 soldi, Fatima per 138 ducatoni e 48 soldi, Amet preso per il privilegio di joya.
Il dottor Antiogo Fortesa acquista Aisse per 74 ducatoni.
Francesco Maglon acquista Casiba per 100 ducatoni e Ferech per 140.
Il conte di Laconi acquista Malorica per 150 ducatoni, Amet e Salem per 240 ducatoni.
A Joan Pere Soler, reggente la real cancelleria, viene venduto Amet per 100 ducatoni.
All’arcivescovo di Cagliari vengono venduti Ali e Amet per 220 ducatoni ed Embarga e Amira per 240 ducatoni.
Il conte di Quirra acquista Monsor per 125 ducatoni e altri due schiavi per 250 ducatoni.
Joan Francesco Jorgi acquista Sale per 120 ducatoni.
Al dottor Salvador Carcassona viene venduta Enbarca per 140 ducatoni.
Johan Naharro de Ruecas, tesoriere, acquista una schiava con una figlia per 168 ducatoni e 40 soldi.
Al reverendo Cristofol Gessa, commissario del Santo Offizio, viene venduta una schiava di nome Aisa per 68 ducatoni. Don Nofre Fabra e Deixer, procuratore reale, compra una schiavetta di nome Embarco per 90 ducatoni.
Antonio de Tola compra Embargue, schiavo, per 80 ducatoni.
Joan Angel Concas compra una schiava con suo figlio per 133 ducatoni e 18 soldi.
Ramon Cetrilla compra Aisa per 70 ducatoni.
A Hieroni Pintor viene venduto uno schiavetto di nome Ali per 50 ducatoni.
Marianna Aragones e Montelles compra una mora e suo figlio per 117 ducatoni.
Balthasar Caseri compra uno schiavo di nome Marquie per 38 ducatoni.
Joseph Garous, siciliano, acquista uno schiavetto di due mesi per 11ducatoni e mezzo.
Francesco Giagarachio compra una mora e due figli per 150 ducatoni.
-
 Inventario di schiavi del 27 marzo 1603
Inventario di schiavi del 27 marzo 1603 Inventario, fatto per ordine del procuratore reale e del portiere ordinario della procurazione reale, alla presenza del sostituto del notaio e scrivano della stessa, della presa di mori fatta nei mari di Berberia dal patrone Guilhelm Prebost con la sua tartana.
Del valore della detta presa il 4% spetta alla regia corte.
I mori catturati sono: Turquis e Embarga di 12 e 8 anni, Amet, Casiba di 14 anni, Ferech di due anni, Malorica di 17anni, Amet e Salem di 14 e 13 anni, Amet di due anni, Ali e Amet di 8 e 5 anni, Embarga e Amira di 6 e 5 anni, Monsor di 18 anni, due schiavi di cui non indica i nomi di 14 e 8 anni, Sale di 14 anni, Embarca di 18 anni, una schiava e una schiavetta senza nome di 22 anni e 3 anni, Embarca di 5 anni, Embarque di 4 anni, una schiava e uno schiavetto senza nome di 45 e 15 anni madre e figlio, Aisse di 40 anni, Ali di 8 anni, una schiava e uno schiavetto madre e figlio di 30 anni e un mese, Marque di 45 anni, un moretto senza nome né età, una schiava e due figli di 27, 4 e 6 anni.
Il totale delle persone catturate è di 42. Tutti gli schiavi sono stato affidati al capitano Guilhelm Prebost.
Testimoni sono Gasper Rovira e Francesco Guasch, abitanti di Cagliari.
-
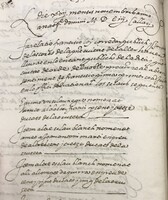 Incanto di schiavi del 17 novembre 1603
Incanto di schiavi del 17 novembre 1603 Il pubblico corridore Francisco Loi fa relazione in merito alla vendita nel pubblico incanto della città di Cagliari, per ordine del procuratore reale e col consenso del primo coadiutore del razionale, Francisco Pinna, i seguenti schiavi: uno schiavo negro di nome Amet al dottor Franci per 339 lire sarde; uno schiavo bianco di nome Amet per lo stesso prezzo a Joan Antoni Marti; uno schiavo bianco di nome Ali al conte di Quirra per 351,5 lire sarde.
Si aggiunge che il viceré ha preso uno schiavo per il diritto di joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.
-
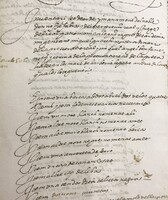 Inventario di schiavi del 4 novembre 1603
Inventario di schiavi del 4 novembre 1603 Inventario, fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio alla presenza del portiere ordinario della reale procurazione e del notaio e scrivano della stessa, della presa fatta da Andres de Lorca nei mari di Berberia.
Sono stati catturati i seguenti schiavi: un modo bianco di nome Alì, un moro bianco di nome Amet, un moro bianco di nome Barca, un moro negro di nome Amet. I mori sono stati affidati a Joan Baptista Loqui.
-
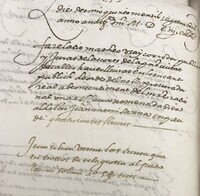 Incanto di schiavi del 15 settembre 1603
Incanto di schiavi del 15 settembre 1603 Il pubblico corridore e giurato della corte di Cagliari Matheo Usai fa relazione in merito alla vendita da lui effettuata al pubblico incanto per volontà del procuratore reale col consenso del maestro razionale una schiava di nome Sisa al dottor Joan Antoni Sanna per 400 lire sarde.
-
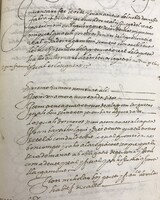 Inventario di schiavi del 6 settembre 1603
Inventario di schiavi del 6 settembre 1603 Inventario della presa compiuta da Andreu Gisbert nei mari di Berberia fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio, alla presenza del portiere ordinario della procurazione reale e dello scrivano della procurazione reale.
Sono stati trovati un moro di nome Ali e una mora di nome Sisa che sono stati affidati al capitano Joan Baptista Loqui.
Testimoni sono Nicholao Boi, portiere e Francesco Devila abitante di Cagliari.
Si fa nota che il viceré ha preso il moro per la joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.
-
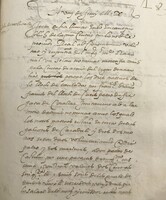 Incanto di schiavi del 9 giugno 1600
Incanto di schiavi del 9 giugno 1600 Il 9 giugno del 1600 si fa pubblico incanto nella città di Cagliari, alla presenza del nobile Procuratore Reale, per consenso, volontà e in presenza del magnifico Maestro Razionale e del pubblico Corridore.
Si vende uno schiavo di nome Mustafa, turco di Smirne del regno di Anatolia, portato da Teulada dal capitano Francesc Bramon, francese di Cassis, patrone di una fregata da corallo. Insieme a lui un altro moro di Tunisi di nome Amet. I due mori sono stati acquistati da don Pedro de Castelvì per 250 lire sarde e 5 soldi in totale.
Nel prezzo totale sono compresi i salari del notaio e del corridore: 8 lire 17 soldi e 8 denari.
Alla regia corte spettano 241 lire, 8 soldi e 4 denari.
Lo stesso giorno viene venduto anche un altro schiavo di nome Amet di Tunisi a don Hieroni Delitala di Alghero per 205 lire di moneta di Cagliari.
Dal prezzo totale si devono sottrarre i soldi per il salario del notaio e del corridore (6 lire 17 soldi e 8 denari), pertanto restano nette alla regia corte 198 lire sarde 3 soldi e 4 denari.
-
 Don Alonso di Castelvì sconta il tempo rimanente dalla taglia di due schiavi
Don Alonso di Castelvì sconta il tempo rimanente dalla taglia di due schiavi Il nobile e molto reverendo don Alonso de Castelvi, canonico della sede di Cagliari, aveva precedentemente stipulato un accordo di affrancamento con Assia, sua schiava, e con il figlio di lei, Joan Pere, anche lui suo schiavo. Le condizioni affinché il patto fosse valido erano che i due lo avrebbero servito per altri 4 anni ciascuno, avrebbero pagato 300 lire e Assia non avrebbe potuto dimorare in altra casa fino al momento in cui avrebbe lasciato il regno. Al momento della stipula del presente atto, delle 300 lire pattuite, i due schiavi ne hanno pagato 130. Nonostante questo Castelvì, per sua esclusiva volontà, abbuona loro sia le lire rimanenti delle 300 da pagare, che il tempo della schiavitù che gli rimane da servire, rendendoli liberi e affrancati da oggi in poi, cosicché possano andare e venire come vorranno, che possano fare ciò che desiderano come persone libere. Permane la condizione che Assia non possa dimorare in un’altra abitazione. L’affrancamento vale anche per tutta la prole dei due schiavi. Assia e Joan Pere accettano questo accordo con reverenze e baciando le mani del Castelvì, al quale restituiscono tutti i vestiti che possiedono.
Testimoni sono Joan Antiogo Caviano, pescatore di Cagliati, e Mauro Ramires, prete di Stampace.
-
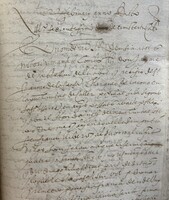 Don Jaume de Castelvì libera Diego, suo schiavo, prima del tempo stabilito dall’atto di taglia
Don Jaume de Castelvì libera Diego, suo schiavo, prima del tempo stabilito dall’atto di taglia Don Jaume de Castelvì, cavaliere dell’ordine di San Giacomo e marchese di Laconi, libera Diego, suo schiavo che lo ha servito per parte dei 4 o 5 anni che doveva in base all’atto di taglia redatto per mano del notaio Alessio Gabriele Horda. Il marchese vuole che il restante tempo del servizio gli sia abbuonato. Quindi rende libero Diego da qualsiasi servitù insieme a tutta la sua prole, cosicché potrà andare e venire come più gli piacerà come un qualsiasi libero cittadino, trattare, stipulare contratti e testimoniare.
Testimoni sono Thomas Scano, prete abitante a Cagliari, Antonio Mannu, negoziante di Sassari al presente abitante a Cagliari.
-
 Atto di liberazione di Axa che ha servito e pagato quanto dovuto
Atto di liberazione di Axa che ha servito e pagato quanto dovuto Elisabetta Alagon y Requesens, marchesa di Villasor, vedova di don Martino de Alagon, marchese di Villasor, signore dell’incontrada di Trexenta e di Parte Barigad’e Susu, libera la sua serva e schiava bianca di nome Axa, di 24 anni circa, del luogo di Bona, che per qualche anno ha servito bene, fedelmente e legalmente nella sua casa e per la sua famiglia. Axa ha inoltre ripagato la sua padrona delle 360 lire che era costato il suo acquisto, parte delle quali messe di tasca sua e parte pagate grazie al prestito del patrone Salvatore Izzo, napoletano di Torre del Greco. Donna Elisabetta libera con Axa anche tutta la sua prole: potranno muoversi e risiedere dove vorranno, testimoniare, trattare e stipulare in giudizio e scegliere un padrone che vorranno, se vorranno, senza limitazione. Testimoni sono Joanne Thoma Mundo di Cagliari e Joanne Maceddo, negoziante di Stampace, e Antiocho Falco, scrivano di Cagliari, intervenuto comes sostituto del notaio.
-
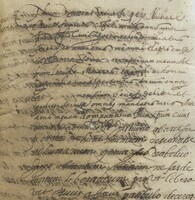 Miquel Roca libera Bonor che ha servito per tre anni e pagato 380 lire
Miquel Roca libera Bonor che ha servito per tre anni e pagato 380 lire Miquel Roca, quarto consigliere della città di Cagliari nel presente anno, afferma di aver comprato anni fa lo schiavo bianco Bonor. Consideranto che Bonor, come da accordi, ha servito bene e fedelmente in casa sua e per la sua famiglia, obbedendo a ogni ordine del suo padrone per tre anni e qualche mese e ha pagato al suo padrone 380 lire di moneta sarda, Roca libera il suo schiavo e tutta la sua prole: da ora in avanti potranno muoversi, andare e venire, abitare dove vorranno, fare ciò che vorranno come liberi cittadini senza più alcun obbligo di servitù.
Testimoni sono Joan Angelo Concas, mercante di Cagliari, e Paulo Morteo, mercante genovese abitante a Cagliari.
-
 Atto di liberazione di Amet che ha pagato il proprio riscatto e servito per gli anni dovuti
Atto di liberazione di Amet che ha pagato il proprio riscatto e servito per gli anni dovuti Donna Elisabetta Alagon y Requesens, marchesa di Villasor, vedova e curatrice dell’eredità di don Martino de Alagon, marchese di Villasor, signore dell’incontrada di Trexenta e di Parte Barigad’e Susu, rispettando le ultime volontà testamentarie del marito libera Amet, schiavo bianco del luogo di Bona. Amet ha servito bene e fedelmente per alcuni anni (nel testo vi è uno spazio bianco in luogo del numero di anni serviti), obbedendo a ogni ordine che gli è stato impartito e ha pagato a donna Isabella, come da accordi presi con don Martino, 300 lire di moneta sarda, valenti 100 ducati d’oro. La libertà e l’affrancamento valgono anche per tutta la prole di Amet, che d’ora in avanti potrà andare e venire come vorrà, dimorare dove vorrà, comparire in giudizio, testimoniare, stipulare accordi, senza più alcun obbligo di servitù come un qualsiasi uomo libero.
Testimoni sono Vincentio Zonca, causidico di Stampace, e Petro Meloni di Villanova.
-
 Accordo di taglia tra Amet Mardaix e Jaume Santoro
Accordo di taglia tra Amet Mardaix e Jaume Santoro Il reverendo canonico Jaume Santoro, domiciliato nell’appendice di Llapola, dichiara di aver ricevuto dal suo schiavo Amet Mardaix, moro bianco di Tunisi, 81 lire di moneta cagliaritana. Si tratta della prima parte di un totale di 200 lire totali che Amet deve consegnare al suo padrone in cambio del proprio riscatto. Santoro afferma che la condizione imposta per l'affrancamento di Amet è che mentre pagherà le 119 lire restanti, egli dovrà prestare servizio in tutto ciò che gli verrà comandato. A sua volta il canonico Santoro dichiara di accettare gli accordi e promette di affrancare e rendere libero Amet nel momento in cui terminerà di pagare quanto dovuto.
Amet accetta questi patti e giura, con il dito alzato e con il viso rivolto a oriente, di rispettarli .
Testimoni sono Francesch Leca, sarto, e Jacinto Faris, scrivano della Lapola, abitante a Cagliari.
-
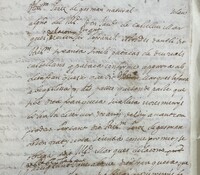 Accordo di taglia tra don Jaume di Castelvì e il suo schiavo Hieronim Perez de Gusman
Accordo di taglia tra don Jaume di Castelvì e il suo schiavo Hieronim Perez de Gusman Don Jaume de Castelvì, marchese di Laconi, intende liberare il suo schiavo Hieronim Perez de Gusman. Infatti Hieronim ha consegnato al suo padrone, in cambio della propria libertà, 65 patacche da 2 reali castigliani ciascuna. L’accordo di liberazione prevede che lo schiavo, oltre al pagamento della suddetta cifra, presti altri due anni di servizio fedele, trascorsi i quali sarà libero e affrancato senza più alcun obbligo di schiavitù.
Testimoni sono Thomas Moreno, scrivano, e Simoni Carta, causidico, abitanti entrambi a Stampace di Cagliari.
-
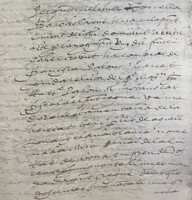 Monço, schiavo attallato, tratta per riscattare la schiava Mira
Monço, schiavo attallato, tratta per riscattare la schiava Mira Don Melchiorre Torrella, barone di Capoterra, ha comprato da Francisca Palou e Garcet, vedova di Joan Antonio Palou, ex avvocato fiscale del regno, una schiava bianca di nome Mira, nata a Bona, per 250 lire di moneta del presente regno.
Delle 250 lire ne ha pagato 220 il barone Torrella stesso e 30 lire gliele ha date Monço, schiavo di Joan Angel Quessa, mercante di Cagliari. Si specifica che Monço e il suo padrone Joan Angel Quessa hanno stipulato un patto di taglia che avrà termine nel mese di dicembre di questo stesso anno, e dopo la fine della taglia lo schiavo sarà libero.
Il barone Torrella dice di aver comprato la schiava Mira in nome, per conto e commissione dello schiavo Monço stipulando i seguenti accordi.
Il Torrella promette che, non appena Monço gli avrà ripagato le 220 lire che ha anticipato per l’acquisto di Mira, lui gli consegnerà la schiava affrancata e libera e Monço ne potrà fare ciò che vorrà nella sua piena volontà. Monço inoltre si obbliga a Melchior Torrella affinché, nel frattempo che non avrà terminato di ripagargli il suo debito, starà in casa sua insieme a Mira e lo servirà da schiavo in tutti i servizi che lui gli comanderà, e il suo precedente padrone, quando finirà la taglia, gli permetterà di trasferirsi nella casa del Torrella. Inoltre promette che, durante il tempo rimanente della taglia, ogni giorno porterà, a spese di Torrella, due barili d’acqua al Quessa e due barili di pescato. Ancora il barone Torrella pro mette a Monço per tutto il tempo che lui e Mira staranno a casa sua lui li nutrirà con cibo e bevande.
D’accordo le due parti decidono che Monço non potrà ricevere soldi da nessuna persona di Cagliari né del resto del regno di Sardegna per restituire i soldi che deve al barone, ma devono essere soldi di giornate lavorate, guadagnati o che gli verranno inviati dalla Barberia. Ancora d’accordo stabiliscono che se Monço non adempie a tutte le cose stabilite, Mira rimarrà schiava di Melchior Torrella come se questo atto non fosse mai stato fatto. Se invece Monço ne paga solo parte e il rimanente viene pagato da Mira, allora Mira sarà libera e franca. Tutte le parti promettono di adempiere agli accordi senza ritardi. Testimoni sono Nicolao Montelles, mercante di Cagliari e Nicolao Porxella della villa di Serdiana.
-
 Don Joan Naharro de Ruecas libera in anticipo Barquet di Bona rispetto ai tempi previsti dal contratto di taglia
Don Joan Naharro de Ruecas libera in anticipo Barquet di Bona rispetto ai tempi previsti dal contratto di taglia Don Joannes Naharro de Ruecas ha concesso taglia al suo schiavo Barquet di Bona nel 1599. Barquet ha servito nella casa del padrone per tre anni e ha pagato 85 scudi, prezzo del proprio riscatto nonché cifra che l’acquisto dello schiavo era costato a don Joan. Nel presente atto don Joan sconta a Barquet i tre mesi e 21 giorni che rimarrebbero del servizio e lo libera in anticipo: dal giorno presente Barquet potrà muoversi, spostarsi e andare dove vorrà nel mondo come uomo libero, testimoniare, fare contratti e tutto quello che un uomo libero può fare. La libertà di Barquet è estesa anche a tutta la sua prole.
Testimoni sono Antonius Maynes, sarto di Stampace, e Luca de Vico di Sassari, abitante a Villanova di Cagliari.
-
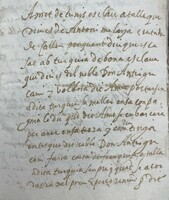 Amet di Tunisi, schiavo attallato, fa un accordo col padrone della propria moglie, la schiava Turquia
Amet di Tunisi, schiavo attallato, fa un accordo col padrone della propria moglie, la schiava Turquia Amet di Tunisi, schiavo di Antoni Molarja, sottoposto a taglia e sposato con Turquia di Bona, schiava del nobile don Antiogo Cani, afferma di voler portare Turquia con sé quando si imbarcherà per la Barbaria. Dunque Amet si accorda con don Antiogo Cani per pagare il riscatto di Turquia 500 lire di moneta cagliaritana, pagate poco a poco, e così don Antiogo consente che quando Amet si imbarcherà porterà con sé Turquia. Per garanzia delle cose concordate, Amet obbliga la sua persona e i suoi beni mobili e immobili. Lo firma e giura more saracenorum.
Testimoni sono Visent Guiso e Miquel Angel Bonfant, abitanti di Cagliari.
-
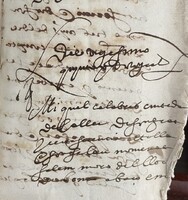 Accordo di taglia tra Miquel Calabres e Salem di Bona
Accordo di taglia tra Miquel Calabres e Salem di Bona Miquel Calabres, cittadino di Cagliari, dà talla al suo schiavo Salem, moro di Bona, purché Salem sia obbligato alla stessa servitù e schiavitù per altri tre anni a partire da oggi. Inoltre entro la fine dei tre anni Salem sarà obbligato a pagare 160 lire, prezzo che costò a Calabres il suo acquisto, compreso lo stipendio del pubblico corridore. Di queste 160 lire Calabres ne ha già ricevute 25, dunque ne restano da pagare a Salem 135.
Testimoni sono Simo Merea, mercante genovese, e Joan Jaco Rubio di Nuoro, abitante di Cagliari.
Tre anni dopo, il 2 novembre 1614, Calabres riconosce a Salem che ha ricevuto da lui in diverse partite e giorni diversi 160 lire che sono il prezzo del suo riscatto, conformemente all’atto di taglia firmato il 25 giugno 1611. Quindi firmando l’apoca di pagamento lo fa anche libero e affrancato dalla schiavitù, così che possa andare e venire come vorrà e fare ciò che vorrà come un uomo libero.
Testimoni sono il reverendo Pere [Cavassa], prete e benificiato della sede primaziale di Cagliari e Jaime Gamboi, abitante di Cagliari.
-
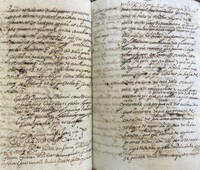 Accordo di taglia tra Gregori Guerau e Ibraim di Niemsa
Accordo di taglia tra Gregori Guerau e Ibraim di Niemsa Il molto reverendo dottore in sacra teologia Gregori Guerau de Pinna, canonico e vicario nell’arcivescovato di Cagliari per l’illustrissimo e reverendissimo don Francesco Esquivell, arcivescovo di Cagliari, dona taglia a Ibraym. ungaro di Niemsa nelle parti di tramontana o levante, suo schiavo bianco, di statura alta, di più di 40 anni. La taglia prevede che lo schiavo debba servire per 4 anni il suo padrone e la sua famiglia in casa, bene e lealmente, cominciando i 4 anni dal giorno presente. Dovrà inoltre pagare 300 lire di moneta di Cagliari e dovrà essere leale, non rubare niente né in casa né fuori, non fuggire, tornare a casa ogni notte al tocco della preghiera, non ubriacarsi. Se non seguirà ognuno degli obblighi, la taglia sarà nulla. Per il sostentamento della casa del padrone lo schiavo dovrà andare a prendere l’acqua da bere a Palabanda e promette che per ogni anno darà 4 scudi per la raccolta dell’acqua che si conserverà nella cisterna. E questo oltre alle 300 lire che deve pagare. Il suo padrone promette di alimentarlo e vestirlo e, alla fine della taglia, promette fargli carta di affrancamento. Lo schiavo non potrà spostarsi dalla casa del padrone finché non avrà modo di imbarcarsi per tornare nella sua terra e se il viaggio non dovesse avere buon esito dovrà tornare al servizio del padrone finché non riuscirà a uscire dal regno di Sardegna. Abraim (Ibraim) accetta e promette di osservare i patti. Testimoni sono Antiochus Holla, boscaiolo di lapola e Gavinus Penducho, scrivano di Cagliari.
-
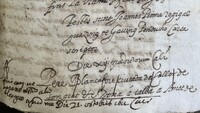 Accordo di taglia tra Pere Blancafort e Amet di Algeri
Accordo di taglia tra Pere Blancafort e Amet di Algeri Pere Blancafort cittadino di Cagliari concorda i capitoli di taglia con Amet di Algeri, suo schiavo. Amet dovrà servire lui e la sua famiglia con tutti i doveri di che gli saranno comandati per sei anni contati dal giorno presente; dovrà pagare 400 lire di moneta cagliaritana da pagare secondo quanto guadagnerà dal suo lavoro: dovrà dare al suo padrone tutto quello che guadagnerà giornalmente. Amet promette che non fuggirà, non ruberà in casa né fuori casa, non si ubriacherà e ogni notte, suonata la preghiera, si farà trovare in casa del padrone. Se mancherà di fare una di queste cose la taglia sarà nulla. Inoltre Blancafort non sarà obbligato a vestirlo, farlo sposare e nutrirlo con cibo e acqua. Alla fine di questa taglia, se Amet avrà adempiuto a tutti gli obblighi, Blancafort promette di dargli la libertà. Inoltre si stabilisce che, nel caso finisca la taglia e abbia pagato come detto, che lo schiavo non possa cambiare casa se non per tornare a casa sua nella sua terra, e se il viaggio non dovesse rivelarsi fruttuoso e non riuscisse ad arrivare nella sua terra, allora dovrà tornare a casa del padrone e servirlo nuovamente secondo i patti. Amet accetta questa taglia e i patti, promettendo di servire bene e lealmente e di pagare le 400 lire. Per maggiore sicurezza del suo padrone, in caso fuggisse, porta come garanzia Amet di Algeri schiavo di don Gaspar de Requesens e Abarca schiavo del quondam Joan Antonio Palou di Tabarca e uno schiavo di Miquel Calabres proveniente da Gerbens ma di cui non viene indicato il nome, tutti presenti per far sì che ciò che Amet promette sia obbligato a mantenere. Non solo, ma se lui fuggirà e non dovesse tornare, si impegnano a pagare loro stessi le 400 lire di taglia a Blancafort e a servirlo in vece di Amet oppure a pagare perché venga svolto per il Blancafort lo stesso servizio che avrebbe dovuto svolgere Amet durante il periodo di taglia come se non fosse mai fuggito. Blancafort accetta queste garanzie ad ulteriore patto che se uno di questi schiavi venisse nel frattempo liberato, provvederà a sua volta a trovare un’altra garanzia. Testimoni: mestre Antiogo Meli e Francesch Jorgii, filatori abitanti a stampace e marina e lo schiavo (di cui non scrivono il nome) di Miquel Calabres.
Il 24 luglio dello stesso anno, Abarca, schiavo appartenuto prima al dottor Juan Antoni Palou, avvocato fiscale e patrimoniale e, dopo la sua morte, a sua moglie Francesca Palou y Garcet, essendo stato nel frattempo affrancato, firma un atto in merito alla sua partecipazione in qualità di garante all’atto di taglia del 12 maggio 1606 a favore di Amet di Algeri. La condizione della sua garanzia nell’atto di taglia era che, nel caso fosse stato liberato nel frattempo, avrebbe provveduto a dare un altro moro in suo luogo come garante. Quindi considerato che ora Abarca intende ritornare nella sua terra, essendo stato liberato, in presenza di Pere Blancafort dà in cambio di se stesso come garante Abrahim di Bona, presente a questo atto, schiavo di Gaspar Bonato, mercante di Cagliari, con le medesime obbligazioni. Abrahim accetta le responsabilità di garanzia. Promette che sarà tenuto a tutte le cose che Abarca promettè. Tesimoni sono Gavinus Penducho Carta, scrivano, e Jacobus Gamboa, portario regio.
-
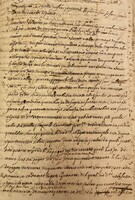 Accordo di taglia tra Joan Antonio Sanna e Antioco della Conpceçion e di Tetuan
Accordo di taglia tra Joan Antonio Sanna e Antioco della Conpceçion e di Tetuan Capitoli di taglia stipulati tra il dottore in arti e medicina Joan Antoni Sanna, protomedico di Cagliari, e il suo schiavo, cristiano battezzato, Antiogo della Conpceçion della città di Tetuan in Marocco. Sanna concede taglia per il tempo di 4 anni a partire da oggi ad Antiogo a patto che in questo tempo gli faccia tutti i servizi che gli verranno ordinati sia di giorno che di notte, e che, terminati i servizi, chieda licenza per andare a servire altre persone per guadagnare il denaro necessario a pagare il prezzo del proprio riscatto e, se sarà necessario, per far sì che il dottor Sanna possa disporre di un altro uomo per fare il detto servizio di Antiogo nel caso in cui lui non si trovasse in casa per fare il suo dovere. Tutto ciò a condizione che non fuggirà, non ruberà né a casa del Sanna né a casa di nessun’altra persona e non si ubriacherà. In caso contrario la presente taglia sarà dichiarata nulla, il denaro che Antiogo gli avrà dato fino a quel momento sarà perduto e Antiogo dovrà tornare schiavo e rimanerlo perpetuamente. Un altro accordo è che entro i 4 anni dovrà pagare l’intero suo riscatto, stabilito in 250 lire in contanti e, se non avrà finito di pagare, dovrà continuare a servire il Sanna, alle stesse condizioni, finché non terminerà. Il Sanna specifica che ogni settimana o ogni mese Antiogo dovrà consegnargli il denaro che guadagnerà – fino al raggiungimento della somma totale – e lui gli rilascerà ogni volta ricevuta. A sua volta Sanna si impegna a nutrirlo, dargli da bere, curarlo se malato. Alla fine dei 4 anni, se tutto andrà bene, il Sanna farà carta di affrancamento ad Antiogo, il quale accetta tutti gli accordi.
Testimoni sono Joan Bonungo e Thomas Fancello, scrivano, abitante a Cagliari.
 Intervista a Umberto Cocco L'intervista si apre con una breve presentazione del giornalista Umberto Cocco. Fin dall’inizio ha collegato il culto di San Costantino alla schiavitù in Sardegna, facendo riferimento alla leggenda sullo schiavo di Scano Montiferro, liberato da San Costantino e che, in segno di gratitudine, avrebbe costruito la chiesa sul Monte Isei. Secondo il giornalista Cocco, a Scano Montiferro questa memoria è forse più viva rispetto a Sedilo, dove invece vengono tramandate diverse storie locali, come quella secondo cui San Costantino avrebbe salvato il paese dall’imposizione di tasse da parte dell’esercito piemontese. Tuttavia, l’esperto ha ammesso di non conoscere molti dettagli sul collegamento diretto tra il culto e la schiavitù. Si è poi soffermato sull’importanza del culto di San Costantino, sottolineando come oggi abbia assunto grande rilevanza, talvolta eccessiva, mentre in passato non rappresentava la devozione principale. Negli anni Duemila, l’amministrazione aveva commissionato una ricerca agli archivisti di Cagliari, dalla quale emerse che fino all’Ottocento il nome Costantino non veniva attribuito ai figli appena nati. Se il culto fosse stato così centrale, sostiene Cocco, il nome sarebbe stato più diffuso. In effetti, esso compare tardivamente ed è presente soprattutto in alcune zone della Sardegna come Sassari, Olzai e Orotelli, non lontano da Sedilo. Per quanto riguarda gli ex voto presenti nella chiesa, il giornalista afferma che molti sono scomparsi nel tempo, in parte perché alcuni sacerdoti non li ritenevano esponibili e in parte perché fino a pochi anni gli ex voto da parte dei sedilesi erano molto rari. Secondo l’esperto, il culto non apparteneva realmente alla comunità sedilese fino al Novecento, quando il paese decise di appropriarsene, soprattutto in relazione all’Ardia. Oggi, infatti, il rito risulta fortemente centrato sull’Ardia stessa, mentre la devozione verso San Costantino appare marginale, soprattutto tra i giovani, e teme che in futuro questa tendenza possa accentuarsi ulteriormente. L’intervista si è conclusa con il consenso alla pubblicazione per fini di studio e di ricerca.
Intervista a Umberto Cocco L'intervista si apre con una breve presentazione del giornalista Umberto Cocco. Fin dall’inizio ha collegato il culto di San Costantino alla schiavitù in Sardegna, facendo riferimento alla leggenda sullo schiavo di Scano Montiferro, liberato da San Costantino e che, in segno di gratitudine, avrebbe costruito la chiesa sul Monte Isei. Secondo il giornalista Cocco, a Scano Montiferro questa memoria è forse più viva rispetto a Sedilo, dove invece vengono tramandate diverse storie locali, come quella secondo cui San Costantino avrebbe salvato il paese dall’imposizione di tasse da parte dell’esercito piemontese. Tuttavia, l’esperto ha ammesso di non conoscere molti dettagli sul collegamento diretto tra il culto e la schiavitù. Si è poi soffermato sull’importanza del culto di San Costantino, sottolineando come oggi abbia assunto grande rilevanza, talvolta eccessiva, mentre in passato non rappresentava la devozione principale. Negli anni Duemila, l’amministrazione aveva commissionato una ricerca agli archivisti di Cagliari, dalla quale emerse che fino all’Ottocento il nome Costantino non veniva attribuito ai figli appena nati. Se il culto fosse stato così centrale, sostiene Cocco, il nome sarebbe stato più diffuso. In effetti, esso compare tardivamente ed è presente soprattutto in alcune zone della Sardegna come Sassari, Olzai e Orotelli, non lontano da Sedilo. Per quanto riguarda gli ex voto presenti nella chiesa, il giornalista afferma che molti sono scomparsi nel tempo, in parte perché alcuni sacerdoti non li ritenevano esponibili e in parte perché fino a pochi anni gli ex voto da parte dei sedilesi erano molto rari. Secondo l’esperto, il culto non apparteneva realmente alla comunità sedilese fino al Novecento, quando il paese decise di appropriarsene, soprattutto in relazione all’Ardia. Oggi, infatti, il rito risulta fortemente centrato sull’Ardia stessa, mentre la devozione verso San Costantino appare marginale, soprattutto tra i giovani, e teme che in futuro questa tendenza possa accentuarsi ulteriormente. L’intervista si è conclusa con il consenso alla pubblicazione per fini di studio e di ricerca. Intervista Giovanni Melis Nel corso della ricerca si è rivelato fondamentale il contributo del confratello ed ex presidente Giovanni Melis, il quale ha chiarito il legame tra schiavitù e l’Arciconfraternita, definendolo piuttosto marginale. Questo esperto ha spiegato che l’Arciconfraternita fu fondata da venti ex schiavi, i quali, al momento della costituzione, non erano più in stato di schiavitù. Si presume, sebbene non vi siano fonti scritte che lo attestino con certezze, che fossero stati liberati dall’Arciconfraternita dei Genovesi e successivamente condotti a Cagliari. Una volta giunti in città, chiesero aiuto ai padri agostiniani, dai quali furono accolti e gradualmente introdotti nella società locale. Con il passare del tempo, questi ex schiavi sentirono la necessità di restituire quanto ricevuto, offrendo il proprio servizio alla comunità e, in particolare, aiutando le persone più deboli. In seguito, con il sostegno di alcuni confratelli dell’Arciconfraternita dei Genovesi, diedero vita a una nuova confraternita, quella della Madonna d’Itria, che essi già veneravano durante il periodo della schiavitù. Il confratello ha inoltre sottolineato che la Madonna d’Itria era conosciuta anche come Madonna del Buon Cammino, poiché ritenuta guida delle persone sul giusto percorso di vita. Esistono infatti confraternite che assumono il nome di Confraternite del Buon Cammino o dei Viandanti, come nel caso di Sassari. Il riconoscimento ufficiale dell’Arciconfraternita raggiunse il suo apice nel 1607, con la bolla di papa Paolo V, che ne sancì lo status di confraternita dotata di diritti e doveri ecclesiastici. Nel 1625 la confraternita viene affiliata alla cerchia di Sant’Agostino di Roma, ottenendo anche il titolo di Arciconfraternita. Lo scopo principale di questa è l’aiuto ai poveri e ai bisognosi, con particolare attenzione alle donne in stato di necessità, come ad esempio le ragazze madri. L’Arciconfraternita offre sostegno anche ai confratelli in difficoltà, tuttavia, per rispetto della privacy, non vengono resi noti i dettagli degli aiuti forniti pur essendo noto all’interno della comunità che tali interventi avvengono. L’Arciconfraternita si distingue dalle altre anche per la sua struttura interna: non esistono le figure del priore o della priora, ma solo confratelli e consorelle che costituiscono un unico gruppo. L’abito è uguale sia per gli uomini sia per le donne e anche la carica di presidente può essere ricoperta da una donna, evento che si è già verificato in passato. Di questo aspetto l’Arciconfraternita si dichiara particolarmente orgogliosa. L’intervista si conclude con il consenso da parte di Giovanni Melis a pubblicare l’intervista per fini di studio e di ricerca.
Intervista Giovanni Melis Nel corso della ricerca si è rivelato fondamentale il contributo del confratello ed ex presidente Giovanni Melis, il quale ha chiarito il legame tra schiavitù e l’Arciconfraternita, definendolo piuttosto marginale. Questo esperto ha spiegato che l’Arciconfraternita fu fondata da venti ex schiavi, i quali, al momento della costituzione, non erano più in stato di schiavitù. Si presume, sebbene non vi siano fonti scritte che lo attestino con certezze, che fossero stati liberati dall’Arciconfraternita dei Genovesi e successivamente condotti a Cagliari. Una volta giunti in città, chiesero aiuto ai padri agostiniani, dai quali furono accolti e gradualmente introdotti nella società locale. Con il passare del tempo, questi ex schiavi sentirono la necessità di restituire quanto ricevuto, offrendo il proprio servizio alla comunità e, in particolare, aiutando le persone più deboli. In seguito, con il sostegno di alcuni confratelli dell’Arciconfraternita dei Genovesi, diedero vita a una nuova confraternita, quella della Madonna d’Itria, che essi già veneravano durante il periodo della schiavitù. Il confratello ha inoltre sottolineato che la Madonna d’Itria era conosciuta anche come Madonna del Buon Cammino, poiché ritenuta guida delle persone sul giusto percorso di vita. Esistono infatti confraternite che assumono il nome di Confraternite del Buon Cammino o dei Viandanti, come nel caso di Sassari. Il riconoscimento ufficiale dell’Arciconfraternita raggiunse il suo apice nel 1607, con la bolla di papa Paolo V, che ne sancì lo status di confraternita dotata di diritti e doveri ecclesiastici. Nel 1625 la confraternita viene affiliata alla cerchia di Sant’Agostino di Roma, ottenendo anche il titolo di Arciconfraternita. Lo scopo principale di questa è l’aiuto ai poveri e ai bisognosi, con particolare attenzione alle donne in stato di necessità, come ad esempio le ragazze madri. L’Arciconfraternita offre sostegno anche ai confratelli in difficoltà, tuttavia, per rispetto della privacy, non vengono resi noti i dettagli degli aiuti forniti pur essendo noto all’interno della comunità che tali interventi avvengono. L’Arciconfraternita si distingue dalle altre anche per la sua struttura interna: non esistono le figure del priore o della priora, ma solo confratelli e consorelle che costituiscono un unico gruppo. L’abito è uguale sia per gli uomini sia per le donne e anche la carica di presidente può essere ricoperta da una donna, evento che si è già verificato in passato. Di questo aspetto l’Arciconfraternita si dichiara particolarmente orgogliosa. L’intervista si conclude con il consenso da parte di Giovanni Melis a pubblicare l’intervista per fini di studio e di ricerca. Intervista Antonio Esposito Ordine Mercedario L’intervista si apre con il racconto della nascita dell’Ordine Mercedario nel 1218 a Barcellona. La guida ha sottolineato come il fondatore dell’Ordine, Pietro Nolasco, fosse un laico, ribadendo più volte che la santità fosse accessibile a tutti. Nolasco era un ricco mercante di stoffe che, viaggiando, si rese conto della diffusa povertà e della schiavitù presenti nel mondo, da questa consapevolezza nacque un profondo cambiamento nella sua vita, che lo portò a donare i propri beni ai poveri e ai prigionieri. Secondo il racconto, Pietro Nolasco ebbe successivamente una visione della Madonna della Mercede, che gli chiese di fondare un ordine religioso dedicato al riscatto degli schiavi. Iniziò così, insieme ai suoi compagni, a raccogliere denaro per pagare il riscatto dei prigionieri. Tra le figure centrali vi era il cosiddetto frate cercatore, incaricato a reperire le somme necessarie e di consegnarle per la liberazione degli schiavi. La guida ha inoltre spiegato che molte opere presenti nella sagrestia raffigurano proprio queste scene: i frati trattavano con i saraceni, che spesso richiedevano somme sempre più elevate. In alcuni casi, il responsabile della questua offriva persino la propria vita in cambio della liberazione del prigioniero. Tra il Trecento e il Quattrocento, secondo quanto riferito, circa cinquecento frati mercedari persero la vita in modo violento, impiccati, bruciati vivi, lapidati o squarciati nel tentativo di riscattare gli schiavi. Un episodio particolarmente significativo per la Sardegna riguarda i carlofortini, deportati in Tunisia e riscattati uno alla volta dai padri mercedari. Per questo motivo ancora oggi, i carlofortini si recano a Cagliari portando la Madonna dello Schiavo, in segno di ringraziamento alla Vergine e ai padri mercedari per la liberazione dalla schiavitù. L’intervista si chiude con un invito di Antonio Esposito alla popolazione a visitare il Santuario di Bonaria e a scoprirne la storia; infine, esprime il suo consenso alla pubblicazione dell’intervista per fini di studio e di ricerca.
Intervista Antonio Esposito Ordine Mercedario L’intervista si apre con il racconto della nascita dell’Ordine Mercedario nel 1218 a Barcellona. La guida ha sottolineato come il fondatore dell’Ordine, Pietro Nolasco, fosse un laico, ribadendo più volte che la santità fosse accessibile a tutti. Nolasco era un ricco mercante di stoffe che, viaggiando, si rese conto della diffusa povertà e della schiavitù presenti nel mondo, da questa consapevolezza nacque un profondo cambiamento nella sua vita, che lo portò a donare i propri beni ai poveri e ai prigionieri. Secondo il racconto, Pietro Nolasco ebbe successivamente una visione della Madonna della Mercede, che gli chiese di fondare un ordine religioso dedicato al riscatto degli schiavi. Iniziò così, insieme ai suoi compagni, a raccogliere denaro per pagare il riscatto dei prigionieri. Tra le figure centrali vi era il cosiddetto frate cercatore, incaricato a reperire le somme necessarie e di consegnarle per la liberazione degli schiavi. La guida ha inoltre spiegato che molte opere presenti nella sagrestia raffigurano proprio queste scene: i frati trattavano con i saraceni, che spesso richiedevano somme sempre più elevate. In alcuni casi, il responsabile della questua offriva persino la propria vita in cambio della liberazione del prigioniero. Tra il Trecento e il Quattrocento, secondo quanto riferito, circa cinquecento frati mercedari persero la vita in modo violento, impiccati, bruciati vivi, lapidati o squarciati nel tentativo di riscattare gli schiavi. Un episodio particolarmente significativo per la Sardegna riguarda i carlofortini, deportati in Tunisia e riscattati uno alla volta dai padri mercedari. Per questo motivo ancora oggi, i carlofortini si recano a Cagliari portando la Madonna dello Schiavo, in segno di ringraziamento alla Vergine e ai padri mercedari per la liberazione dalla schiavitù. L’intervista si chiude con un invito di Antonio Esposito alla popolazione a visitare il Santuario di Bonaria e a scoprirne la storia; infine, esprime il suo consenso alla pubblicazione dell’intervista per fini di studio e di ricerca. Intervista ad Andrea Luxoro Secondo l’esperto, il culto è legato all’esperienza tragica dell’incursione barbaresca compiuta dai tunisini nel 1798. Nella notte fra il 2 e il 3 settembre si verificò il famoso sacco di Carloforte, durante il quale una parte della popolazione fu ridotta in schiavitù e deportata in Tunisia. Tra gli schiavi vi era Nicola Moretto, che il 15 novembre 1800, in un giardino della Tunisia, ritrovò il simulacro della Madonna dello Schiavo in circostanze misteriose, definite quasi miracolose da un attestato del prefetto di Tunisi. Successivamente Andrea si sofferma sull’importanza che la Madonna dello Schiavo ha per sé stesso e per la comunità di Carloforte, definendola una delle devozioni più significative della sua vita. Il culto, infatti non riguarda soltanto una scelta individuale, ma assume una dimensione collettiva, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Andrea Luxoro ha raccontato di aver sempre partecipato alle celebrazioni, rientrando da Cagliari a Carloforte, sia per la festa del 15 novembre, legata al ritrovamento del simulacro, sia per quella del 2 settembre, che ricorda l’incursione barbaresca. Quest’ultima è caratterizzata da un tono più sobrio e solenne. La modalità delle celebrazioni è cambiata nel tempo: documenti storici mostrano che inizialmente veniva commemorata soltanto la data del 2 settembre; nel 1924 don Gabriele Pagani istituì la festa del 15 novembre e, dalla seconda metà del Novecento, entrambe le ricorrenze vennero mantenute. Attualmente la festa si arricchisce di nuovi momenti rituali, tra cui la processione del trasferimento del simulacro dal suo santuario alla chiesa parrocchiale di San Carlo, che avviene il 5 novembre, vigilia dell’inizio della novena. In passato tale trasferimento avveniva in forma privata, mentre oggi è accompagnato dai giovani e assume forme sempre più solenni. Il rientro del simulacro nella sua chiesa avviene la settimana successiva alla festa, ma qualora la celebrazione cada in un giorno successivo al giovedì, il rientro non avviene la domenica immediatamente successiva, ma quella seguente, con una permanenza di circa quindici giorni nella parrocchia di San Carlo. La festa comprende anche altri momenti significativi: i carlofortini residenti nell’area del Cagliaritano celebrano la Madonna dello Schiavo presso il Santuario di Nostra Signora di Bonaria, ricordando anche l’intervento dell’Ordine della Mercede per la liberazione degli schiavi. Un’ulteriore celebrazione si svolge in Liguria, alla fine di novembre, presso la parrocchia dell’Immacolata di Pegli, con la partecipazione dei carlofortini residenti in quella regione. Infine, l’esperto ha sottolineato come il concetto di schiavitù venga tramandato ai carlofortini fin dall’infanzia, attraverso il racconto dell’incursione e della storia della Madonna dello Schiavo. Di conseguenza, le forme devozionali legate alla Madonna veicolano, anche involontariamente, la consapevolezza della schiavitù anche tra le generazioni più giovani. L’intervista si conclude con il consenso di Andrea alla pubblicazione dei contenuti per fini di studio e di ricerca.
Intervista ad Andrea Luxoro Secondo l’esperto, il culto è legato all’esperienza tragica dell’incursione barbaresca compiuta dai tunisini nel 1798. Nella notte fra il 2 e il 3 settembre si verificò il famoso sacco di Carloforte, durante il quale una parte della popolazione fu ridotta in schiavitù e deportata in Tunisia. Tra gli schiavi vi era Nicola Moretto, che il 15 novembre 1800, in un giardino della Tunisia, ritrovò il simulacro della Madonna dello Schiavo in circostanze misteriose, definite quasi miracolose da un attestato del prefetto di Tunisi. Successivamente Andrea si sofferma sull’importanza che la Madonna dello Schiavo ha per sé stesso e per la comunità di Carloforte, definendola una delle devozioni più significative della sua vita. Il culto, infatti non riguarda soltanto una scelta individuale, ma assume una dimensione collettiva, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Andrea Luxoro ha raccontato di aver sempre partecipato alle celebrazioni, rientrando da Cagliari a Carloforte, sia per la festa del 15 novembre, legata al ritrovamento del simulacro, sia per quella del 2 settembre, che ricorda l’incursione barbaresca. Quest’ultima è caratterizzata da un tono più sobrio e solenne. La modalità delle celebrazioni è cambiata nel tempo: documenti storici mostrano che inizialmente veniva commemorata soltanto la data del 2 settembre; nel 1924 don Gabriele Pagani istituì la festa del 15 novembre e, dalla seconda metà del Novecento, entrambe le ricorrenze vennero mantenute. Attualmente la festa si arricchisce di nuovi momenti rituali, tra cui la processione del trasferimento del simulacro dal suo santuario alla chiesa parrocchiale di San Carlo, che avviene il 5 novembre, vigilia dell’inizio della novena. In passato tale trasferimento avveniva in forma privata, mentre oggi è accompagnato dai giovani e assume forme sempre più solenni. Il rientro del simulacro nella sua chiesa avviene la settimana successiva alla festa, ma qualora la celebrazione cada in un giorno successivo al giovedì, il rientro non avviene la domenica immediatamente successiva, ma quella seguente, con una permanenza di circa quindici giorni nella parrocchia di San Carlo. La festa comprende anche altri momenti significativi: i carlofortini residenti nell’area del Cagliaritano celebrano la Madonna dello Schiavo presso il Santuario di Nostra Signora di Bonaria, ricordando anche l’intervento dell’Ordine della Mercede per la liberazione degli schiavi. Un’ulteriore celebrazione si svolge in Liguria, alla fine di novembre, presso la parrocchia dell’Immacolata di Pegli, con la partecipazione dei carlofortini residenti in quella regione. Infine, l’esperto ha sottolineato come il concetto di schiavitù venga tramandato ai carlofortini fin dall’infanzia, attraverso il racconto dell’incursione e della storia della Madonna dello Schiavo. Di conseguenza, le forme devozionali legate alla Madonna veicolano, anche involontariamente, la consapevolezza della schiavitù anche tra le generazioni più giovani. L’intervista si conclude con il consenso di Andrea alla pubblicazione dei contenuti per fini di studio e di ricerca. Intervista a Mauro Salis a Cagliari Durante l’intervista, l’attenzione si è concentrata fin da subito sul rapporto tra la Madonna del Rimedio e la schiavitù in Sardegna. Secondo Mauro Salis, la Madonna del Rimedio è conosciuta anche con il titolo di Madonna del Riscatto: due denominazioni differenti che fanno riferimento alla medesima manifestazione mariana. Il docente ha spiegato che tali devozioni sono patrocinate dall’Ordine dei Trinitari, un ordine religioso medievale, la cui finalità principale era il riscatto delle persone ridotte in schiavitù. Il riscatto avveniva attraverso la raccolta di elemosine, necessarie a raggiungere una somma richiesta dai detentori degli schiavi per la loro liberazione. Nel corso di queste attività, la richiesta di elemosine era accompagnata da argomentazioni religiose, preghiere e invocazione alla Madonna nella sua titolazione di Riscatto. Come sottolineato dal docente esperto, il termine riscatto è ancora oggi corrente nella lingua italiana e chiarisce il collegamento semantico tra la liberazione degli schiavi e la devozione mariana. Nel contesto sardo, lo storico dell’arte ha evidenziato come il riscatto fosse quasi sempre legato a schiavi sardi di fede cristiana, catturati durante le cosiddette incursioni barbaresche e deportati nelle città nordafricane, dove rimanevano in attesa di liberazione. Il processo di riscatto comportava anche lo spostamento temporaneo dei membri dell’Ordine verso porti di nordafricani. In questo contesto, la Madonna del Rimedio veniva invocata anche come protettrice dei naviganti. Dal punto di vista della storia dell’arte, il docente ha citato lo scultore Giuseppe Antonio Lonis, al quale è stata attribuita una statua conservata nella chiesa di San Lucifero. Sebbene tale attribuzione sia oggi oggetto di discussione, il docente ha sottolineato che il suo interesse per l’opera nasce proprio dalla presenza della titolazione della Madonna del Rimedio. Infine, ha evidenziato come nell’analisi delle immagini sacre, si debba tenere conto anche delle ragioni sociali e antropologiche che determinano le variazioni iconografiche. In questo senso, si è interrogato sul significato e sulle origini della devozione alla Madonna del Rimedio, mettendola in relazione con altri culti mariani legati al tema della schiavitù, come quello della Madonna d’Itria. Quest’ultima, in particolare, nel Seicento entra in competizione con la devozione alla Madonna del Rimedio nel cuore e nell’esperienza di coloro che avevano i familiari da riscattare. L’intervista si è conclusa con il consenso alla pubblicazione dei contenuti a fini di studio e di ricerca.
Intervista a Mauro Salis a Cagliari Durante l’intervista, l’attenzione si è concentrata fin da subito sul rapporto tra la Madonna del Rimedio e la schiavitù in Sardegna. Secondo Mauro Salis, la Madonna del Rimedio è conosciuta anche con il titolo di Madonna del Riscatto: due denominazioni differenti che fanno riferimento alla medesima manifestazione mariana. Il docente ha spiegato che tali devozioni sono patrocinate dall’Ordine dei Trinitari, un ordine religioso medievale, la cui finalità principale era il riscatto delle persone ridotte in schiavitù. Il riscatto avveniva attraverso la raccolta di elemosine, necessarie a raggiungere una somma richiesta dai detentori degli schiavi per la loro liberazione. Nel corso di queste attività, la richiesta di elemosine era accompagnata da argomentazioni religiose, preghiere e invocazione alla Madonna nella sua titolazione di Riscatto. Come sottolineato dal docente esperto, il termine riscatto è ancora oggi corrente nella lingua italiana e chiarisce il collegamento semantico tra la liberazione degli schiavi e la devozione mariana. Nel contesto sardo, lo storico dell’arte ha evidenziato come il riscatto fosse quasi sempre legato a schiavi sardi di fede cristiana, catturati durante le cosiddette incursioni barbaresche e deportati nelle città nordafricane, dove rimanevano in attesa di liberazione. Il processo di riscatto comportava anche lo spostamento temporaneo dei membri dell’Ordine verso porti di nordafricani. In questo contesto, la Madonna del Rimedio veniva invocata anche come protettrice dei naviganti. Dal punto di vista della storia dell’arte, il docente ha citato lo scultore Giuseppe Antonio Lonis, al quale è stata attribuita una statua conservata nella chiesa di San Lucifero. Sebbene tale attribuzione sia oggi oggetto di discussione, il docente ha sottolineato che il suo interesse per l’opera nasce proprio dalla presenza della titolazione della Madonna del Rimedio. Infine, ha evidenziato come nell’analisi delle immagini sacre, si debba tenere conto anche delle ragioni sociali e antropologiche che determinano le variazioni iconografiche. In questo senso, si è interrogato sul significato e sulle origini della devozione alla Madonna del Rimedio, mettendola in relazione con altri culti mariani legati al tema della schiavitù, come quello della Madonna d’Itria. Quest’ultima, in particolare, nel Seicento entra in competizione con la devozione alla Madonna del Rimedio nel cuore e nell’esperienza di coloro che avevano i familiari da riscattare. L’intervista si è conclusa con il consenso alla pubblicazione dei contenuti a fini di studio e di ricerca. Intervista ad Antonio Esposito a Cagliari Durante l’intervista, la guida ha ricostruito l’episodio dell’arrivo della cassa davanti al colle di Bonaria, in prossimità dell’area dove oggi si trova la scalinata. La popolazione tentò invano di aprire la cassa, finché una donna, presente con il proprio bambino, mandò quest’ultimo a chiedere aiuto ai religiosi. Due frati giunsero sul posto, presero la cassa e la trasportarono nel Santuario. Esposito ha sottolineato la difficoltà nello spostamento, affermando che, anche vuota, per sollevarla sarebbero necessarie almeno dieci persone per sollevarla. Una volta aperta la cassa davanti a testimoni, i religiosi trovarono la Madonna con il Bambino e la candela ancora accesa. Inizialmente la statua fu collocata nella cappella laterale della chiesa, poiché al centro dell’altare si trovava già la Madonna del Miracolo. Tuttavia, per quattro notti consecutive, le statue sembravano spostarsi autonomamente. I frati decisero allora di vegliarle, ma il fenomeno continuò a verificarsi. A questo punto fra Catalano, custode del Santuario, ricordò una visione avuta in precedenza, nella quale gli era stato annunciato che dal mare sarebbe arrivata la Signora del colle. Da quel momento la Madonna di Bonaria venne collocata al centro dell’altare, mentre la Madonna del Miracolo fu spostata sulla parte destra. Durante l’intervista è stato inoltre spiegato il significato del nome Madonna di Bonaria. All’epoca, a Cagliari era diffusa la malaria e le persone si recavano sul colle per respirare aria salubre; per questo motivo la Madonna venne associata all’aria buona. Secondo la tradizione, il nome avrebbe inoltre influenzato quello della capitale argentina, Buenos Aires. Infine, Esposito ha descritto le celebrazioni in onore alla Madonna di Bonaria raccontando che la prima si svolge il 25 marzo, la seconda ad aprile, la terza a settembre, mentre la prima domenica di luglio ha luogo la processione a mare, durante la quale la comunità ringrazia la Madonna per i miracoli compiuti e per la sua protezione come patrona dei naviganti. Un ulteriore elemento significativo è rappresentato da una barca d’avorio collocata sopra il Santuario, donata da una pellegrina diretta in Terra Santa. Secondo la tradizione, una volta posta sull’altare di fronte alla Madonna di Bonaria, la barca si muoverebbe quotidianamente, con la prua che indicherebbe le correnti presenti nel Golfo degli Angeli. L’intervista si conclude con il consenso di Antonio Esposito a pubblicarla per fini di studio e di ricerca.
Intervista ad Antonio Esposito a Cagliari Durante l’intervista, la guida ha ricostruito l’episodio dell’arrivo della cassa davanti al colle di Bonaria, in prossimità dell’area dove oggi si trova la scalinata. La popolazione tentò invano di aprire la cassa, finché una donna, presente con il proprio bambino, mandò quest’ultimo a chiedere aiuto ai religiosi. Due frati giunsero sul posto, presero la cassa e la trasportarono nel Santuario. Esposito ha sottolineato la difficoltà nello spostamento, affermando che, anche vuota, per sollevarla sarebbero necessarie almeno dieci persone per sollevarla. Una volta aperta la cassa davanti a testimoni, i religiosi trovarono la Madonna con il Bambino e la candela ancora accesa. Inizialmente la statua fu collocata nella cappella laterale della chiesa, poiché al centro dell’altare si trovava già la Madonna del Miracolo. Tuttavia, per quattro notti consecutive, le statue sembravano spostarsi autonomamente. I frati decisero allora di vegliarle, ma il fenomeno continuò a verificarsi. A questo punto fra Catalano, custode del Santuario, ricordò una visione avuta in precedenza, nella quale gli era stato annunciato che dal mare sarebbe arrivata la Signora del colle. Da quel momento la Madonna di Bonaria venne collocata al centro dell’altare, mentre la Madonna del Miracolo fu spostata sulla parte destra. Durante l’intervista è stato inoltre spiegato il significato del nome Madonna di Bonaria. All’epoca, a Cagliari era diffusa la malaria e le persone si recavano sul colle per respirare aria salubre; per questo motivo la Madonna venne associata all’aria buona. Secondo la tradizione, il nome avrebbe inoltre influenzato quello della capitale argentina, Buenos Aires. Infine, Esposito ha descritto le celebrazioni in onore alla Madonna di Bonaria raccontando che la prima si svolge il 25 marzo, la seconda ad aprile, la terza a settembre, mentre la prima domenica di luglio ha luogo la processione a mare, durante la quale la comunità ringrazia la Madonna per i miracoli compiuti e per la sua protezione come patrona dei naviganti. Un ulteriore elemento significativo è rappresentato da una barca d’avorio collocata sopra il Santuario, donata da una pellegrina diretta in Terra Santa. Secondo la tradizione, una volta posta sull’altare di fronte alla Madonna di Bonaria, la barca si muoverebbe quotidianamente, con la prua che indicherebbe le correnti presenti nel Golfo degli Angeli. L’intervista si conclude con il consenso di Antonio Esposito a pubblicarla per fini di studio e di ricerca. Intervista ad Albertina Piras a Villamar Durante l’intervista, svolta presso la chiesa campestre, la docente ha raccontato la storia della Madonna, sottolineando il suo arrivo da Costantinopoli, fino al territorio sardo grazie ai Bizantini. Si è soffermata inoltre sull’iconografia del simulacro, evidenziando come solo in Sardegna la Madonna venga raffigurata insieme al moro e al turco. Secondo Piras, la comunità villamarese è molto devota alla Madonna, e ritiene sia stata lei stessa a scegliere il paese, poiché, secondo la tradizione la statua era diretta verso Pauli Arbarei, ma i buoi che la trasportavano si fermarono a Villamar e non vollero più andare avanti. Questo episodio fu interpretato dai villamaresi come un segno della volontà della Madonna di restare nel loro paese. Ancora oggi, nel punto in cui avvenne l’episodio, è presente una croce chiamata Sa Gruxi de Nostra Signora. Nell’intervista è stata affrontata anche la questione del cocchio, che ha generato conflitti all’interno della comunità: inizialmente si desiderava collocarlo all’interno della chiesa, ma ciò non fu consentito. Attualmente, per questo motivo, il cocchio è custodito in un garage, mentre presso la parrocchia di San Giovanni Battista è conservato un cocchio in miniatura. Infine, la docente ha ricordato come in passato gli abitanti del paese ritenessero che il culto della Madonna d’Itria esistesse solo a Villamar, mentre studi successivi hanno dimostrato la sua diffusione in altri centri della Sardegna. L’intervista si conclude con l’autorizzazione della docente a pubblicare l’intervista per fini di studio e di ricerca.
Intervista ad Albertina Piras a Villamar Durante l’intervista, svolta presso la chiesa campestre, la docente ha raccontato la storia della Madonna, sottolineando il suo arrivo da Costantinopoli, fino al territorio sardo grazie ai Bizantini. Si è soffermata inoltre sull’iconografia del simulacro, evidenziando come solo in Sardegna la Madonna venga raffigurata insieme al moro e al turco. Secondo Piras, la comunità villamarese è molto devota alla Madonna, e ritiene sia stata lei stessa a scegliere il paese, poiché, secondo la tradizione la statua era diretta verso Pauli Arbarei, ma i buoi che la trasportavano si fermarono a Villamar e non vollero più andare avanti. Questo episodio fu interpretato dai villamaresi come un segno della volontà della Madonna di restare nel loro paese. Ancora oggi, nel punto in cui avvenne l’episodio, è presente una croce chiamata Sa Gruxi de Nostra Signora. Nell’intervista è stata affrontata anche la questione del cocchio, che ha generato conflitti all’interno della comunità: inizialmente si desiderava collocarlo all’interno della chiesa, ma ciò non fu consentito. Attualmente, per questo motivo, il cocchio è custodito in un garage, mentre presso la parrocchia di San Giovanni Battista è conservato un cocchio in miniatura. Infine, la docente ha ricordato come in passato gli abitanti del paese ritenessero che il culto della Madonna d’Itria esistesse solo a Villamar, mentre studi successivi hanno dimostrato la sua diffusione in altri centri della Sardegna. L’intervista si conclude con l’autorizzazione della docente a pubblicare l’intervista per fini di studio e di ricerca.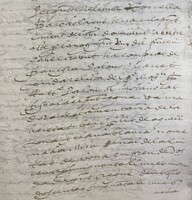 Schiavi che usano la schiavitù Nelle vicende di mobilità che conduce alla libertà possiamo trovare casi in cui gli schiavi stessi, inevitabilmente, partecipano delle dinamiche commerciali di quel sistema oppressivo dal quale sono per primi soggiogati: acquistano schiavi loro stessi sia per liberarli, sia per riuscire a liberare se stessi. Alcuni esempi della prima fattispecie possiamo ritrovarli nel caso di di Amet Decoll di Annaba che, nel 1619, acquista la schiava Fatima da don Angel dela Bronda con l’intento di affrancarla, e anche nell’acquisto di Mira da parte di Melchior Torrella su commissione dello schiavo Monço ha lo stesso intento. Amet Decoll e Monço in qualche modo sono parte del meccanismo di possesso delle persone. Acquistare (o, nel secondo caso, far acquistare) Fatima e Mira come schiave è un modo per poterle liberare. Si servono dell’istituto schiavile stesso come mezzo per ottenerne la cessazione. La vicenda di Amet di Annaba è ancora più singolare. Nel 1615 vive da alcuni anni al servizio della nobile Ysabel Alagon e Requesens, marchesa di Villasor e vedova di Martino Alagon. Determinato a riconquistare la libertà, con una piccola somma di denaro elabora un piano ingegnoso. Tratta con donna Ysabel, che inizialmente rifiuta di lasciarlo andare, probabilmente per non rinunciare al suo servizio. Amet decide di aggirare il rifiuto. Si reca al porto durante un'asta pubblica e compra un altro schiavo, anch'egli chiamato Amet e proveniente da Annaba. Amet offre il nuovo schiavo a donna Ysabel, proponendolo in cambio della sua libertà. La marchesa accetta. Amet rappresenta un esempio di riappropriazione della dignità individuale. La sua vicenda mostra una sintesi tra integrazione nella società ospitante e determinazione personale. Da un lato, riesce a stabilire legami lavorativi che gli permettono di guadagnare denaro; dall'altro, dimostra capacità di negoziazione, giungendo a compromessi sia con la padrona che con chi gli vende un altro schiavo. Amet sfrutta ogni risorsa a disposizione con astuzia, intraprendenza e una certa dose di spregiudicatezza. Utilizza infatti la schiavitù come strumento di liberazione, sostituendosi con un altro schiavo per migliorare la propria condizione. È “complice” del meccanismo di privazione della libertà. Rompe la schiavitù, ma lo fa deliberatamente a spese di un altro come lui. In altri casi, invece, gli schiavi usano la schiavitù per trarre profitto, come nel caso di Salem Desfachs. Egli viene pagato da Hagemusa, schiavo del viceré Calatayud, affinché faccia da garante durante il suo viaggio in patria, dove deve trovare il denaro necessario per riscattarsi dalla schiavitù. Questi e altri casi mostrano la complessità del fenomeno schiavile e, per la prima volta, fanno emergere il ruolo attivo e contraddittorio degli schiavi nel sistema stesso.
Schiavi che usano la schiavitù Nelle vicende di mobilità che conduce alla libertà possiamo trovare casi in cui gli schiavi stessi, inevitabilmente, partecipano delle dinamiche commerciali di quel sistema oppressivo dal quale sono per primi soggiogati: acquistano schiavi loro stessi sia per liberarli, sia per riuscire a liberare se stessi. Alcuni esempi della prima fattispecie possiamo ritrovarli nel caso di di Amet Decoll di Annaba che, nel 1619, acquista la schiava Fatima da don Angel dela Bronda con l’intento di affrancarla, e anche nell’acquisto di Mira da parte di Melchior Torrella su commissione dello schiavo Monço ha lo stesso intento. Amet Decoll e Monço in qualche modo sono parte del meccanismo di possesso delle persone. Acquistare (o, nel secondo caso, far acquistare) Fatima e Mira come schiave è un modo per poterle liberare. Si servono dell’istituto schiavile stesso come mezzo per ottenerne la cessazione. La vicenda di Amet di Annaba è ancora più singolare. Nel 1615 vive da alcuni anni al servizio della nobile Ysabel Alagon e Requesens, marchesa di Villasor e vedova di Martino Alagon. Determinato a riconquistare la libertà, con una piccola somma di denaro elabora un piano ingegnoso. Tratta con donna Ysabel, che inizialmente rifiuta di lasciarlo andare, probabilmente per non rinunciare al suo servizio. Amet decide di aggirare il rifiuto. Si reca al porto durante un'asta pubblica e compra un altro schiavo, anch'egli chiamato Amet e proveniente da Annaba. Amet offre il nuovo schiavo a donna Ysabel, proponendolo in cambio della sua libertà. La marchesa accetta. Amet rappresenta un esempio di riappropriazione della dignità individuale. La sua vicenda mostra una sintesi tra integrazione nella società ospitante e determinazione personale. Da un lato, riesce a stabilire legami lavorativi che gli permettono di guadagnare denaro; dall'altro, dimostra capacità di negoziazione, giungendo a compromessi sia con la padrona che con chi gli vende un altro schiavo. Amet sfrutta ogni risorsa a disposizione con astuzia, intraprendenza e una certa dose di spregiudicatezza. Utilizza infatti la schiavitù come strumento di liberazione, sostituendosi con un altro schiavo per migliorare la propria condizione. È “complice” del meccanismo di privazione della libertà. Rompe la schiavitù, ma lo fa deliberatamente a spese di un altro come lui. In altri casi, invece, gli schiavi usano la schiavitù per trarre profitto, come nel caso di Salem Desfachs. Egli viene pagato da Hagemusa, schiavo del viceré Calatayud, affinché faccia da garante durante il suo viaggio in patria, dove deve trovare il denaro necessario per riscattarsi dalla schiavitù. Questi e altri casi mostrano la complessità del fenomeno schiavile e, per la prima volta, fanno emergere il ruolo attivo e contraddittorio degli schiavi nel sistema stesso. La società cagliaritana e gli schiavi: gli uomini del mare Corsari e mercanti sono figure chiave nell’esperienza schiavile mediterranea. Attraverso essi si instaurano il dialogo e le connessioni più concreti tra la Sardegna e l’esterno. Versatili, capaci di adattamento e di gestire affari in due “mondi” diversi e opposti, con linguaggi verbali, culturali e sociali diversi. I corsari sono i primi a guadagnare dalla merce umana, sono i principali responsabili del traffico di schiavi e rappresentano il loro canale di ingresso nel Regno e nel circuito di mercato. L’efficacia del loro ruolo dipende, nelle fasi di cattura, dalla scaltrezza, dalla rapidità e dalla forza che possono mettere in campo e, successivamente, dalla capacità contrattuale e dalla fermezza che impiegano nel negoziare con le autorità e con gli acquirenti per ottenere il massimo profitto dalle proprie prede. D’altra parte, i mercanti rivestono una posizione altrettanto significativa non solo nelle compravendite, ma anche e soprattutto nelle operazioni di riscatto degli schiavi. Operano come intermediari nelle complesse transazioni di redenzione, parallelamente ai noti ordini religiosi dediti a questa attività1. Per il successo nel big business2 dei riscatti, sono indispensabili non solo le risorse economiche per finanziare viaggi, mobilitare persone e far circolare denaro, ma anche una solida abilità di negoziazione e una rete di relazioni ben sviluppata. A Cagliari, nel primo Seicento, sono presenti molti corsari naturals, ma sono soprattutto i forestieri a svolgere questa professione del mare. Valenzani, maiorchini, francesi, maltesi, napoletani e siciliani. Analizzare le relazioni di cui sono protagonisti permette di ampliare la comprensione della società, conoscendo anche quei nomi che, pur implicati nella vicenda, sfuggono all’analisi delle connessioni più rilevanti. Tante persone, infatti, emergono nelle nostre fonti per aver acquistato anche un solo schiavo, ma ciò non nega la loro rilevanza in un discorso generale di movimento di captivi nella società. Anche i singoli atti di acquisto contribuiscono a tracciare una mappa sociale più complessa e interconnessa. I corsari di maggior successo sono Andreu de Lorca, definito ora maiorchino e ora valenzano, attivo dal 1600 al 1617, e Guillelm Prevost, francese, attivo nei primi anni del secolo. Secondo le fonti che abbiamo potuto esaminare, i due catturano e vendono circa cento schiavi entrando in contatto, rispettivamente, con cinquantadue e quarantasette acquirenti. A queste si aggiungono le interazioni con gli ufficiali implicati nella gestione dei pubblici incanti: il Procuratore Reale, il Procuratore Fiscale, il Maestro Razionale e il Pubblico Corridore, spesso protagonisti anche come compratori. Tra i nomi degli acquirenti ritroviamo principalmente personalità eminenti di estrazione soprattutto locale: nobili e ufficiali reali, letrados, canonici, dottori della Reale Udienza insieme a mercanti e notai. Anche per Miquel Mitzavilla, maiorchino, e Barthomeu Didià, francese, riscontriamo una discreta attività nel 1632 e nel 1633. Vendono ventuno schiavi ciascuno ad altrettanti acquirenti. Tra costoro, molti sono protagonisti del commercio di persone già trent’anni prima, come don Pau di Castelvì e don Gaspar Pira, i canonici Simo Montanacho e Melchior Pirella; troviamo nuovi esponenti di famiglie già note che continuano la "tradizione" di possesso di schiavi avviata all'inizio del secolo, come i Fortesa e i Capay, dottori in in legge, i dela Matta, i Bonfant, famiglia di notai; vi sono, infine, personalità che appaiono per la prima volta nella nostra ricerca, come don Joan Dexart, dottore in leggi, avvocato e giudice della Reale Udienza, il dottor Antoni Sauni, il dottor Matheo Benedeto, i canonici Pere Folgiari e Lorens Sampero, i mercanti Sisinni Geruna e Diego Alonço. Altri corsari attivi ma meno documentati sono Juan Maltes e Miquel Matos, dei quali non conosciamo la provenienza, Bathomeu Torres, maiorchino, Paulo Pilicato, trapanese abitante nell’appendice cagliaritana di Lapola, Francesch Bramon, Andreu Gisbert e Jean Baptiste Lalgin, francesi. Gli ultimi tre operano all’inizio del secolo, nel 1600, 1602 e 1603. Ad acquistare i gli schiavi catturati da loro sono soprattutto grandi personalità del Regno: don Pedro de Castelvì, don Hieroni Delitala di Alghero, il dottore in medicina Joan Antoni Sanna, il viceré conte d’Elda, don Joan Naharro de Ruecas, il dottor Mostallino e Juan Antoni Martì, mercante. Pilicato è attivo tra il 1617 e il 1619 e vende sei schiavi a don Pau de Ravaneda e al mercante Augustin Regestra. Lo ritroviamo alcuni anni dopo, nel 1638, a sua volta schiavo a Tunisi nelle mani di Sidi Atias. Pilicato dà procura a tale Mateo Farere, anche lui trapanese, per recuperare alcuni crediti e, con quel denaro, riscattarlo. Torres, infine, va in corso nel 1633 e 1634 e vende tre schiavi a Juan Font, Joan Luis Fiorillo e al canonico Thomas Rachis. Alcuni altri corsari compaiono una sola volta nella documentazione, ma la loro attività da conto della vivacità di Cagliari come porto corsaro nel Seicento. Si tratta di Joan Arbizola, maiorchino, Paulo de Vicco, napoletano, Gabriel Hernandez, siciliano, Llorens Soliman e Monserrat de Lorca, maiorchini, Steve Già, genovese, Hercules Velle, maltese, Ugues Athenos, francese, Baptista Brumeo, Damian Domingo Lian, Joan Veloto, Nicolao Justiniano e Bernardo Beltran di provenienza sconosciuta, Joan Pere Masala e Jaume Sala, sardi, e diversi altri. Gli schiavi sono una merce tra le tante, venduta, scambiata e trasportata. Per questo parrà normale constatare come anche molti mercanti, uomini di mare che spesso sono anche patroni di imbarcazioni, siano implicati nella loro compravendita, in attività creditizie e di riscatto, o in attività commerciali. Come nel caso dei corsari, si tratta soprattutto di uomini forestieri, spesso domiciliati nelle appendici di Cagliari, Lapola e Stampace. Non manca qualche autoctono. Miquel Vidal, maiorchino, è proprietario di almeno tre schiavi, Soliman, Aly Badari e Fatima. Il primo viene acquistato al pubblico incanto da Andreu de Lorca, il secondo gli viene venduto da un altro mercante, Alexi Picasso, mentre sulla terza non abbiamo a disposizione questo dato. Vidal entra in relazione con Salem Desfachs e Baptista Baldo, nel 1606, per la commissione di un riscatto in Nordafrica. Anche il cagliaritano Miquel Calabres entra in contatto con Salem Desfachs e Amet di Tripoli attraverso uno dei quattro schiavi che possiede. I due liberti gli consegnano il denaro che il suo schiavo David Jucu deve pagare per essere affrancato. Nicolò Derouche, mercante residente a Cagliari negli anni Trenta e Quaranta del Seicento, si ritaglia il suo protagonismo nella vicenda schiavile occupandosi di alcuni riscatti di musulmani in Sardegna. Il primo è Mahamet Cherif, il quale consegna a Derouche il denaro per pagare il proprio riscatto, denaro che ha ricevuto in prestito da un altro schiavo musulmano. Derouche, ancora, riceve da Rais Ayet, moro di Biserta, il denaro necessario per riscattare due bistertini in prigionia a Cagliari, di nome Abdelatif e Abraham Rassit. Infine, riceve da Marina Hienone, ebrea, venti pezzi da otto reali per riscattare, a Cagliari, Moussa, figlio della donna, schiavo di Joan Caulcer, mercante maiorchino. Un personaggio ricorrente nelle fonti è il patrone di Torre del Greco Salvator Izzo, un “ingranaggio” rilevante nella macchina della schiavitù non solo a Cagliari, ma anche al di fuori. Oltre che occuparsi di prestare denaro ad alcuni schiavi perché possano pagare il proprio affrancamento, è piuttosto attivo in operazioni di riscatto di schiavi sardi, siciliani, calabresi e napoletani in Nordafrica, specificamente a Tunisi. Riceve una commissione da Joan Antoni Marti, anch’egli mercante abitante a Cagliari, per occuparsi del riscatto del frate Cherubi Pichiotta, calabrese schiavo a Tunisi18. Izzo si occupa anche del secondo riscatto di Baptista Morvillo, schiavo a Tunisi, e di quelli del frate siciliano Francesco Francavalli e di Giuseppe Pancrazzi. È probabile che Izzo metta in piedi una sorta di rete di prestiti e crediti, in quanto troviamo almeno tre testimonianze di crediti aperti nei suoi confronti da parte di Raffaello Francesco di Marsiglia, Guglielmo Martino di Maiorca, e Hugues Changet, console francese.
La società cagliaritana e gli schiavi: gli uomini del mare Corsari e mercanti sono figure chiave nell’esperienza schiavile mediterranea. Attraverso essi si instaurano il dialogo e le connessioni più concreti tra la Sardegna e l’esterno. Versatili, capaci di adattamento e di gestire affari in due “mondi” diversi e opposti, con linguaggi verbali, culturali e sociali diversi. I corsari sono i primi a guadagnare dalla merce umana, sono i principali responsabili del traffico di schiavi e rappresentano il loro canale di ingresso nel Regno e nel circuito di mercato. L’efficacia del loro ruolo dipende, nelle fasi di cattura, dalla scaltrezza, dalla rapidità e dalla forza che possono mettere in campo e, successivamente, dalla capacità contrattuale e dalla fermezza che impiegano nel negoziare con le autorità e con gli acquirenti per ottenere il massimo profitto dalle proprie prede. D’altra parte, i mercanti rivestono una posizione altrettanto significativa non solo nelle compravendite, ma anche e soprattutto nelle operazioni di riscatto degli schiavi. Operano come intermediari nelle complesse transazioni di redenzione, parallelamente ai noti ordini religiosi dediti a questa attività1. Per il successo nel big business2 dei riscatti, sono indispensabili non solo le risorse economiche per finanziare viaggi, mobilitare persone e far circolare denaro, ma anche una solida abilità di negoziazione e una rete di relazioni ben sviluppata. A Cagliari, nel primo Seicento, sono presenti molti corsari naturals, ma sono soprattutto i forestieri a svolgere questa professione del mare. Valenzani, maiorchini, francesi, maltesi, napoletani e siciliani. Analizzare le relazioni di cui sono protagonisti permette di ampliare la comprensione della società, conoscendo anche quei nomi che, pur implicati nella vicenda, sfuggono all’analisi delle connessioni più rilevanti. Tante persone, infatti, emergono nelle nostre fonti per aver acquistato anche un solo schiavo, ma ciò non nega la loro rilevanza in un discorso generale di movimento di captivi nella società. Anche i singoli atti di acquisto contribuiscono a tracciare una mappa sociale più complessa e interconnessa. I corsari di maggior successo sono Andreu de Lorca, definito ora maiorchino e ora valenzano, attivo dal 1600 al 1617, e Guillelm Prevost, francese, attivo nei primi anni del secolo. Secondo le fonti che abbiamo potuto esaminare, i due catturano e vendono circa cento schiavi entrando in contatto, rispettivamente, con cinquantadue e quarantasette acquirenti. A queste si aggiungono le interazioni con gli ufficiali implicati nella gestione dei pubblici incanti: il Procuratore Reale, il Procuratore Fiscale, il Maestro Razionale e il Pubblico Corridore, spesso protagonisti anche come compratori. Tra i nomi degli acquirenti ritroviamo principalmente personalità eminenti di estrazione soprattutto locale: nobili e ufficiali reali, letrados, canonici, dottori della Reale Udienza insieme a mercanti e notai. Anche per Miquel Mitzavilla, maiorchino, e Barthomeu Didià, francese, riscontriamo una discreta attività nel 1632 e nel 1633. Vendono ventuno schiavi ciascuno ad altrettanti acquirenti. Tra costoro, molti sono protagonisti del commercio di persone già trent’anni prima, come don Pau di Castelvì e don Gaspar Pira, i canonici Simo Montanacho e Melchior Pirella; troviamo nuovi esponenti di famiglie già note che continuano la "tradizione" di possesso di schiavi avviata all'inizio del secolo, come i Fortesa e i Capay, dottori in in legge, i dela Matta, i Bonfant, famiglia di notai; vi sono, infine, personalità che appaiono per la prima volta nella nostra ricerca, come don Joan Dexart, dottore in leggi, avvocato e giudice della Reale Udienza, il dottor Antoni Sauni, il dottor Matheo Benedeto, i canonici Pere Folgiari e Lorens Sampero, i mercanti Sisinni Geruna e Diego Alonço. Altri corsari attivi ma meno documentati sono Juan Maltes e Miquel Matos, dei quali non conosciamo la provenienza, Bathomeu Torres, maiorchino, Paulo Pilicato, trapanese abitante nell’appendice cagliaritana di Lapola, Francesch Bramon, Andreu Gisbert e Jean Baptiste Lalgin, francesi. Gli ultimi tre operano all’inizio del secolo, nel 1600, 1602 e 1603. Ad acquistare i gli schiavi catturati da loro sono soprattutto grandi personalità del Regno: don Pedro de Castelvì, don Hieroni Delitala di Alghero, il dottore in medicina Joan Antoni Sanna, il viceré conte d’Elda, don Joan Naharro de Ruecas, il dottor Mostallino e Juan Antoni Martì, mercante. Pilicato è attivo tra il 1617 e il 1619 e vende sei schiavi a don Pau de Ravaneda e al mercante Augustin Regestra. Lo ritroviamo alcuni anni dopo, nel 1638, a sua volta schiavo a Tunisi nelle mani di Sidi Atias. Pilicato dà procura a tale Mateo Farere, anche lui trapanese, per recuperare alcuni crediti e, con quel denaro, riscattarlo. Torres, infine, va in corso nel 1633 e 1634 e vende tre schiavi a Juan Font, Joan Luis Fiorillo e al canonico Thomas Rachis. Alcuni altri corsari compaiono una sola volta nella documentazione, ma la loro attività da conto della vivacità di Cagliari come porto corsaro nel Seicento. Si tratta di Joan Arbizola, maiorchino, Paulo de Vicco, napoletano, Gabriel Hernandez, siciliano, Llorens Soliman e Monserrat de Lorca, maiorchini, Steve Già, genovese, Hercules Velle, maltese, Ugues Athenos, francese, Baptista Brumeo, Damian Domingo Lian, Joan Veloto, Nicolao Justiniano e Bernardo Beltran di provenienza sconosciuta, Joan Pere Masala e Jaume Sala, sardi, e diversi altri. Gli schiavi sono una merce tra le tante, venduta, scambiata e trasportata. Per questo parrà normale constatare come anche molti mercanti, uomini di mare che spesso sono anche patroni di imbarcazioni, siano implicati nella loro compravendita, in attività creditizie e di riscatto, o in attività commerciali. Come nel caso dei corsari, si tratta soprattutto di uomini forestieri, spesso domiciliati nelle appendici di Cagliari, Lapola e Stampace. Non manca qualche autoctono. Miquel Vidal, maiorchino, è proprietario di almeno tre schiavi, Soliman, Aly Badari e Fatima. Il primo viene acquistato al pubblico incanto da Andreu de Lorca, il secondo gli viene venduto da un altro mercante, Alexi Picasso, mentre sulla terza non abbiamo a disposizione questo dato. Vidal entra in relazione con Salem Desfachs e Baptista Baldo, nel 1606, per la commissione di un riscatto in Nordafrica. Anche il cagliaritano Miquel Calabres entra in contatto con Salem Desfachs e Amet di Tripoli attraverso uno dei quattro schiavi che possiede. I due liberti gli consegnano il denaro che il suo schiavo David Jucu deve pagare per essere affrancato. Nicolò Derouche, mercante residente a Cagliari negli anni Trenta e Quaranta del Seicento, si ritaglia il suo protagonismo nella vicenda schiavile occupandosi di alcuni riscatti di musulmani in Sardegna. Il primo è Mahamet Cherif, il quale consegna a Derouche il denaro per pagare il proprio riscatto, denaro che ha ricevuto in prestito da un altro schiavo musulmano. Derouche, ancora, riceve da Rais Ayet, moro di Biserta, il denaro necessario per riscattare due bistertini in prigionia a Cagliari, di nome Abdelatif e Abraham Rassit. Infine, riceve da Marina Hienone, ebrea, venti pezzi da otto reali per riscattare, a Cagliari, Moussa, figlio della donna, schiavo di Joan Caulcer, mercante maiorchino. Un personaggio ricorrente nelle fonti è il patrone di Torre del Greco Salvator Izzo, un “ingranaggio” rilevante nella macchina della schiavitù non solo a Cagliari, ma anche al di fuori. Oltre che occuparsi di prestare denaro ad alcuni schiavi perché possano pagare il proprio affrancamento, è piuttosto attivo in operazioni di riscatto di schiavi sardi, siciliani, calabresi e napoletani in Nordafrica, specificamente a Tunisi. Riceve una commissione da Joan Antoni Marti, anch’egli mercante abitante a Cagliari, per occuparsi del riscatto del frate Cherubi Pichiotta, calabrese schiavo a Tunisi18. Izzo si occupa anche del secondo riscatto di Baptista Morvillo, schiavo a Tunisi, e di quelli del frate siciliano Francesco Francavalli e di Giuseppe Pancrazzi. È probabile che Izzo metta in piedi una sorta di rete di prestiti e crediti, in quanto troviamo almeno tre testimonianze di crediti aperti nei suoi confronti da parte di Raffaello Francesco di Marsiglia, Guglielmo Martino di Maiorca, e Hugues Changet, console francese. La società cagliaritana e gli schiavi: l'alto clero Anche gli arcivescovi e gli alti prelati partecipano attivamente agli scambi di schiavi. L’arcivescovo di Cagliari, Alonso Laso Sedeño, in carica tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento (1596-1604), è una delle figure più rilevanti. Uomo di grande prestigio, è abilitatore e trattatore dello stamento ecclesiastico nel Parlamento tenuto all’inizio del secolo dal viceré d’Elda. Nel 1603, il monsignore possiede cinque schiavi, quattro dei quali acquistati al pubblico incanto dal patrone Guillelm Prevost, mentre il quinto è il figlio di uno di loro. Subito dopo l’acquisto, Laso Sedeño battezza e cresima i suoi schiavi, e nei ruoli di padrini e madrine vengono scelte importanti personalità laiche e religiose, come la nobile donna Magdalena Portugues e Barbarà, baronessa di Posada, il canonico Joseph Laso, parente dell’arcivescovo, e i canonici Guerau de Pinna e Joan Thomas Caldentey. Il successore di Laso Sedeño è don Francisco d’Esquivell (in carica dal 1605 al 1624), il quale sembra possedere tre schiavi, uno dei quali acquistato al pubblico incanto dal corsaro francese Barthomeu Didià. Tra i padrini e madrine dei suoi captivi compaiono don Francisco Torrella, futuro barone di Capoterra, il canonico Miquel Claramont, e due figure di estrazione ignota: Maria Esprugas e Joan Gunallons. Infine, in merito a monsignor don Antonio Canopolo, arcivescovo di Arborea presente in Parlamento fino al 1614, ci sono pervenuti un atto di compravendita e uno di battesimo. Canopolo vende la sua schiava Portia a donna Ysabel Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon, e nel 1610 fa battezzare un suo schiavo nella chiesa di San Nicola di Sassari. A officiare il rito è il Vescovo di Bosa. Lo schiavo di Canopolo viene battezzato insieme uno schiavo di don Antonio Mulines. Padrino e madrina di entrambi gli schiavi sono don Enrico de Sena, governatore del capo di Sassari, e sua moglie. Tra i canonici, molti dei quali intervengono nello stamento ecclesiastico durante i Parlamenti del Regno, alcuni acquistano i loro schiavi direttamente dai corsari nelle pubbliche vendite all’asta: Salvador Soler, Jaume Spiga, Antoni Quença, Thomas Rachis, Augustì Murtas, Lorens Sampero. Altri sono implicati in compravendite con vari esponenti dell’élite. Ad esempio, il canonico Antoni Tola acquista una schiava mora da donna Hieronima Carta e Requesens, mentre il canonico Joan Meli, della cattedrale di Iglesias, tramite il proprio procuratore Jaume Hortola, acquista uno schiavo di nome Barca da Gavi Sasso, ex avvocato fiscale e patrimoniale del Regno. Barca viene utilizzato come moneta di scambio per la liberazione del fratello di Meli, Francesch, schiavo della madre di Barca in Nordafrica. Il canonico Vincent Baccallar è discretamente attivo nel possesso di schiavi. Per il battesimo di Joan Baptista, sceglie come padrino don Pere Portugues, barone di Posada, e come madrina la propria sorella donna Marchesa Baccallar. Il canonico a sua volta battezza una schiava del barone don Miquel Portugues e di sua moglie Madalena Portugues e Barbarà. La ricorrenza della famiglia Portugues indica una certa prossimità tra le due famiglie. Simon Montanacho, canonico e giudice di appello nel Regno, acquista uno schiavo dall’eredità dell’omologo Joan Sini, con cui sembra avere un rapporto di vicinanza visto l’intervento di entrambi come padrini dei rispettivi schiavi. Montanacho entra anche in contatto, tramite uno dei suoi schiavi, con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli, i due liberti le cui avventure sono contenute nel secondo capitolo. Bilcasser, schiavo del canonico, si impegna come creditore nei confronti dei due. Sini, infine, è legato al viceré don Calatayud, comparendo sia come officiante del battesimo di uno dei suoi schiavi, sia nel ruolo di padrino di un altro. In generale, sembra che anche gli alti prelati, come i viceré, preferiscano interagire prevalentemente con i notabili del Regno per quanto riguarda il possesso di schiavi. Il rapporto più frequentemente attestato tra loro e i nobili o gli ufficiali regi è quello di padrinaggio. Meno attestati sono gli atti di compravendita o altre tipologie di passaggio di schiavi. Sul piano spaziale, i legami restano principalmente locali, mentre sono i corsari, gli schiavi e i liberti a proiettare il Regno verso l’esterno, stabilendo connessioni con luoghi come la Francia, Maiorca, Malta e il Nord Africa.
La società cagliaritana e gli schiavi: l'alto clero Anche gli arcivescovi e gli alti prelati partecipano attivamente agli scambi di schiavi. L’arcivescovo di Cagliari, Alonso Laso Sedeño, in carica tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento (1596-1604), è una delle figure più rilevanti. Uomo di grande prestigio, è abilitatore e trattatore dello stamento ecclesiastico nel Parlamento tenuto all’inizio del secolo dal viceré d’Elda. Nel 1603, il monsignore possiede cinque schiavi, quattro dei quali acquistati al pubblico incanto dal patrone Guillelm Prevost, mentre il quinto è il figlio di uno di loro. Subito dopo l’acquisto, Laso Sedeño battezza e cresima i suoi schiavi, e nei ruoli di padrini e madrine vengono scelte importanti personalità laiche e religiose, come la nobile donna Magdalena Portugues e Barbarà, baronessa di Posada, il canonico Joseph Laso, parente dell’arcivescovo, e i canonici Guerau de Pinna e Joan Thomas Caldentey. Il successore di Laso Sedeño è don Francisco d’Esquivell (in carica dal 1605 al 1624), il quale sembra possedere tre schiavi, uno dei quali acquistato al pubblico incanto dal corsaro francese Barthomeu Didià. Tra i padrini e madrine dei suoi captivi compaiono don Francisco Torrella, futuro barone di Capoterra, il canonico Miquel Claramont, e due figure di estrazione ignota: Maria Esprugas e Joan Gunallons. Infine, in merito a monsignor don Antonio Canopolo, arcivescovo di Arborea presente in Parlamento fino al 1614, ci sono pervenuti un atto di compravendita e uno di battesimo. Canopolo vende la sua schiava Portia a donna Ysabel Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon, e nel 1610 fa battezzare un suo schiavo nella chiesa di San Nicola di Sassari. A officiare il rito è il Vescovo di Bosa. Lo schiavo di Canopolo viene battezzato insieme uno schiavo di don Antonio Mulines. Padrino e madrina di entrambi gli schiavi sono don Enrico de Sena, governatore del capo di Sassari, e sua moglie. Tra i canonici, molti dei quali intervengono nello stamento ecclesiastico durante i Parlamenti del Regno, alcuni acquistano i loro schiavi direttamente dai corsari nelle pubbliche vendite all’asta: Salvador Soler, Jaume Spiga, Antoni Quença, Thomas Rachis, Augustì Murtas, Lorens Sampero. Altri sono implicati in compravendite con vari esponenti dell’élite. Ad esempio, il canonico Antoni Tola acquista una schiava mora da donna Hieronima Carta e Requesens, mentre il canonico Joan Meli, della cattedrale di Iglesias, tramite il proprio procuratore Jaume Hortola, acquista uno schiavo di nome Barca da Gavi Sasso, ex avvocato fiscale e patrimoniale del Regno. Barca viene utilizzato come moneta di scambio per la liberazione del fratello di Meli, Francesch, schiavo della madre di Barca in Nordafrica. Il canonico Vincent Baccallar è discretamente attivo nel possesso di schiavi. Per il battesimo di Joan Baptista, sceglie come padrino don Pere Portugues, barone di Posada, e come madrina la propria sorella donna Marchesa Baccallar. Il canonico a sua volta battezza una schiava del barone don Miquel Portugues e di sua moglie Madalena Portugues e Barbarà. La ricorrenza della famiglia Portugues indica una certa prossimità tra le due famiglie. Simon Montanacho, canonico e giudice di appello nel Regno, acquista uno schiavo dall’eredità dell’omologo Joan Sini, con cui sembra avere un rapporto di vicinanza visto l’intervento di entrambi come padrini dei rispettivi schiavi. Montanacho entra anche in contatto, tramite uno dei suoi schiavi, con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli, i due liberti le cui avventure sono contenute nel secondo capitolo. Bilcasser, schiavo del canonico, si impegna come creditore nei confronti dei due. Sini, infine, è legato al viceré don Calatayud, comparendo sia come officiante del battesimo di uno dei suoi schiavi, sia nel ruolo di padrino di un altro. In generale, sembra che anche gli alti prelati, come i viceré, preferiscano interagire prevalentemente con i notabili del Regno per quanto riguarda il possesso di schiavi. Il rapporto più frequentemente attestato tra loro e i nobili o gli ufficiali regi è quello di padrinaggio. Meno attestati sono gli atti di compravendita o altre tipologie di passaggio di schiavi. Sul piano spaziale, i legami restano principalmente locali, mentre sono i corsari, gli schiavi e i liberti a proiettare il Regno verso l’esterno, stabilendo connessioni con luoghi come la Francia, Maiorca, Malta e il Nord Africa.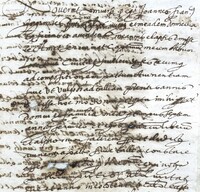 La società cagliaritana e gli schiavi: gli ufficiali regi Ai più alti livelli istituzionali e amministrativi del Regno, molti esponenti sono attivi nel commercio e nel possesso di schiavi. La famiglia Soler, di origini barcellonesi, si distingue in Sardegna col canonico Salvador, con Gaspar e con Pere Joan. Gaspar Soler, dottore in utroque iure del capitolo della Cattedrale di Cagliari e avvocato dello stamento ecclesiastico nel parlamento d’Elda, possiede un solo schiavo, acquistato dal corsaro Andreu de Lorca. È implicato personalmente nelle vendite all’asta di schiavi almeno nel 1604, agendo come delegato del procuratore reale don Nofre Fabra e Deixer. Pere Joan Soler è reggente la Reale Cancelleria, molto attivo nelle prime Corti del Seicento come abilitatore, trattatore, giudice dei gravami, rappresentante del viceré e ambasciatore di diversi ufficiali regi: tutti ruoli che favoriscono il dialogo e il contatto con i maggiori esponenti di tutti gli stamenti e con gli altri rappresentanti regi. Soler possiede diversi schiavi che acquista direttamente dai corsari de Lorca e Prevost e che vengono battezzati da personalità come Ysabel Soler, sua figlia, Juan Masons, giudice della Reale Udienza e il nobile don Joan Baptista Delitala; troviamo poi Nicolau Sart, Antioga Paisana, levatrice, Miquel Atzeni e Catelina Xanquir, tutti di estrazione sociale non rilevabile. Soler ricopre anche il ruolo di padrino insieme a donna Marianna Deixer e Castelvì, marchesa di Cea e moglie di don Pau de Castelvì, nel battesimo di Joan Thomas de Santa Creu, il giovane musulmano recatosi a Cagliari dalla Barberia per diventare cristiano. Un altro esempio significativo di protagonismo nella vicenda schiavile è rappresentato da don Joan Naharro de Ruecas, reggente della Tesoreria Generale del Regno. Nel 1599, acquisisce il titolo nobiliare e da quel momento partecipa attivamente ai Parlamenti del Regno, cooperando con figure chiave come i viceré don Anton Coloma o don Carlos de Borja, gli altri ufficiali regi e i principali rappresentanti dei tre stamenti. Tra il 1601 e il 1612, don Joan possiede almeno quattordici schiavi e, attraverso la documentazione che li riguarda, possiamo ricostruire alcuni dei contatti sociali. Acquista quattro schiavi dai corsari Andreu de Lorca, Jean Baptiste Lalgin e Guillelm Prevost e uno da don Christofol Centelles. Il suo captivo Amet di Annaba si interfaccia con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli per chiedere loro un prestito di denaro per potersi riscattare. I due creditori consegnano a don Juan duecentosettanta lire; per ripagare il debito. Amet si accorda poi con don Emanuel de Castelvì, componente dello stamento militare nei Parlamenti d’Elda e de Borja, ottenendo un secondo prestito dello stesso ammontare. Abdalla, altro degli schiavi di Ruecas, compare come garante in un contratto di taglia di un altro captivo, mettendo il suo padrone in contatto con i proprietari degli altri schiavi implicati nell’accordo: donna Joanna Castelvì e Amat e i giudici della Reale Udienza Joan Masons e Francesch Jagaracho. Lo schiavo Juan Francesco viene battezzato dai nobili don Augustin Baccallar e donna Catherina Naharro e Baccallar, i cui cognomi evidenziano l’esistenza di una parentela tra le due famiglie. Joana viene battezzata dallo stesso don Augustin Baccallar e da una tale Lucrecia Vaquer e viene cresimata dal canonico Miquel Claramont; Antiogo Francesco ha come padrino il dottor Salvador Carcassona, avvocato dello stamento militare nel parlamento d’Elda; Antonio viene battezzato da Joan Pullo, mentre Antiogo da Martin del Contado. Martin del Contado compare anche nel 1611 nella documentazione sulle galere conservata nell’Archivo General de Simancas. Le galere della squadra di Genova, condotte dal duca di Tursi Carlo I Doria del Carretto, arruolano dieci forzati da Milano e dal Regno di Sardegna. Tra questi ultimi compare Del Contado, condannato perpetuamente al remo. Francesch Jagaracho fa parte di una famiglia borghese sassarese, dedita alle professioni liberali. Nel primo Seicento è giudice della Reale Udienza e avvocato fiscale. Possiede almeno undici schiavi tra il 1603 e il 1611, quattro dei quali vengono acquistati in occasione delle pubbliche aste successive alle prese dei corsari De Lorca e Prevost. In occasione di un accordo di credito a vantaggio del suo schiavo Amet di Annaba, Jagaracho si interfaccia con donna Juanna Castelvì e Amat, padrona dello schiavo creditore, con il barone don Portugues e con il suo schiavo Scandaria, intervenuti come testimoni dell’atto. Un altra occasione di contatto con donna Juanna è la partecipazione dello schiavo Ali come garante per lo stesso atto di taglia cui partecipano Adalla di don Naharro de Ruecas e Ali del dottor Joan Masons. Infine vediamo nei rapporti di padrinaggio, ancora una volta, l’emersione di figure sconosciute e non meglio collocabili: Gavino Bonaventura ha come padrino Joan Francesc Corda, Maria viene battezzata da Angel de Andriola e da Catelina Jana, Joan Gavi da Marta Carta e da Joan Hieroni Pascanal. Monserrat Rossellò è un letrado, giudice della Reale Udienza e, alla fine del Cinquecento, visitador degli ufficiali del Regno. Come i due precedenti, si trova in grande prossimità con i grandi nobili, ecclesiastici e con i principali protagonisti dell’amministrazione del Regno per via della comune partecipazione ai Parlamenti. Rossellò acquista due schiavi nel 1604 da una presa del corsaro francese Prevost, e altri due nel 1606 da Miquel Roca, quarto consigliere della città di Cagliari, e da don Augustin Baccallar, nobile. I due schiavi vengono utilizzati da Rossellò come moneta di scambio per liberare un frate di nome Arcangel Daviso Capretzi, schiavo “in potere degli infedeli” nella città di Biserta. Tra i dottori della Reale Udienza troviamo anche Joan Masons, attivo protagonista dei Parlamenti fino alla prima riunione del XVII secolo. Avvocato del Regio Patrimonio, giudice della Reale Udienza, dottore in leggi, sindaco e avvocato della città di Oristano, presente prima nello stamento reale e poi in quello militare. I canali di scambio attivati dal possesso di schiavi sembrano restare sostanzialmente nell’ambito delle interazioni parlamentari. Tra compravendite, battesimi e fideiussioni sono coinvolti il corsaro Andreu de Lorca, donna Joanna Castelvì e Amat, Melchior Torrella e i mercanti genovesi residenti a Cagliari Joan Costa e Pere Morteo; ancora, il Reggente Pere Joan Soler, il dottor Angel Jagaracho, Gracia Quença e Santoru, Miquel Angel Bonfant, notaio, il reverendo Pau Sanna e Balthasara Bonfant e Masons. Quest’ultimo cognome mostra l’esistenza di una parentela tra la famiglia del giudice Masons e quella dei notai Bonfant. Anche la famiglia Palou è discretamente presente nelle fonti come proprietaria di schiavi, con Joan Antoni Palou e sua moglie Francisca Palou e Garcet. Gli atti ritrovati parlano di acquisti, vendite e affrancamenti, oltre che dell’intervento di uno dei loro schiavi come garante in un atto di taglia. Si tratta di accordi nei quali sono protagonisti Pere Blancafort, consigliere municipale di Cagliari, i nobili don Gaspar de Requesens e don Joan Baptista Zatrillas e i mercanti Miquel Calabres, Gaspar Bonato e Andria Materano. I Palou non risultano attestati nella fonte parrocchiale e sembra, dunque, non intervengano in occasione di battesimi e cresime, né come padroni di schiavi cristianizzati né come padrino e madrina di schiavi altrui. Un altro protagonista istituzionale del Regno è Joan Francisco Jorgi, convocato nello stamento militare dei Parlamenti Aytona (1592-1594) ed Elda (1602-1603). È consigliere civico di Cagliari per diverse volte, podestà nel 1606 e, in Parlamento, svolge il ruolo di procuratore del feudo di Quirra e di diversi esponenti dell’élite del capo di Sassari. Jorgi possiede numerosi schiavi ed è una figura ricorrente nella nostra ricerca. Attraverso le vicende riguardanti i suoi captivi, possiamo individuare alcuni legami parentali. È sposato con Angela Cascali, componente di una famiglia che, attraverso il matrimonio della sorella Sperantia con don Melchior Torrella, si lega ai nobili baroni di Capoterra. La moglie di Jorgi, i cognati, donna Sperantia e don Melchiorre, e i nipoti, donna Magdalena e don Francesch Torrella sono molto presenti nelle tappe dell’esperienza schiavile dell’uomo. Compaiono spesso come padrini e madrine di battesimo e di cresima degli schiavi, insieme a personalità come il protomedico Joan Andreu, il canonico Spiga, don Pere Portugues e il canonico Miquel Gessa. La cognata Sperantia e la nipote Magdalena sono anche le destinatarie della donazione di due schiave da parte di Jorgi che, alla fine della sua vita, lascia tutti gli schiavi che possiede a sua moglie Angela, comprese le due precedentemente donate alle Torrella. Gli accordi di compravendita che Joan Francisco Jorgi stringe lo mettono in relazione con il corsaro Guillelm Prevost ed evidenziano rapporti con la famiglia Carrillo nella persona di don Joan, e Montelles, con don Salvador. Alla morte di Joan Francisco, sua moglie Angela si trova a gestire gli schiavi ereditati e decide di liberarne la maggior parte. La schiava Xarifa paga ad Angela Jorgi e Cascali centocinquanta lire per il proprio riscatto, denaro che viene consegnato alla padrona da Amet di Annaba, schiavo appartenuto a Miquel Calabres, mercante di Cagliari. La vedova Jorgi compare anche come madrina di battesimo di uno schiavo di don Melchior Torrella, suo cognato.
La società cagliaritana e gli schiavi: gli ufficiali regi Ai più alti livelli istituzionali e amministrativi del Regno, molti esponenti sono attivi nel commercio e nel possesso di schiavi. La famiglia Soler, di origini barcellonesi, si distingue in Sardegna col canonico Salvador, con Gaspar e con Pere Joan. Gaspar Soler, dottore in utroque iure del capitolo della Cattedrale di Cagliari e avvocato dello stamento ecclesiastico nel parlamento d’Elda, possiede un solo schiavo, acquistato dal corsaro Andreu de Lorca. È implicato personalmente nelle vendite all’asta di schiavi almeno nel 1604, agendo come delegato del procuratore reale don Nofre Fabra e Deixer. Pere Joan Soler è reggente la Reale Cancelleria, molto attivo nelle prime Corti del Seicento come abilitatore, trattatore, giudice dei gravami, rappresentante del viceré e ambasciatore di diversi ufficiali regi: tutti ruoli che favoriscono il dialogo e il contatto con i maggiori esponenti di tutti gli stamenti e con gli altri rappresentanti regi. Soler possiede diversi schiavi che acquista direttamente dai corsari de Lorca e Prevost e che vengono battezzati da personalità come Ysabel Soler, sua figlia, Juan Masons, giudice della Reale Udienza e il nobile don Joan Baptista Delitala; troviamo poi Nicolau Sart, Antioga Paisana, levatrice, Miquel Atzeni e Catelina Xanquir, tutti di estrazione sociale non rilevabile. Soler ricopre anche il ruolo di padrino insieme a donna Marianna Deixer e Castelvì, marchesa di Cea e moglie di don Pau de Castelvì, nel battesimo di Joan Thomas de Santa Creu, il giovane musulmano recatosi a Cagliari dalla Barberia per diventare cristiano. Un altro esempio significativo di protagonismo nella vicenda schiavile è rappresentato da don Joan Naharro de Ruecas, reggente della Tesoreria Generale del Regno. Nel 1599, acquisisce il titolo nobiliare e da quel momento partecipa attivamente ai Parlamenti del Regno, cooperando con figure chiave come i viceré don Anton Coloma o don Carlos de Borja, gli altri ufficiali regi e i principali rappresentanti dei tre stamenti. Tra il 1601 e il 1612, don Joan possiede almeno quattordici schiavi e, attraverso la documentazione che li riguarda, possiamo ricostruire alcuni dei contatti sociali. Acquista quattro schiavi dai corsari Andreu de Lorca, Jean Baptiste Lalgin e Guillelm Prevost e uno da don Christofol Centelles. Il suo captivo Amet di Annaba si interfaccia con Salem Desfachs di Tunisi e Amet di Tripoli per chiedere loro un prestito di denaro per potersi riscattare. I due creditori consegnano a don Juan duecentosettanta lire; per ripagare il debito. Amet si accorda poi con don Emanuel de Castelvì, componente dello stamento militare nei Parlamenti d’Elda e de Borja, ottenendo un secondo prestito dello stesso ammontare. Abdalla, altro degli schiavi di Ruecas, compare come garante in un contratto di taglia di un altro captivo, mettendo il suo padrone in contatto con i proprietari degli altri schiavi implicati nell’accordo: donna Joanna Castelvì e Amat e i giudici della Reale Udienza Joan Masons e Francesch Jagaracho. Lo schiavo Juan Francesco viene battezzato dai nobili don Augustin Baccallar e donna Catherina Naharro e Baccallar, i cui cognomi evidenziano l’esistenza di una parentela tra le due famiglie. Joana viene battezzata dallo stesso don Augustin Baccallar e da una tale Lucrecia Vaquer e viene cresimata dal canonico Miquel Claramont; Antiogo Francesco ha come padrino il dottor Salvador Carcassona, avvocato dello stamento militare nel parlamento d’Elda; Antonio viene battezzato da Joan Pullo, mentre Antiogo da Martin del Contado. Martin del Contado compare anche nel 1611 nella documentazione sulle galere conservata nell’Archivo General de Simancas. Le galere della squadra di Genova, condotte dal duca di Tursi Carlo I Doria del Carretto, arruolano dieci forzati da Milano e dal Regno di Sardegna. Tra questi ultimi compare Del Contado, condannato perpetuamente al remo. Francesch Jagaracho fa parte di una famiglia borghese sassarese, dedita alle professioni liberali. Nel primo Seicento è giudice della Reale Udienza e avvocato fiscale. Possiede almeno undici schiavi tra il 1603 e il 1611, quattro dei quali vengono acquistati in occasione delle pubbliche aste successive alle prese dei corsari De Lorca e Prevost. In occasione di un accordo di credito a vantaggio del suo schiavo Amet di Annaba, Jagaracho si interfaccia con donna Juanna Castelvì e Amat, padrona dello schiavo creditore, con il barone don Portugues e con il suo schiavo Scandaria, intervenuti come testimoni dell’atto. Un altra occasione di contatto con donna Juanna è la partecipazione dello schiavo Ali come garante per lo stesso atto di taglia cui partecipano Adalla di don Naharro de Ruecas e Ali del dottor Joan Masons. Infine vediamo nei rapporti di padrinaggio, ancora una volta, l’emersione di figure sconosciute e non meglio collocabili: Gavino Bonaventura ha come padrino Joan Francesc Corda, Maria viene battezzata da Angel de Andriola e da Catelina Jana, Joan Gavi da Marta Carta e da Joan Hieroni Pascanal. Monserrat Rossellò è un letrado, giudice della Reale Udienza e, alla fine del Cinquecento, visitador degli ufficiali del Regno. Come i due precedenti, si trova in grande prossimità con i grandi nobili, ecclesiastici e con i principali protagonisti dell’amministrazione del Regno per via della comune partecipazione ai Parlamenti. Rossellò acquista due schiavi nel 1604 da una presa del corsaro francese Prevost, e altri due nel 1606 da Miquel Roca, quarto consigliere della città di Cagliari, e da don Augustin Baccallar, nobile. I due schiavi vengono utilizzati da Rossellò come moneta di scambio per liberare un frate di nome Arcangel Daviso Capretzi, schiavo “in potere degli infedeli” nella città di Biserta. Tra i dottori della Reale Udienza troviamo anche Joan Masons, attivo protagonista dei Parlamenti fino alla prima riunione del XVII secolo. Avvocato del Regio Patrimonio, giudice della Reale Udienza, dottore in leggi, sindaco e avvocato della città di Oristano, presente prima nello stamento reale e poi in quello militare. I canali di scambio attivati dal possesso di schiavi sembrano restare sostanzialmente nell’ambito delle interazioni parlamentari. Tra compravendite, battesimi e fideiussioni sono coinvolti il corsaro Andreu de Lorca, donna Joanna Castelvì e Amat, Melchior Torrella e i mercanti genovesi residenti a Cagliari Joan Costa e Pere Morteo; ancora, il Reggente Pere Joan Soler, il dottor Angel Jagaracho, Gracia Quença e Santoru, Miquel Angel Bonfant, notaio, il reverendo Pau Sanna e Balthasara Bonfant e Masons. Quest’ultimo cognome mostra l’esistenza di una parentela tra la famiglia del giudice Masons e quella dei notai Bonfant. Anche la famiglia Palou è discretamente presente nelle fonti come proprietaria di schiavi, con Joan Antoni Palou e sua moglie Francisca Palou e Garcet. Gli atti ritrovati parlano di acquisti, vendite e affrancamenti, oltre che dell’intervento di uno dei loro schiavi come garante in un atto di taglia. Si tratta di accordi nei quali sono protagonisti Pere Blancafort, consigliere municipale di Cagliari, i nobili don Gaspar de Requesens e don Joan Baptista Zatrillas e i mercanti Miquel Calabres, Gaspar Bonato e Andria Materano. I Palou non risultano attestati nella fonte parrocchiale e sembra, dunque, non intervengano in occasione di battesimi e cresime, né come padroni di schiavi cristianizzati né come padrino e madrina di schiavi altrui. Un altro protagonista istituzionale del Regno è Joan Francisco Jorgi, convocato nello stamento militare dei Parlamenti Aytona (1592-1594) ed Elda (1602-1603). È consigliere civico di Cagliari per diverse volte, podestà nel 1606 e, in Parlamento, svolge il ruolo di procuratore del feudo di Quirra e di diversi esponenti dell’élite del capo di Sassari. Jorgi possiede numerosi schiavi ed è una figura ricorrente nella nostra ricerca. Attraverso le vicende riguardanti i suoi captivi, possiamo individuare alcuni legami parentali. È sposato con Angela Cascali, componente di una famiglia che, attraverso il matrimonio della sorella Sperantia con don Melchior Torrella, si lega ai nobili baroni di Capoterra. La moglie di Jorgi, i cognati, donna Sperantia e don Melchiorre, e i nipoti, donna Magdalena e don Francesch Torrella sono molto presenti nelle tappe dell’esperienza schiavile dell’uomo. Compaiono spesso come padrini e madrine di battesimo e di cresima degli schiavi, insieme a personalità come il protomedico Joan Andreu, il canonico Spiga, don Pere Portugues e il canonico Miquel Gessa. La cognata Sperantia e la nipote Magdalena sono anche le destinatarie della donazione di due schiave da parte di Jorgi che, alla fine della sua vita, lascia tutti gli schiavi che possiede a sua moglie Angela, comprese le due precedentemente donate alle Torrella. Gli accordi di compravendita che Joan Francisco Jorgi stringe lo mettono in relazione con il corsaro Guillelm Prevost ed evidenziano rapporti con la famiglia Carrillo nella persona di don Joan, e Montelles, con don Salvador. Alla morte di Joan Francisco, sua moglie Angela si trova a gestire gli schiavi ereditati e decide di liberarne la maggior parte. La schiava Xarifa paga ad Angela Jorgi e Cascali centocinquanta lire per il proprio riscatto, denaro che viene consegnato alla padrona da Amet di Annaba, schiavo appartenuto a Miquel Calabres, mercante di Cagliari. La vedova Jorgi compare anche come madrina di battesimo di uno schiavo di don Melchior Torrella, suo cognato. La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà Le casate che si distinguono maggiormente nell’esperienza schiavile sarda della prima metà del Seicento sono i Centelles, i Castelvì, i Requesens e i Torrella. Tra i nobili feudatari più potenti e importanti del Regno, troviamo don Christofol Centelles, prima conte e poi, dal 1603, marchese dello sconfinato feudo di Quirra. Don Christofor è attivo protagonista delle Corti del 1602-1603 in qualità di ambasciatore e trattatore dello stamento militare. È in stretto rapporto col viceré conte d’Elda e con i maggiori esponenti dei tre stamenti e della regia cort, come personalità delle famiglie Castelvì, Alagon, Zatrillas, Zapata, Aymerich, Fortesa, Masons, Baccallar, Requesens, Torrella. Dal 1602 al 1609 possiamo contare circa venti schiavi in suo possesso, molti dei quali acquistati direttamente durante i pubblici incanti delle prese corsare di Andreu de Lorca, Andreu Gisbert e Guillelm Prevost. Don Christofor ha la tendenza a battezzare e cresimare buona parte degli schiavi che possiede. I nomi dei padrini e delle madrine non sembrano rimandare, di norma, a famiglie della nobiltà. Tali famiglie emergono, invece, nel caso in cui sia Centelles a svolgere il ruolo di padrino o in occasione di compravendite private. All’inizio del secolo, don Christofor battezza uno schiavo del viceré Coloma insieme alla contessa di Laconi donna Anna de Castelvì e vende uno dei propri captivi a don Joan Naharro de Ruecas, Tesoriere Reale. Al proprio procuratore, Gaspar Cugia, ordina nel 1609 di occuparsi di ritrovare e ricondurre a casa Almanzor, schiavo fuggitivo. Cugia, a sua volta, delega il compito al proprio procuratore, il capitano del re Christofor Franco, palermitano abitante di Cagliari, anch’egli possessore di schiavi. Gaspar Cugia si occupa altresì di un’operazione di riscatto: troviamo una procura che Laurenso Pira, cittadino di Sassari schiavo di Sidi Hamida, dà a Cugia per occuparsi di procurare il denaro necessario alla sua liberazione dal padrone. Nello stesso anno il marchese si trasferisce nella sua città natale, Valencia, portando con sé almeno quattro schiavi. A presentarsi davanti al Bailo di Valencia per occuparsi degli adempimenti necessari al trasferimento dei captivi fuori dalla Sardegna è un altro procuratore di Centelles, Antoni Datos del Castillo, insieme al nobile don Hieroni Mercader il quale si assume la responsabilità di recarsi a Cagliari per trovare le carte patrimoniali che attestano l’avvenuto pagamento del quinto reale sugli schiavi. Dei contatti che è stato possibile ricostruire per don Christofol Centelles, una buona parte si intreccia al rapporto con Salem Desfachs, declinato prima nel binomio padrone-schiavo e poi evolutosi verso una collaborazione “professionale” dopo la sua liberazione. Ricordiamo, ad esempio, i patroni Joan Dale e Baptista Baldo, Honorat Rocafort e Spirit Pipin. Il caso del marchese di Quirra mostra una rete sociale “schiavile” che, più che sovrapporsi a quella “istituzionale”, prende nuove direzioni. Sottolinea un modo unico di sfruttare la schiavitù, almeno nel panorama della nostra ricerca. Centelles utilizza i suoi schiavi non solo durante il periodo vero e proprio di cattività, non solo per il lavoro forzato, non solo per il profitto delle vendite o dei riscatti. Porta avanti, invece, la strategia di utilizzarli anche successivamente, quando sono diventati uomini liberi, sfruttandone competenze, connessioni e abilità per il beneficio dei propri commerci. Possiamo ipotizzare che, da una parte, Salem sfrutti le conoscenze e le connessioni del marchese, ma che anche il marchese possa trarre vantaggio delle relazioni costruite autonomamente dal suo collaboratore. La spazialità che il network di Centelles disegna crea ponti tra Cagliari, Valencia, Biserta e altre città della Barberia e la Francia. Un cognome ricorrente e particolarmente noto nella storia della Sardegna è Castelvì. Si tratta di una famiglia feudale di origine valenzana che nel Regno di Sardegna forma tre rami: i marchesi di Laconi, i signori di Samassi e Serrenti e i marchesi di Cea, imparentandosi con altre grandi famiglie nobiliari e feudali. Gli uomini della famiglia sono tra i più eminenti membri dello stamento militare in Parlamento, svolgendo spesso il ruolo di rappresentanti, abilitatori, trattatori e giudici dei gravami, stringendo rapporti di prossimità con gli altri maggiori nobili e feudatari. La famiglia Castelvì si rende protagonista nella vicenda schiavile anche con le sue esponenti femminili. Don Jaume Castelvì tra il 1603 al 1617, tramite gli schiavi che possiede, entra in contatto con diverse personalità. Il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i quali gli consegnano il denaro del riscatto di uno dei suoi schiavi; Jaime de Aquena e Isabel Torres sono il padrino e la madrina uno “schiavetto”; lo schiavo Juan Baptista invece è battezzato da don Jaume stesso e da sua moglie, donna Anna de Castelvì; Juan Seraphi ha come padrini Salvador Caddeo, prete, e Joana Sorja; per Juan Jordi, invece, sono Jordi Jaquello e Rosa Marras. Al momento della cresima dello schiavo Pablo Zacharias, a fargli da padrino è Benitto Bravo. Donna Anna de Castelvì battezza, oltre a Juan Baptista, anche uno schiavo del viceré Coloma insieme al marchese di Quirra don Christofol Centelles. La donna possiede a sua volta due schiave: una battezzata da Nicolau Porxella, signore della villa di Serdiana e ambasciatore dello stamento militare nel parlamento d’Elda, e l’altra cresimata dal dottore in utroque iure Gaspar Pira. Don Francesco, visconte di Sanluri, al momento dell’ingresso nell’ordine dei padri cappuccini (nel 1607) lascia in eredità al fratello don Pau due schiavi che dovranno servire per quattro anni a suo beneficio e a beneficio di don Hieronim de Sena, sindaco della città di Alghero nel parlamento d’Elda, e di don Joan Sant Just, anche lui ripetutamente abilitato a partecipare alle Corti del Regno nello stamento militare. Don Francesco possiede un altro schiavo, Joan Baptista, che viene battezzato da Hieronima Sarroch e Castelvì, ed è anche padrino di battesimo di uno degli schiavi del nobile dottor Anton de Tola, anch’egli presente in Parlamento, insieme a Margalida Castañeda. Don Pau è cavaliere di San Giacomo e Procuratore Reale dal 1616, grazie alle nozze con donna Mariana Deixar, erede dell’ufficio per via del padre don Nofre Fabra e Deixar. Don Pau possiede diversi schiavi oltre a quelli ricevuti dal fratello, tra i quali Amet, acquistato dal corsaro Barthomeu Didià. Compare, poi, come padrino nel battesimo di uno schiavo del conte di Cuglieri insieme a donna Mariana. Altri esponenti della famiglia sono don Salvador de Castelvì che, per mezzo di Miquel Velasquez, intraprende un rapporto di compravendita col viceré Gandìa; donna Juana Castelvì e Amat dopo aver concesso una taglia allo schiavo Anasar, riceve la garanzia “fideiussoria” di altri tre schiavi dei quali sono padroni il dottor Juan Masons, don Juan Naharro de Ruecas e il dottor Francesch Jagaracho. Don Emanuel presta denaro allo schiavo Amet di proprietà di don Joan Naharro de Ruecas. Anche donna Mariana Castelvì e Deixar viene scelta come madrina: battezza una schiava di suo padre, don Nofre Fabra e Deixar, ed è madrina di cresima di Joan Thomas, il “negro venuto nella terra dei cristiani per farsi cristiano” con la cui storia famigliare si apre questo lavoro. I numerosi contatti d’alto rango della famiglia sono tendenzialmente locali e identificati nell’alta società nobile e borghese della città e del circondario. Fanno eccezione alcuni nomi non meglio ascrivibili a specifici ambiti o posizioni sociali e presenti in qualità di padrini e madrine. Rileviamo, in alcuni casi, il realizzarsi di scambi interni all’ambito famigliare. A proiettare la famiglia verso l’esterno sono il francese Didià, il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i valenciani viceré Coloma e marchese di Quirra, gli schiavi provenienti dal Nordafrica e dalla Polonia. A proposito di Joseph Caruso le fonti ci dicono che il suo protagonismo nel riscatto di schiavi non è circostanziale, ma una vera e propria attività “professionale”. Lo ritroviamo menzionato negli atti del consolato francese a Tunisi nel 1610, quando paga il riscatto di un uomo di Alicante schiavo a Tunisi di Ossoman Dey. Il riscatto avviene per volontà e su commissione di Miquel Vidal, mercante maiorchino residente a Cagliari. Caruso non manca, comunque, di possedere qualche schiavo: tra il 1603 e il 1608 è padrone almeno di tre. Un’altra famiglia che emerge nel possesso schiavi è quella dei Requesens. È una famiglia catalana trasferitasi a Cagliari, presente in Parlamento almeno dal 1592-1594 con diversi esponenti della famiglia ammessi nello stamento militare, tra cui don Gaspare. Nel primo Seicento, egli possiede diversi schiavi. Amet di Algeri, per esempio, è coinvolto come garante in un atto di taglia a favore di uno schiavo di Pere Blancafort, insieme ad altri due schiavi appartenenti al defunto Joan Antoni Palou e a Miquel Calabres. Tra gli altri schiavi vi sono Maria Francesca, battezzata da Juan Pere Requesens e Angela Taria, e Antonia Ela, battezzata da Leonart Uda e Francesca Serra. Gli ultimi quattro nomi, sconosciuti, non sono collocabili in alcun ambito sociale. Più attiva nell’ambito schiavile è donna Ysabel Requesens, o meglio Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon. Donna Ysabel, dal 1604 al 1616 possiede almeno dieci schiavi, alcuni dei quali protagonisti di eccezionali vicende personali. Tra i captivi che possiede troviamo Amet Bofetil di Biserta, il cui riscatto viene pagato a donna Ysabel dal patrone napoletano Salvator Izzo; Portia, che la donna acquista dall’arcivescovo di Arborea don Antonio Canopolo per mezzo del suo procuratore padre Hieronim Sanna, gesuita; Anastasia, la schiava poi affrancata che costruisce una famiglia con Joan Thomas de Santa Cruz: al loro matrimonio i testimoni sono Antiogo Lai e il reverendo Monserrat Baccallar, mentre a fare da padrino di confermazione alla loro figlia Catelina è chiamato Joan Miquel Carta; Anastasia ha anche un’altra figlia nata prima del matrimonio con Joan Thomas, che appartiene ai marchesi di Villasor e che viene battezzata col nome di Dionisa Isabela dal padrino Hieroni Pola e dalla madrina Maria Meli; infine, ricordiamo Axia, la schiava del commendatore Vintimilla che non risiede presso il padrone, ma nella dimora di donna Ysabel e che è implicata nella vicenda dell’avvelenamento del commendatore: questo fatto indica la sussistenza di un qualche rapporto tra la famiglia Alagon e Vintimilla. Ultima esponente della famiglia è Donna Hieronima Carta e Requesens, che vende due schiave al dottore in diritti Anton de Tola, canonico di Cagliari. Nel 1610 Miquel Angel Carta presta uno dei propri schiavi al figlio Joan Baptista perché lo assista e lo serva in un viaggio da Cagliari alla Castiglia passando per Valencia, a bordo della nave del patrone francese Uguet Steva. Giunti nella penisola iberica, a giurare sui documenti notarili che attestano la legittimità del possesso dello schiavo sono il marchese di Quirra don Christofol Centelles e Gaspar Feo, valenciano. I Requesens possono vantare numerosi contatti altisonanti, ai quali si affiancano nomi poco o per nulla noti. La spazialità tracciata da tali relazioni mette in collegamento la Sardegna con Napoli, con Valencia, con la Francia e con il Nordafrica. Infine, nella persona di don Melchiorr Torrella, barone di Capoterra, vediamo una chiara espressione dell’intreccio tra nobiltà, governo municipale e amministrazione cittadina, che trova nel possesso di schiavi un canale di consolidamento. Torrella, nobile, è implicato nel governo civico di Cagliari come consigliere capo nei primi anni del Seicento e rappresentante dello stamento reale nel parlamento d’Elda, abilitatore e trattatore, in cooperazione e vicinanza con i più alti rappresentanti delle istituzioni. Nella compravendita e nel possesso di schiavi troviamo interazioni con alcuni tra i principali ufficiali regi come Joan Masons, giudice della Reale Udienza, l’avvocato fiscale Joan Antoni Palou, e altri amministratori civici come Joan Francisco Jorgi, consigliere municipale. Altri contatti sono stretti con i mercanti Joan Costa, genovese, e Joan Angel Quessa, cagliaritano. Altri esponenti della famiglia Torrella, come visto precedentemente, sono implicati come padrini e madrine di schiavi e schiave della famiglia Jorgi, dell’arcivescovo D’Esquivell, del canonico Salvador Costanti, del consigliere civico Jaume Hortola e del barone di Orosei e Galtellì Fabrissio Manca e Guiso.
La società cagliaritana e gli schiavi: la nobiltà Le casate che si distinguono maggiormente nell’esperienza schiavile sarda della prima metà del Seicento sono i Centelles, i Castelvì, i Requesens e i Torrella. Tra i nobili feudatari più potenti e importanti del Regno, troviamo don Christofol Centelles, prima conte e poi, dal 1603, marchese dello sconfinato feudo di Quirra. Don Christofor è attivo protagonista delle Corti del 1602-1603 in qualità di ambasciatore e trattatore dello stamento militare. È in stretto rapporto col viceré conte d’Elda e con i maggiori esponenti dei tre stamenti e della regia cort, come personalità delle famiglie Castelvì, Alagon, Zatrillas, Zapata, Aymerich, Fortesa, Masons, Baccallar, Requesens, Torrella. Dal 1602 al 1609 possiamo contare circa venti schiavi in suo possesso, molti dei quali acquistati direttamente durante i pubblici incanti delle prese corsare di Andreu de Lorca, Andreu Gisbert e Guillelm Prevost. Don Christofor ha la tendenza a battezzare e cresimare buona parte degli schiavi che possiede. I nomi dei padrini e delle madrine non sembrano rimandare, di norma, a famiglie della nobiltà. Tali famiglie emergono, invece, nel caso in cui sia Centelles a svolgere il ruolo di padrino o in occasione di compravendite private. All’inizio del secolo, don Christofor battezza uno schiavo del viceré Coloma insieme alla contessa di Laconi donna Anna de Castelvì e vende uno dei propri captivi a don Joan Naharro de Ruecas, Tesoriere Reale. Al proprio procuratore, Gaspar Cugia, ordina nel 1609 di occuparsi di ritrovare e ricondurre a casa Almanzor, schiavo fuggitivo. Cugia, a sua volta, delega il compito al proprio procuratore, il capitano del re Christofor Franco, palermitano abitante di Cagliari, anch’egli possessore di schiavi. Gaspar Cugia si occupa altresì di un’operazione di riscatto: troviamo una procura che Laurenso Pira, cittadino di Sassari schiavo di Sidi Hamida, dà a Cugia per occuparsi di procurare il denaro necessario alla sua liberazione dal padrone. Nello stesso anno il marchese si trasferisce nella sua città natale, Valencia, portando con sé almeno quattro schiavi. A presentarsi davanti al Bailo di Valencia per occuparsi degli adempimenti necessari al trasferimento dei captivi fuori dalla Sardegna è un altro procuratore di Centelles, Antoni Datos del Castillo, insieme al nobile don Hieroni Mercader il quale si assume la responsabilità di recarsi a Cagliari per trovare le carte patrimoniali che attestano l’avvenuto pagamento del quinto reale sugli schiavi. Dei contatti che è stato possibile ricostruire per don Christofol Centelles, una buona parte si intreccia al rapporto con Salem Desfachs, declinato prima nel binomio padrone-schiavo e poi evolutosi verso una collaborazione “professionale” dopo la sua liberazione. Ricordiamo, ad esempio, i patroni Joan Dale e Baptista Baldo, Honorat Rocafort e Spirit Pipin. Il caso del marchese di Quirra mostra una rete sociale “schiavile” che, più che sovrapporsi a quella “istituzionale”, prende nuove direzioni. Sottolinea un modo unico di sfruttare la schiavitù, almeno nel panorama della nostra ricerca. Centelles utilizza i suoi schiavi non solo durante il periodo vero e proprio di cattività, non solo per il lavoro forzato, non solo per il profitto delle vendite o dei riscatti. Porta avanti, invece, la strategia di utilizzarli anche successivamente, quando sono diventati uomini liberi, sfruttandone competenze, connessioni e abilità per il beneficio dei propri commerci. Possiamo ipotizzare che, da una parte, Salem sfrutti le conoscenze e le connessioni del marchese, ma che anche il marchese possa trarre vantaggio delle relazioni costruite autonomamente dal suo collaboratore. La spazialità che il network di Centelles disegna crea ponti tra Cagliari, Valencia, Biserta e altre città della Barberia e la Francia. Un cognome ricorrente e particolarmente noto nella storia della Sardegna è Castelvì. Si tratta di una famiglia feudale di origine valenzana che nel Regno di Sardegna forma tre rami: i marchesi di Laconi, i signori di Samassi e Serrenti e i marchesi di Cea, imparentandosi con altre grandi famiglie nobiliari e feudali. Gli uomini della famiglia sono tra i più eminenti membri dello stamento militare in Parlamento, svolgendo spesso il ruolo di rappresentanti, abilitatori, trattatori e giudici dei gravami, stringendo rapporti di prossimità con gli altri maggiori nobili e feudatari. La famiglia Castelvì si rende protagonista nella vicenda schiavile anche con le sue esponenti femminili. Don Jaume Castelvì tra il 1603 al 1617, tramite gli schiavi che possiede, entra in contatto con diverse personalità. Il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i quali gli consegnano il denaro del riscatto di uno dei suoi schiavi; Jaime de Aquena e Isabel Torres sono il padrino e la madrina uno “schiavetto”; lo schiavo Juan Baptista invece è battezzato da don Jaume stesso e da sua moglie, donna Anna de Castelvì; Juan Seraphi ha come padrini Salvador Caddeo, prete, e Joana Sorja; per Juan Jordi, invece, sono Jordi Jaquello e Rosa Marras. Al momento della cresima dello schiavo Pablo Zacharias, a fargli da padrino è Benitto Bravo. Donna Anna de Castelvì battezza, oltre a Juan Baptista, anche uno schiavo del viceré Coloma insieme al marchese di Quirra don Christofol Centelles. La donna possiede a sua volta due schiave: una battezzata da Nicolau Porxella, signore della villa di Serdiana e ambasciatore dello stamento militare nel parlamento d’Elda, e l’altra cresimata dal dottore in utroque iure Gaspar Pira. Don Francesco, visconte di Sanluri, al momento dell’ingresso nell’ordine dei padri cappuccini (nel 1607) lascia in eredità al fratello don Pau due schiavi che dovranno servire per quattro anni a suo beneficio e a beneficio di don Hieronim de Sena, sindaco della città di Alghero nel parlamento d’Elda, e di don Joan Sant Just, anche lui ripetutamente abilitato a partecipare alle Corti del Regno nello stamento militare. Don Francesco possiede un altro schiavo, Joan Baptista, che viene battezzato da Hieronima Sarroch e Castelvì, ed è anche padrino di battesimo di uno degli schiavi del nobile dottor Anton de Tola, anch’egli presente in Parlamento, insieme a Margalida Castañeda. Don Pau è cavaliere di San Giacomo e Procuratore Reale dal 1616, grazie alle nozze con donna Mariana Deixar, erede dell’ufficio per via del padre don Nofre Fabra e Deixar. Don Pau possiede diversi schiavi oltre a quelli ricevuti dal fratello, tra i quali Amet, acquistato dal corsaro Barthomeu Didià. Compare, poi, come padrino nel battesimo di uno schiavo del conte di Cuglieri insieme a donna Mariana. Altri esponenti della famiglia sono don Salvador de Castelvì che, per mezzo di Miquel Velasquez, intraprende un rapporto di compravendita col viceré Gandìa; donna Juana Castelvì e Amat dopo aver concesso una taglia allo schiavo Anasar, riceve la garanzia “fideiussoria” di altri tre schiavi dei quali sono padroni il dottor Juan Masons, don Juan Naharro de Ruecas e il dottor Francesch Jagaracho. Don Emanuel presta denaro allo schiavo Amet di proprietà di don Joan Naharro de Ruecas. Anche donna Mariana Castelvì e Deixar viene scelta come madrina: battezza una schiava di suo padre, don Nofre Fabra e Deixar, ed è madrina di cresima di Joan Thomas, il “negro venuto nella terra dei cristiani per farsi cristiano” con la cui storia famigliare si apre questo lavoro. I numerosi contatti d’alto rango della famiglia sono tendenzialmente locali e identificati nell’alta società nobile e borghese della città e del circondario. Fanno eccezione alcuni nomi non meglio ascrivibili a specifici ambiti o posizioni sociali e presenti in qualità di padrini e madrine. Rileviamo, in alcuni casi, il realizzarsi di scambi interni all’ambito famigliare. A proiettare la famiglia verso l’esterno sono il francese Didià, il siciliano Joseph Caruso e il maltese Francesco Zibosio, i valenciani viceré Coloma e marchese di Quirra, gli schiavi provenienti dal Nordafrica e dalla Polonia. A proposito di Joseph Caruso le fonti ci dicono che il suo protagonismo nel riscatto di schiavi non è circostanziale, ma una vera e propria attività “professionale”. Lo ritroviamo menzionato negli atti del consolato francese a Tunisi nel 1610, quando paga il riscatto di un uomo di Alicante schiavo a Tunisi di Ossoman Dey. Il riscatto avviene per volontà e su commissione di Miquel Vidal, mercante maiorchino residente a Cagliari. Caruso non manca, comunque, di possedere qualche schiavo: tra il 1603 e il 1608 è padrone almeno di tre. Un’altra famiglia che emerge nel possesso schiavi è quella dei Requesens. È una famiglia catalana trasferitasi a Cagliari, presente in Parlamento almeno dal 1592-1594 con diversi esponenti della famiglia ammessi nello stamento militare, tra cui don Gaspare. Nel primo Seicento, egli possiede diversi schiavi. Amet di Algeri, per esempio, è coinvolto come garante in un atto di taglia a favore di uno schiavo di Pere Blancafort, insieme ad altri due schiavi appartenenti al defunto Joan Antoni Palou e a Miquel Calabres. Tra gli altri schiavi vi sono Maria Francesca, battezzata da Juan Pere Requesens e Angela Taria, e Antonia Ela, battezzata da Leonart Uda e Francesca Serra. Gli ultimi quattro nomi, sconosciuti, non sono collocabili in alcun ambito sociale. Più attiva nell’ambito schiavile è donna Ysabel Requesens, o meglio Alagon e Requesens, moglie del marchese di Villasor don Martino de Alagon. Donna Ysabel, dal 1604 al 1616 possiede almeno dieci schiavi, alcuni dei quali protagonisti di eccezionali vicende personali. Tra i captivi che possiede troviamo Amet Bofetil di Biserta, il cui riscatto viene pagato a donna Ysabel dal patrone napoletano Salvator Izzo; Portia, che la donna acquista dall’arcivescovo di Arborea don Antonio Canopolo per mezzo del suo procuratore padre Hieronim Sanna, gesuita; Anastasia, la schiava poi affrancata che costruisce una famiglia con Joan Thomas de Santa Cruz: al loro matrimonio i testimoni sono Antiogo Lai e il reverendo Monserrat Baccallar, mentre a fare da padrino di confermazione alla loro figlia Catelina è chiamato Joan Miquel Carta; Anastasia ha anche un’altra figlia nata prima del matrimonio con Joan Thomas, che appartiene ai marchesi di Villasor e che viene battezzata col nome di Dionisa Isabela dal padrino Hieroni Pola e dalla madrina Maria Meli; infine, ricordiamo Axia, la schiava del commendatore Vintimilla che non risiede presso il padrone, ma nella dimora di donna Ysabel e che è implicata nella vicenda dell’avvelenamento del commendatore: questo fatto indica la sussistenza di un qualche rapporto tra la famiglia Alagon e Vintimilla. Ultima esponente della famiglia è Donna Hieronima Carta e Requesens, che vende due schiave al dottore in diritti Anton de Tola, canonico di Cagliari. Nel 1610 Miquel Angel Carta presta uno dei propri schiavi al figlio Joan Baptista perché lo assista e lo serva in un viaggio da Cagliari alla Castiglia passando per Valencia, a bordo della nave del patrone francese Uguet Steva. Giunti nella penisola iberica, a giurare sui documenti notarili che attestano la legittimità del possesso dello schiavo sono il marchese di Quirra don Christofol Centelles e Gaspar Feo, valenciano. I Requesens possono vantare numerosi contatti altisonanti, ai quali si affiancano nomi poco o per nulla noti. La spazialità tracciata da tali relazioni mette in collegamento la Sardegna con Napoli, con Valencia, con la Francia e con il Nordafrica. Infine, nella persona di don Melchiorr Torrella, barone di Capoterra, vediamo una chiara espressione dell’intreccio tra nobiltà, governo municipale e amministrazione cittadina, che trova nel possesso di schiavi un canale di consolidamento. Torrella, nobile, è implicato nel governo civico di Cagliari come consigliere capo nei primi anni del Seicento e rappresentante dello stamento reale nel parlamento d’Elda, abilitatore e trattatore, in cooperazione e vicinanza con i più alti rappresentanti delle istituzioni. Nella compravendita e nel possesso di schiavi troviamo interazioni con alcuni tra i principali ufficiali regi come Joan Masons, giudice della Reale Udienza, l’avvocato fiscale Joan Antoni Palou, e altri amministratori civici come Joan Francisco Jorgi, consigliere municipale. Altri contatti sono stretti con i mercanti Joan Costa, genovese, e Joan Angel Quessa, cagliaritano. Altri esponenti della famiglia Torrella, come visto precedentemente, sono implicati come padrini e madrine di schiavi e schiave della famiglia Jorgi, dell’arcivescovo D’Esquivell, del canonico Salvador Costanti, del consigliere civico Jaume Hortola e del barone di Orosei e Galtellì Fabrissio Manca e Guiso. La società cagliaritana e gli schiavi: i viceré Come alter ego del re, il viceré è la figura governativa più importante del Regno (insieme al Procuratore Reale e al Reggente la Reale Cancelleria), soluzione all’assenza del sovrano da ciascun Regno. I viceré di Sardegna sono grandi possessori di schiavi, agevolati dal privilegio della “joya” che gli consente di ottenere uno schiavo per ogni presa corsara a titolo di donazione. Abbiamo potuto rinvenire notizie sull’esperienza di possesso di schiavi dei primi tre viceré del diciassettesimo secolo: si tratta di tre nobili provenienti dal Regno di Valencia, tutti di fazione lermista. Il primo è il conte d’Elda don Anton Coloma, la cui moglie è parente prossima del valido di Filippo III; il secondo, il conte del Real don Pedro Sánchez de Calatayud, espressione del partito dominante a corte; il terzo, il duca di Gandía don Carlos Borja, appartiene alla cerchia parentale di Lerma. Don Anton Coloma possiede captivi tra il 1600 al 1604 e ottiene la maggior parte di essi in occasione dei pubblici incanti, interfacciandosi direttamente con il Procuratore Reale don Nofre Fabra e Deixar, con gli altri ufficiali implicati nella gestione delle vendite, come il Maestro Razionale Francesco de Ravaneda, e con i corsari Andreu de Lorca, maiorchino o valenzano, Andreu Gisbert, Guillelm Prevost e Jean Baptiste Lalgin, francesi. In occasione dei battesimi dei suoi schiavi, sono alcuni tra i più grandi nobili e alti prelati del Regno (spesso anch’essi nobili) a testimoniare in qualità di padrini e madrine. Ad esempio, il battesimo dello schiavo Francesch viene officiato dal vescovo di Ales, don Antoni Zureddu e il padrino è don Christofol Centelles, prima conte e poi marchese di Quirra, mentre la madrina è donna Anna di Castelvì, contessa di Laconi. In altri casi troviamo personaggi come don Juan Coloma, (parente non meglio specificato del viceré), e donna Maria de Aragall, moglie del governatore del capo di Cagliari e Gallura, don Jaume de Aragall. Compaiono anche nomi non appartenenti alla nobiltà e sui quali né la documentazione archivistica, né quella bibliografica consentono di dare maggiori informazioni, come Vincent Amador e Anna Latzara. Gli schiavi del conte del Real don Calatayud, viceré e armatore, vengono battezzati e cresimati da padrini e madrine come Juan dela Matta, capitano delle torri, e sua moglie Maria Matta e Perser, dal dottor reverendo Matheo Ornano e il canonico della Cattedrale di Cagliari Joan Sini. Alcuni personaggi, come tre esponenti della famiglia Amelda, rimangono indefiniti e non collocabili in un preciso contesto sociale. Di alcuni dei captivi del viceré abbiamo potuto seguire alcuni momenti di vita. Luis, battezzato nel 1605, viene portato a Valencia nel 1607 dalla moglie del viceré, donna Marina Calatayud e Bou, sulla nave di un patrone francese di nome Urban de Quill per essere regalato o venduto; Hagemusa viene affrancato nel 1606 e affidato a Salem Desfachs, comprador del marchese di Quirra, per essere condotto a Biserta dove deve reperire il denaro del proprio riscatto e di quelli di altri schiavi. A rendere possibile il contatto e la collaborazione tra il viceré e Salem potrebbe essere il legame di amicizia, parentela e affari esistente tra Calatayud e il marchese di Quirra. Per quanto riguarda il duca di Gandìa, infine, abbiamo rilevato il possesso di almeno cinque schiavi in sei anni. Per mezzo di Miquel Velasquez, suo segretario personale e procuratore nello stamento militare, acquista una schiava da don Salvador Castelvì, esponente della grande famiglia dei visconti di Sanluri e marchesi di Laconi. Gli altri legami basati sul possesso di captivi sembrano coinvolgere persone non nobili: Rusina Lopez, Pau Clua, maggiordomo del viceré, e Anna Cerisa, i quali svolgono i ruoli di padrino e madrine nei battesimi. Anche nella seconda metà del secolo, fra il 1670 e il 1684, continuiamo a trovare i viceré tra i padroni di schiavi. Dodici dei venti schiavi che in quegli anni entrano malati nell’ospedale di Sant’Antonio di Cagliari appartengono ai viceré: tre appartengono a don Francisco de Tutavila e del Rufo, duca di San Germano, e sette a don Fernando Joaquín Fajardo de Zúñiga Requesens, VI marchese di Los Vélez. I viceré, dunque, nelle interazioni derivanti dal possesso di schiavi, sembrano privilegiare altri grandi nobili e alti prelati. Questi interlocutori sono spesso presenti in Parlamento e implicati nella vita politica sarda. Le relazioni includono anche le loro consorti, i figli, i fratelli e altri componenti delle loro famiglie, suggerendo la presenza di canali preferenziali di comunicazione e stretti rapporti interpersonali. Sono frequenti i rapporti diretti con chi gestisce le vendite all'asta dei bottini umani, come Procuratori Reali, Maestri Razionali e corsari, anche grazie al diritto "di prelazione" di cui godono i rappresentanti del re.
La società cagliaritana e gli schiavi: i viceré Come alter ego del re, il viceré è la figura governativa più importante del Regno (insieme al Procuratore Reale e al Reggente la Reale Cancelleria), soluzione all’assenza del sovrano da ciascun Regno. I viceré di Sardegna sono grandi possessori di schiavi, agevolati dal privilegio della “joya” che gli consente di ottenere uno schiavo per ogni presa corsara a titolo di donazione. Abbiamo potuto rinvenire notizie sull’esperienza di possesso di schiavi dei primi tre viceré del diciassettesimo secolo: si tratta di tre nobili provenienti dal Regno di Valencia, tutti di fazione lermista. Il primo è il conte d’Elda don Anton Coloma, la cui moglie è parente prossima del valido di Filippo III; il secondo, il conte del Real don Pedro Sánchez de Calatayud, espressione del partito dominante a corte; il terzo, il duca di Gandía don Carlos Borja, appartiene alla cerchia parentale di Lerma. Don Anton Coloma possiede captivi tra il 1600 al 1604 e ottiene la maggior parte di essi in occasione dei pubblici incanti, interfacciandosi direttamente con il Procuratore Reale don Nofre Fabra e Deixar, con gli altri ufficiali implicati nella gestione delle vendite, come il Maestro Razionale Francesco de Ravaneda, e con i corsari Andreu de Lorca, maiorchino o valenzano, Andreu Gisbert, Guillelm Prevost e Jean Baptiste Lalgin, francesi. In occasione dei battesimi dei suoi schiavi, sono alcuni tra i più grandi nobili e alti prelati del Regno (spesso anch’essi nobili) a testimoniare in qualità di padrini e madrine. Ad esempio, il battesimo dello schiavo Francesch viene officiato dal vescovo di Ales, don Antoni Zureddu e il padrino è don Christofol Centelles, prima conte e poi marchese di Quirra, mentre la madrina è donna Anna di Castelvì, contessa di Laconi. In altri casi troviamo personaggi come don Juan Coloma, (parente non meglio specificato del viceré), e donna Maria de Aragall, moglie del governatore del capo di Cagliari e Gallura, don Jaume de Aragall. Compaiono anche nomi non appartenenti alla nobiltà e sui quali né la documentazione archivistica, né quella bibliografica consentono di dare maggiori informazioni, come Vincent Amador e Anna Latzara. Gli schiavi del conte del Real don Calatayud, viceré e armatore, vengono battezzati e cresimati da padrini e madrine come Juan dela Matta, capitano delle torri, e sua moglie Maria Matta e Perser, dal dottor reverendo Matheo Ornano e il canonico della Cattedrale di Cagliari Joan Sini. Alcuni personaggi, come tre esponenti della famiglia Amelda, rimangono indefiniti e non collocabili in un preciso contesto sociale. Di alcuni dei captivi del viceré abbiamo potuto seguire alcuni momenti di vita. Luis, battezzato nel 1605, viene portato a Valencia nel 1607 dalla moglie del viceré, donna Marina Calatayud e Bou, sulla nave di un patrone francese di nome Urban de Quill per essere regalato o venduto; Hagemusa viene affrancato nel 1606 e affidato a Salem Desfachs, comprador del marchese di Quirra, per essere condotto a Biserta dove deve reperire il denaro del proprio riscatto e di quelli di altri schiavi. A rendere possibile il contatto e la collaborazione tra il viceré e Salem potrebbe essere il legame di amicizia, parentela e affari esistente tra Calatayud e il marchese di Quirra. Per quanto riguarda il duca di Gandìa, infine, abbiamo rilevato il possesso di almeno cinque schiavi in sei anni. Per mezzo di Miquel Velasquez, suo segretario personale e procuratore nello stamento militare, acquista una schiava da don Salvador Castelvì, esponente della grande famiglia dei visconti di Sanluri e marchesi di Laconi. Gli altri legami basati sul possesso di captivi sembrano coinvolgere persone non nobili: Rusina Lopez, Pau Clua, maggiordomo del viceré, e Anna Cerisa, i quali svolgono i ruoli di padrino e madrine nei battesimi. Anche nella seconda metà del secolo, fra il 1670 e il 1684, continuiamo a trovare i viceré tra i padroni di schiavi. Dodici dei venti schiavi che in quegli anni entrano malati nell’ospedale di Sant’Antonio di Cagliari appartengono ai viceré: tre appartengono a don Francisco de Tutavila e del Rufo, duca di San Germano, e sette a don Fernando Joaquín Fajardo de Zúñiga Requesens, VI marchese di Los Vélez. I viceré, dunque, nelle interazioni derivanti dal possesso di schiavi, sembrano privilegiare altri grandi nobili e alti prelati. Questi interlocutori sono spesso presenti in Parlamento e implicati nella vita politica sarda. Le relazioni includono anche le loro consorti, i figli, i fratelli e altri componenti delle loro famiglie, suggerendo la presenza di canali preferenziali di comunicazione e stretti rapporti interpersonali. Sono frequenti i rapporti diretti con chi gestisce le vendite all'asta dei bottini umani, come Procuratori Reali, Maestri Razionali e corsari, anche grazie al diritto "di prelazione" di cui godono i rappresentanti del re.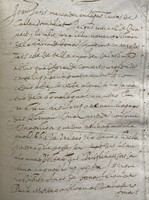 Garantire la liberazione: schiavi fideiussori
Garantire la liberazione: schiavi fideiussori  Schiavi e attività creditizia
Schiavi e attività creditizia 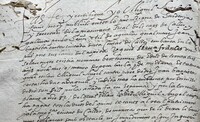 Fuori dal Regno: viaggi di schiavi tra la Sardegna e la penisola iberica
Fuori dal Regno: viaggi di schiavi tra la Sardegna e la penisola iberica 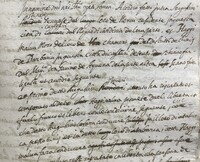 Mobilità, mediazione e riscatto
Mobilità, mediazione e riscatto 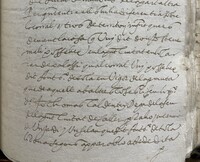 Baratto di schiavi per animali e oggetti
Baratto di schiavi per animali e oggetti 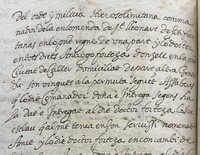 Cambiare il proprio schiavo per un altro: Joan Luis e Amet
Cambiare il proprio schiavo per un altro: Joan Luis e Amet 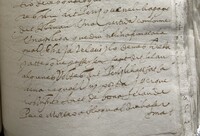 Schiavi in fuga
Schiavi in fuga 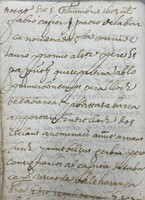 "Sono un buono a nulla ma valgo qualche cosa": scambi di schiavi
"Sono un buono a nulla ma valgo qualche cosa": scambi di schiavi  Schiavi feriti
Schiavi feriti 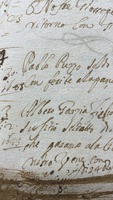 Schiavi all'Ospedale di Sant'Antonio Abate (Cagliari)
Schiavi all'Ospedale di Sant'Antonio Abate (Cagliari) 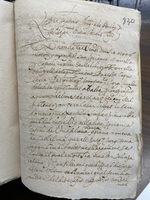 Famiglia Jorgi: lasciti testamentari e donazioni
Famiglia Jorgi: lasciti testamentari e donazioni 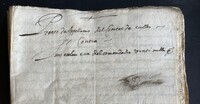 La rete criminale di Joan Luis
La rete criminale di Joan Luis 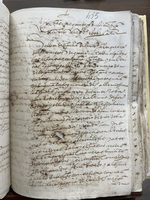 Salem Desfachs e la logistica mediterranea Salem Desfachs è un liberto, ex schiavo appartenuto a don Christofol Centelles, tra i più potenti signori feudali di Sardegna, primo marchese di Quirra e grande “uomo d’affari” impegnato specialmente nella speculazione cerealicola. Salem, nel 1606, emerge come figura centrale in una dinamica serie di attività commerciali. Da solo o in collaborazione con Amet di Tripoli, forse un altro liberto, è attivo, nella circolazione di denaro, nel commercio di vino, caffè e stoffe, nei riscatti e nelle garanzie a favore di altri schiavi. Insieme a Gusman Marsilia, un patrone di nave maltese, nel 1606 stipula un accordo con Augustina Morvillo e de Persia, residente nell’appendice della Lapola di Cagliari. La donna è sposata con Baptista Morvillo, originario di Napoli, il quale si trova in quel momento schiavo a Biserta. L’accordo prevede che Salem e Marsilia si rechino nella città tunisina per riscattare e riportare a Cagliari Morvillo. Augustina promette che, non appena i due condurranno suo marito a casa, pagherà ai due 900 lire: prezzo del riscatto e delle spese. Alla fine del 1607, Salem stringe un nuovo accordo con il provenzale di Cassis Joan Dale, patrone di una tartana. Dale porterà fino a Biserta 40 quintali di caffè, una grande botte di vino rosso e Hegemusa, schiavo di don Pedro Sanchez de Calatayud, viceré di Sardegna dal 1604 al 1610. Una volta giunto a destinazione, Dale consegnerà la merce e lo schiavo a chi Salem indicherà. Per questa commissione riceverà 171 lire. Non molti giorni dopo, Salem commissiona a Battista Baldo, patrone cagliaritano dell’appendice della Lapola, il trasporto a Biserta di un carico di stoffe e dello stesso schiavo prima affidato a Joan Dale. Questo fatto ci fa ipotizzare che per qualche ragione l’accordo precedente non si sia potuto realizzare. Hagemusa deve recarsi in Barberia per reperire il denaro del proprio riscatto e di quello di altri schiavi e Salem si rende disponibile a fargli da garante per il viaggio in mare, ricevendo in cambio 900 lire. Il liberto affida a Baldo anche altri compiti: trasportare a Cagliari un carico di stoffe e un’imbarcazione, e occuparsi di un riscatto commissionato da Miquel Vidal, un mercante di Maiorca residente a Cagliari. In cambio dei servizi prestati, il patrone riceverà parte delle stoffe trasportate in Barberia, metà dell’importo ricavato dalla loro vendita e un terzo di quanto guadagnato dai quaranta quintali di caffè portati a Biserta da Joan Dale; avrà anche un terzo del guadagno ottenuto dal riscatto dello schiavo cristiano. Per assicurare il viaggio di Battista Baldo, Salem promette al patrone e ai marinai che andranno con lui, che basterà la sua parola per far sì che non siano ostacolati né catturati durante la navigazione o durante la permanenza. E se dovessero essere catturati o gli venisse causato qualche danno, Salem stesso li risarcirà; se dovessero essere catturati e venduti in Berberia li riscatterà e ripagherà i danni. L’ultima traccia documentale delle attività commerciali di Salem riguarda un accordo col mercante cagliaritano Hieronim Brondo. Il liberto dichiara di essere debitore a Brondo per la somma di 190 lire, prezzo di un carico di stoffe che questi gli ha venduto, e promette di pagare quanto dovuto entro due mesi. Inoltre assicura che, non appena Battista Baldo tornerà dalla Barberia con il carico di lana, ne venderà cinque quintali a Brondo, se lo vorrà, a un prezzo favorevole. Salem ha un legame con una donna, Fatima, schiava di Miquel Vidal. Si tratta dello stesso Vidal che abbiamo già visto legato a Salem da una commissione di riscatto, e proprio la previa conoscenza tra il liberto e il mercante potrebbe aver favorito l’unione con la schiava. Nel 1609 Fatima e Salem perdono un figlio neonato. Nell'atto di morte del bambino, Salem viene definito “comprador que es del marques de Quirra”, titolo che esplicita e conferma un rapporto "professionale".
Salem Desfachs e la logistica mediterranea Salem Desfachs è un liberto, ex schiavo appartenuto a don Christofol Centelles, tra i più potenti signori feudali di Sardegna, primo marchese di Quirra e grande “uomo d’affari” impegnato specialmente nella speculazione cerealicola. Salem, nel 1606, emerge come figura centrale in una dinamica serie di attività commerciali. Da solo o in collaborazione con Amet di Tripoli, forse un altro liberto, è attivo, nella circolazione di denaro, nel commercio di vino, caffè e stoffe, nei riscatti e nelle garanzie a favore di altri schiavi. Insieme a Gusman Marsilia, un patrone di nave maltese, nel 1606 stipula un accordo con Augustina Morvillo e de Persia, residente nell’appendice della Lapola di Cagliari. La donna è sposata con Baptista Morvillo, originario di Napoli, il quale si trova in quel momento schiavo a Biserta. L’accordo prevede che Salem e Marsilia si rechino nella città tunisina per riscattare e riportare a Cagliari Morvillo. Augustina promette che, non appena i due condurranno suo marito a casa, pagherà ai due 900 lire: prezzo del riscatto e delle spese. Alla fine del 1607, Salem stringe un nuovo accordo con il provenzale di Cassis Joan Dale, patrone di una tartana. Dale porterà fino a Biserta 40 quintali di caffè, una grande botte di vino rosso e Hegemusa, schiavo di don Pedro Sanchez de Calatayud, viceré di Sardegna dal 1604 al 1610. Una volta giunto a destinazione, Dale consegnerà la merce e lo schiavo a chi Salem indicherà. Per questa commissione riceverà 171 lire. Non molti giorni dopo, Salem commissiona a Battista Baldo, patrone cagliaritano dell’appendice della Lapola, il trasporto a Biserta di un carico di stoffe e dello stesso schiavo prima affidato a Joan Dale. Questo fatto ci fa ipotizzare che per qualche ragione l’accordo precedente non si sia potuto realizzare. Hagemusa deve recarsi in Barberia per reperire il denaro del proprio riscatto e di quello di altri schiavi e Salem si rende disponibile a fargli da garante per il viaggio in mare, ricevendo in cambio 900 lire. Il liberto affida a Baldo anche altri compiti: trasportare a Cagliari un carico di stoffe e un’imbarcazione, e occuparsi di un riscatto commissionato da Miquel Vidal, un mercante di Maiorca residente a Cagliari. In cambio dei servizi prestati, il patrone riceverà parte delle stoffe trasportate in Barberia, metà dell’importo ricavato dalla loro vendita e un terzo di quanto guadagnato dai quaranta quintali di caffè portati a Biserta da Joan Dale; avrà anche un terzo del guadagno ottenuto dal riscatto dello schiavo cristiano. Per assicurare il viaggio di Battista Baldo, Salem promette al patrone e ai marinai che andranno con lui, che basterà la sua parola per far sì che non siano ostacolati né catturati durante la navigazione o durante la permanenza. E se dovessero essere catturati o gli venisse causato qualche danno, Salem stesso li risarcirà; se dovessero essere catturati e venduti in Berberia li riscatterà e ripagherà i danni. L’ultima traccia documentale delle attività commerciali di Salem riguarda un accordo col mercante cagliaritano Hieronim Brondo. Il liberto dichiara di essere debitore a Brondo per la somma di 190 lire, prezzo di un carico di stoffe che questi gli ha venduto, e promette di pagare quanto dovuto entro due mesi. Inoltre assicura che, non appena Battista Baldo tornerà dalla Barberia con il carico di lana, ne venderà cinque quintali a Brondo, se lo vorrà, a un prezzo favorevole. Salem ha un legame con una donna, Fatima, schiava di Miquel Vidal. Si tratta dello stesso Vidal che abbiamo già visto legato a Salem da una commissione di riscatto, e proprio la previa conoscenza tra il liberto e il mercante potrebbe aver favorito l’unione con la schiava. Nel 1609 Fatima e Salem perdono un figlio neonato. Nell'atto di morte del bambino, Salem viene definito “comprador que es del marques de Quirra”, titolo che esplicita e conferma un rapporto "professionale".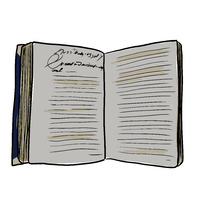 Morte di una schiava di Hieroni Sanna Muore una schiava di Heroni Sanna. Viene sepolta nel fossario (“al fossar”).
Morte di una schiava di Hieroni Sanna Muore una schiava di Heroni Sanna. Viene sepolta nel fossario (“al fossar”).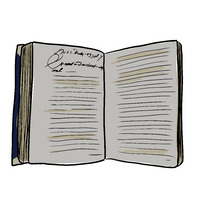 Morte di una schiava del viceré Muore una schiava del viceré che aveva ricevuto tutti i sacramenti. Viene viene sepolta “en jesus”, cioè nella chiesa di Nostra Signora del Gesù.
Morte di una schiava del viceré Muore una schiava del viceré che aveva ricevuto tutti i sacramenti. Viene viene sepolta “en jesus”, cioè nella chiesa di Nostra Signora del Gesù.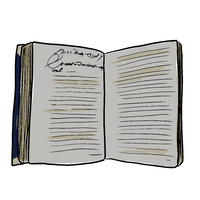 Battesimo di una schiava nella Diocesi di Sassari Viene battezzata la schiava del signor don Henrigues de Sena. Le viene dato il nome di Caderina Antonia Joanna. Padrino è il reverendo Marcu Barra e madrina Antonia Corriga.
Battesimo di una schiava nella Diocesi di Sassari Viene battezzata la schiava del signor don Henrigues de Sena. Le viene dato il nome di Caderina Antonia Joanna. Padrino è il reverendo Marcu Barra e madrina Antonia Corriga.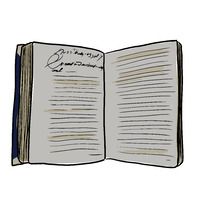 Battesimi di due schiavi nella Diocesi di Sassari Vengono battezzati dall’arcivescovo di Bosa don Gavino Manca lo schiavo del monsignor di Arborea don Antonio Canopolo e un altro del signor don Pedro de Mulines. Si chiamano uno Joan Antonio e l’altro Joan Pedro. Padrini per entrambi sono il governatore e la governatrice di questa città.
Battesimi di due schiavi nella Diocesi di Sassari Vengono battezzati dall’arcivescovo di Bosa don Gavino Manca lo schiavo del monsignor di Arborea don Antonio Canopolo e un altro del signor don Pedro de Mulines. Si chiamano uno Joan Antonio e l’altro Joan Pedro. Padrini per entrambi sono il governatore e la governatrice di questa città.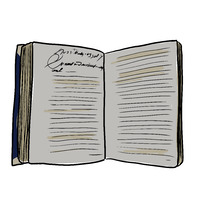 Abraam lascia in Sardegna Juaneta, sua figlia Un musulmano di nome Abraam, ora liberto e prima schiavo di Miquel Comprat, dovendo tornare in Barberia, deve lasciare una sua figlia cristiana di 4 anni, chiamata Juaneta. Perché la figlia non resti senza protezione, la affida alla signora Gracia Cavalier y Comprar affinché stia per venti anni a servizio della signora che dovrà provvedere a farla sposare. La signora Gracia, l'accetta come serva alle condizioni abituali per il servizio domestico: promette di tenerla da sana e malata, di provvederla di vestiti e di scarpe, di mangiare e bere e di darle per il matrimonio 100 lire, 50 in soldi e 50 in roba.
Abraam lascia in Sardegna Juaneta, sua figlia Un musulmano di nome Abraam, ora liberto e prima schiavo di Miquel Comprat, dovendo tornare in Barberia, deve lasciare una sua figlia cristiana di 4 anni, chiamata Juaneta. Perché la figlia non resti senza protezione, la affida alla signora Gracia Cavalier y Comprar affinché stia per venti anni a servizio della signora che dovrà provvedere a farla sposare. La signora Gracia, l'accetta come serva alle condizioni abituali per il servizio domestico: promette di tenerla da sana e malata, di provvederla di vestiti e di scarpe, di mangiare e bere e di darle per il matrimonio 100 lire, 50 in soldi e 50 in roba.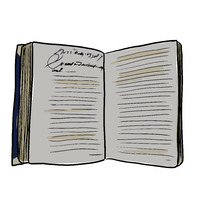 Atto di taglia stabilito in nove anni e mezzo Lo schiavo deve versare al padrone 120 ducati, 5 al momento della stipula dell’atto e 115 nel corso del tempo per un ducato al mese. Gli anni previsti sono dunque 9 e mezzo: anche se la somma fosse stata pagata prima, il tempo non sarebbe diminuito.
Atto di taglia stabilito in nove anni e mezzo Lo schiavo deve versare al padrone 120 ducati, 5 al momento della stipula dell’atto e 115 nel corso del tempo per un ducato al mese. Gli anni previsti sono dunque 9 e mezzo: anche se la somma fosse stata pagata prima, il tempo non sarebbe diminuito.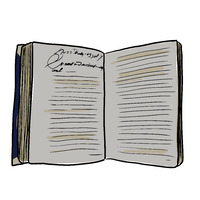 Atto di taglia di Alì L’atto di taglia di Alì prevede che egli versi 80 ducati, valenti 224 lire di Cagliari. L’atto precisa che un ducato vale 56 soldi e cioè 2,8 lire. Alì dovrà versare un ducato al mese e quindi la durata della taglia è prevista in sei anni e sei mesi. È stabilito che, qualora ne sia in grado, potrà versare più di un ducato al mese facendo così accorciare la durata della taglia.
Atto di taglia di Alì L’atto di taglia di Alì prevede che egli versi 80 ducati, valenti 224 lire di Cagliari. L’atto precisa che un ducato vale 56 soldi e cioè 2,8 lire. Alì dovrà versare un ducato al mese e quindi la durata della taglia è prevista in sei anni e sei mesi. È stabilito che, qualora ne sia in grado, potrà versare più di un ducato al mese facendo così accorciare la durata della taglia.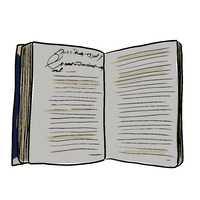 Taglia di Amet Allo schiavo Amet viene accordato il riscatto per taglia e il padrone concede che egli, insieme alla moglie Fatima, già liberta, possa dormire fuori da Cagliari: “fora de Caller”.
Taglia di Amet Allo schiavo Amet viene accordato il riscatto per taglia e il padrone concede che egli, insieme alla moglie Fatima, già liberta, possa dormire fuori da Cagliari: “fora de Caller”.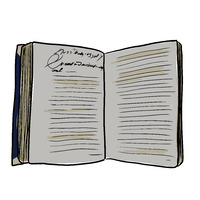 Atto di taglia di uno schiavo di Bona Due coniugi di Lapola di Cagliari stipulano accordo di taglia con il loro schiavo di Bona. Gli impongono di dormire a casa loro per svolgere i servizi dovuti di notte e di giorno, ma concedono che possa dormire fuori casa una o due notti, nel Castello di Cagliari, per poter provvedere alle sue necessità.
Atto di taglia di uno schiavo di Bona Due coniugi di Lapola di Cagliari stipulano accordo di taglia con il loro schiavo di Bona. Gli impongono di dormire a casa loro per svolgere i servizi dovuti di notte e di giorno, ma concedono che possa dormire fuori casa una o due notti, nel Castello di Cagliari, per poter provvedere alle sue necessità.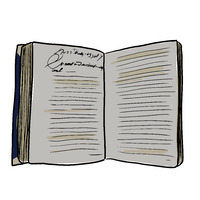 Taglia di uno schiavo di Bona Due coniugi di Lapola di Cagliari stipulano accordo di taglia con il loro schiavo di Bona. Si impegnano a consegnargli un “gonell” di orbace e una berretta sarda. Gli consentono inoltre di poter lavorare e servire altrove per guadagnare per se stesso e per il proprio riscatto, dopo aver adempiuto ai compiti che come schiavo è tenuto a fare a casa del padrone.
Taglia di uno schiavo di Bona Due coniugi di Lapola di Cagliari stipulano accordo di taglia con il loro schiavo di Bona. Si impegnano a consegnargli un “gonell” di orbace e una berretta sarda. Gli consentono inoltre di poter lavorare e servire altrove per guadagnare per se stesso e per il proprio riscatto, dopo aver adempiuto ai compiti che come schiavo è tenuto a fare a casa del padrone.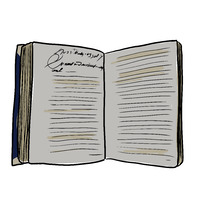 Taglia di Sebastiano, nero convertito Mossen Nicolò Pintor sprona il suo schiavo nero convertito, Sebastiano, a lavorare. Secondo lui lo schiavo non si curava di procurarsi la libertà. I due stipulano un accordo di taglia a condizioni molto vantaggiose per Sebastiano: avrebbe potuto dormire in casa del padrone e avrebbe ricevuto indumenti e scarpe.
Taglia di Sebastiano, nero convertito Mossen Nicolò Pintor sprona il suo schiavo nero convertito, Sebastiano, a lavorare. Secondo lui lo schiavo non si curava di procurarsi la libertà. I due stipulano un accordo di taglia a condizioni molto vantaggiose per Sebastiano: avrebbe potuto dormire in casa del padrone e avrebbe ricevuto indumenti e scarpe.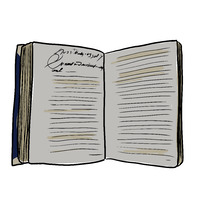 Taglia di Fatima, sessantenne di Tunisi Una donna residente nel quartiere di Lapola, a Cagliari, permette alla sua schiava sessantenne Fatima di Tunisi, di poter lavorare per guadagnare il denaro necessario a pagare la propria taglia.
Taglia di Fatima, sessantenne di Tunisi Una donna residente nel quartiere di Lapola, a Cagliari, permette alla sua schiava sessantenne Fatima di Tunisi, di poter lavorare per guadagnare il denaro necessario a pagare la propria taglia.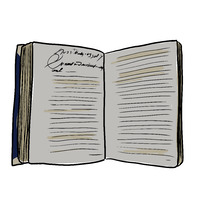 Taglia di Bartolomeo de Pintor Bartolomeo de Pintor, schiavo convertito, viene sottoposto a taglia.
Taglia di Bartolomeo de Pintor Bartolomeo de Pintor, schiavo convertito, viene sottoposto a taglia.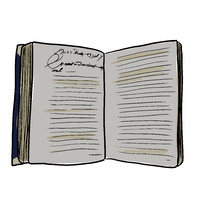 Una conversione complicata Una schiava di Tunisi, poco dopo essere stata battezzata, venne processata dall’Inquisizione sarda nel 1593 perché i padroni la accusarono di aver maledetto il giorno in cui aveva ricevuto il battesimo, affermando che sebbene un musulmano non fosse battezzato, andrebbe lo stesso in paradiso come un cristiano se rispetta la sua legge; che la religione islamica è migliore di quella cristiana, che il battesimo ricevuto era solo stato accettato con la bocca ma non col cuore; e che alla fine dei conti mori e cristiani sono tutti uniti. Cercò di giustificarsi dicendo che aveva detto quelle cose perché le avevano promesso la libertà se si fosse battezzata, senza mai dargliela. In verità, tra le poche righe riassuntive del suo processo , si scorgono le sue intime convinzioni: disse che "era vissuta da musulmana per 50 anni e aveva spesso dubitato delle dottrine della santa fede cattolica e dubitava spesso delle cose di cui la si accusava e creduto ciò di cui era accusata". Alla fine fu riconosciuta colpevole e condannata a tre anni di prigione e a portare per lo stesso periodo l'abito penitenziale, chiamato sambenito. Nel frattempo era stata liberata, giacché durante il processo viene chiamata liberta. Di lei non si sa altro. Tornò alla terra dei moroso restò nell'isola? Molto probabilmente continuò a credere che "chi osserva la sua religione" si salva e a sperare che "alla fine, musulmani e cristiani saremo tutti uniti"
Una conversione complicata Una schiava di Tunisi, poco dopo essere stata battezzata, venne processata dall’Inquisizione sarda nel 1593 perché i padroni la accusarono di aver maledetto il giorno in cui aveva ricevuto il battesimo, affermando che sebbene un musulmano non fosse battezzato, andrebbe lo stesso in paradiso come un cristiano se rispetta la sua legge; che la religione islamica è migliore di quella cristiana, che il battesimo ricevuto era solo stato accettato con la bocca ma non col cuore; e che alla fine dei conti mori e cristiani sono tutti uniti. Cercò di giustificarsi dicendo che aveva detto quelle cose perché le avevano promesso la libertà se si fosse battezzata, senza mai dargliela. In verità, tra le poche righe riassuntive del suo processo , si scorgono le sue intime convinzioni: disse che "era vissuta da musulmana per 50 anni e aveva spesso dubitato delle dottrine della santa fede cattolica e dubitava spesso delle cose di cui la si accusava e creduto ciò di cui era accusata". Alla fine fu riconosciuta colpevole e condannata a tre anni di prigione e a portare per lo stesso periodo l'abito penitenziale, chiamato sambenito. Nel frattempo era stata liberata, giacché durante il processo viene chiamata liberta. Di lei non si sa altro. Tornò alla terra dei moroso restò nell'isola? Molto probabilmente continuò a credere che "chi osserva la sua religione" si salva e a sperare che "alla fine, musulmani e cristiani saremo tutti uniti"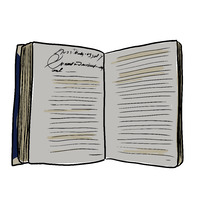 Una conversione in punto di morte Il rifiuto del battesimo da parte di uno schiavo veniva visto come un’insensatezza e opera del demonio. In questo senso si esprime una fonte gesuitica che riferisce la conversione di un turco avvenuta a Sassari nel 1601. Il turco in questione era stato condannato a morte e non voleva in nessun modo farsi battezzare. Quando vedeva uno dei gesuiti entrare nella sua cella, abbassava gli occhi a terra per non ascoltare quanto gli veniva detto, desiderando, come diceva, morire nella setta di Maometto per salvarsi. Decise di impiccarsi nella cella, ma accorsero i custodi e lo soccorsero, slegando il cappio. Il turco tornò in sé e si arrese a Dio. Fece chiamare i padri, dicendo che non c’era altra legge al di fuori di quella dei cristiani e voleva essere uno di loro. Fu battezzato. Per tre giorni perseverò nella sua saggia scelta con molta devozione e pietà. I padri non lo lasciarono fino alla esecuzione capitale, dopo la quale fu sepolto come un cristiano.
Una conversione in punto di morte Il rifiuto del battesimo da parte di uno schiavo veniva visto come un’insensatezza e opera del demonio. In questo senso si esprime una fonte gesuitica che riferisce la conversione di un turco avvenuta a Sassari nel 1601. Il turco in questione era stato condannato a morte e non voleva in nessun modo farsi battezzare. Quando vedeva uno dei gesuiti entrare nella sua cella, abbassava gli occhi a terra per non ascoltare quanto gli veniva detto, desiderando, come diceva, morire nella setta di Maometto per salvarsi. Decise di impiccarsi nella cella, ma accorsero i custodi e lo soccorsero, slegando il cappio. Il turco tornò in sé e si arrese a Dio. Fece chiamare i padri, dicendo che non c’era altra legge al di fuori di quella dei cristiani e voleva essere uno di loro. Fu battezzato. Per tre giorni perseverò nella sua saggia scelta con molta devozione e pietà. I padri non lo lasciarono fino alla esecuzione capitale, dopo la quale fu sepolto come un cristiano.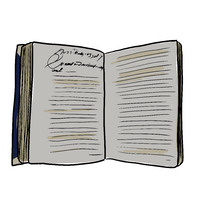 Risarcimenti ai padroni per gli schiavi attallati convocati per le regie galere Nella lista del 1564 per l’arruolamento degli schiavi di Sardegna nelle regie galere di Spagna, gli schiavi sottoposti a taglia vengono considerati schiavi a tutti gli effetti e giudicati idonei al servizio, differentemente dagli schiavi già definitivamente affrancati. Come risarcimento, al padrone viene corrisposta la somma di denaro che al captivo restava ancora da pagare in quel momento e lo sfortunato tornava irrimediabilmente in condizione di schiavo, finendo al remo. Nell’Archivio Generale di Simancas sono riportati alcuni ordini di pagamento per gli schiavi attallati: Abdalà di Donato Satta, Amet di Sebastiano Dessì, Amet di Antonio Silvestre, Marjan – nero – di Giovanni Sisto. Il contenuto dell’ultimo è il seguente: si pagheranno a Giovanni Sisto 55 scudi e 4 reali equivalenti a 144 lire di cui il detto Sisto è creditore da Marjan, suo schiavo, come completamento dei 60 scudi totali previsti dall’atto di taglia redatto davanti al notaio Melchiorre de Silvia il 24 gennaio 1562. La taglia di Marjan doveva essere pagata con uno scudo al mese.
Risarcimenti ai padroni per gli schiavi attallati convocati per le regie galere Nella lista del 1564 per l’arruolamento degli schiavi di Sardegna nelle regie galere di Spagna, gli schiavi sottoposti a taglia vengono considerati schiavi a tutti gli effetti e giudicati idonei al servizio, differentemente dagli schiavi già definitivamente affrancati. Come risarcimento, al padrone viene corrisposta la somma di denaro che al captivo restava ancora da pagare in quel momento e lo sfortunato tornava irrimediabilmente in condizione di schiavo, finendo al remo. Nell’Archivio Generale di Simancas sono riportati alcuni ordini di pagamento per gli schiavi attallati: Abdalà di Donato Satta, Amet di Sebastiano Dessì, Amet di Antonio Silvestre, Marjan – nero – di Giovanni Sisto. Il contenuto dell’ultimo è il seguente: si pagheranno a Giovanni Sisto 55 scudi e 4 reali equivalenti a 144 lire di cui il detto Sisto è creditore da Marjan, suo schiavo, come completamento dei 60 scudi totali previsti dall’atto di taglia redatto davanti al notaio Melchiorre de Silvia il 24 gennaio 1562. La taglia di Marjan doveva essere pagata con uno scudo al mese. Crida sui mori e i turchi l consigliere e governatore del capo di Cagliari e Gallura Miquel de Aragall fa sapere a nome del re che in quei tempi i turchi e mori infedeli e nemici della santa fede cattolica hanno aumentato la loro temerarietà e audacia e vengono nel regno ogni giorno con le loro armate e imbarcazioni, e prendono e fanno schiavi i cristiani oltre a distruggere e rubare quello che possono. Ordina dunque che si voglia provvedere all’indennità del regno e che i mori e turchi siano perseguiti ed estirpati, previa deliberazione degli ufficiali del regio consiglio al riguardo effettuata con l'intervento e la conoscenza del magnifico reggente la procurazione reale a supplica dei magnifici consiglieri della città di Cagliari. Per il tenore della presente crida pubblica, notifica a tutti quelli che vanno per mare o per terra che dovranno perseguire e cacciare dal regno i mori e i turchi e potranno fare di loro e delle loro cose quello che vorranno, tenendo per sé tutto eccetto la decima parte di tutto quello che prenderanno, che dovranno pagare al re tramite il reggente della procurazione reale.
Crida sui mori e i turchi l consigliere e governatore del capo di Cagliari e Gallura Miquel de Aragall fa sapere a nome del re che in quei tempi i turchi e mori infedeli e nemici della santa fede cattolica hanno aumentato la loro temerarietà e audacia e vengono nel regno ogni giorno con le loro armate e imbarcazioni, e prendono e fanno schiavi i cristiani oltre a distruggere e rubare quello che possono. Ordina dunque che si voglia provvedere all’indennità del regno e che i mori e turchi siano perseguiti ed estirpati, previa deliberazione degli ufficiali del regio consiglio al riguardo effettuata con l'intervento e la conoscenza del magnifico reggente la procurazione reale a supplica dei magnifici consiglieri della città di Cagliari. Per il tenore della presente crida pubblica, notifica a tutti quelli che vanno per mare o per terra che dovranno perseguire e cacciare dal regno i mori e i turchi e potranno fare di loro e delle loro cose quello che vorranno, tenendo per sé tutto eccetto la decima parte di tutto quello che prenderanno, che dovranno pagare al re tramite il reggente della procurazione reale.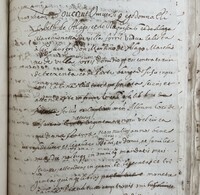 Liberazione di Amet Bofetil che ha servito e pagato secondo gli accordi Elisabetta Alagon y Requenses, marchesa di Villasor, vedova di don Martino de Alagon libera il suo schiavo bianco di nome Amet Bofetil, proveniente da Biserta, di 30 anni e di statura media. Afferma che lo schiavo da anni ha servito bene lei, la sua casa e la sua famiglia, fedelmente e legalmente, giorno e notte, obbedendo a tutti i suoi ordini. In considerazione delle 335 lire di denaro cagliaritano, prezzo dell’acquisto di Amet, che egli stesso le ha restituito e pagato, donna Elisabetta per propria volontà e per la remissione dei peccati libera Amet Bofetil e tutta la sua prole, liberandoli da qualunque dominio e imposizione. Potranno recarsi dovunque vorranno e dimorare ovunque vorranno, potranno testimoniare, contrattare e stipulare in giudizio come qualsiasi cittadino e persona libera. Potranno scegliere il padrone che vorranno senza impedimento. Amet riconosce al patrone Salvador Izzo, napoletano di Torre del Greco, che gli deve 170 pesses da 8 reali castigliani del valore di 340 lire cagliaritane per altrettante che il detto Izzo gli ha prestato graziosamente per pagare il prezzo del riscatto alla marchesa Alagon e Requesens. Amet promette di pagare il suo debito una volta che arriverà in Berberia.
Liberazione di Amet Bofetil che ha servito e pagato secondo gli accordi Elisabetta Alagon y Requenses, marchesa di Villasor, vedova di don Martino de Alagon libera il suo schiavo bianco di nome Amet Bofetil, proveniente da Biserta, di 30 anni e di statura media. Afferma che lo schiavo da anni ha servito bene lei, la sua casa e la sua famiglia, fedelmente e legalmente, giorno e notte, obbedendo a tutti i suoi ordini. In considerazione delle 335 lire di denaro cagliaritano, prezzo dell’acquisto di Amet, che egli stesso le ha restituito e pagato, donna Elisabetta per propria volontà e per la remissione dei peccati libera Amet Bofetil e tutta la sua prole, liberandoli da qualunque dominio e imposizione. Potranno recarsi dovunque vorranno e dimorare ovunque vorranno, potranno testimoniare, contrattare e stipulare in giudizio come qualsiasi cittadino e persona libera. Potranno scegliere il padrone che vorranno senza impedimento. Amet riconosce al patrone Salvador Izzo, napoletano di Torre del Greco, che gli deve 170 pesses da 8 reali castigliani del valore di 340 lire cagliaritane per altrettante che il detto Izzo gli ha prestato graziosamente per pagare il prezzo del riscatto alla marchesa Alagon e Requesens. Amet promette di pagare il suo debito una volta che arriverà in Berberia.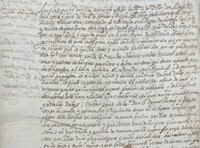 Provvedimenti per evitare che gli schiavi fuggano con barche Pochi mesi dopo la pubblicazione del pregone precedente, nella necessità di stabilire maggiore controllo, un altro avviso indica che i proprietari di barche non siano più gli unici responsabili delle fughe ma, insieme a loro, anche le corporazioni di cui facevano parte (San Pietro e Sant’Elmo) e, inoltre, che tutte le barche vengano iscritte a un registro: 200 ducati di multa e l’imputazione della colpa delle fughe sarebbero le pene comminate in caso di mancato rispetto della norma.
Provvedimenti per evitare che gli schiavi fuggano con barche Pochi mesi dopo la pubblicazione del pregone precedente, nella necessità di stabilire maggiore controllo, un altro avviso indica che i proprietari di barche non siano più gli unici responsabili delle fughe ma, insieme a loro, anche le corporazioni di cui facevano parte (San Pietro e Sant’Elmo) e, inoltre, che tutte le barche vengano iscritte a un registro: 200 ducati di multa e l’imputazione della colpa delle fughe sarebbero le pene comminate in caso di mancato rispetto della norma.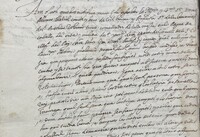 Pregone del viceré sulla fuga degli schiavi Il viceré de Erill pubblica un grida urgente, immediatamente dopo che numerosi schiavi sono fuggiti nella notte del 6 giugno. Tale ordinanza ripropone gli obblighi di sorveglianza e custodia delle barche emessi precedentemente e inasprisce di gran lunga le pene per chi non denunci – pur essendone a conoscenza – notizie su schiavi fuggitivi: si prescrive la pena di morte.
Pregone del viceré sulla fuga degli schiavi Il viceré de Erill pubblica un grida urgente, immediatamente dopo che numerosi schiavi sono fuggiti nella notte del 6 giugno. Tale ordinanza ripropone gli obblighi di sorveglianza e custodia delle barche emessi precedentemente e inasprisce di gran lunga le pene per chi non denunci – pur essendone a conoscenza – notizie su schiavi fuggitivi: si prescrive la pena di morte. Pregone del viceré sugli schiavi Il viceré de Erill ordina tutti i moriscos affrancati che vivono e abitano nella città di Cagliari si presentino davanti a lui entro due giorni dalla pubblicazione del pregone, sia uomini che donne. Chi si trova nel resto del Regno di Sardegna ha otto giorni di tempo per fare lo stesso. La pena in caso di mancato rispetto sarà la galera perpetua per gli uomini e 200 frustate e la confisca dei beni per le donne. Impone ancora che nessuno abbia alcun tipo di rapporto con gli schiavi o li ospiti o li nutra; ai padroni di imbarcazioni ancora si intima di non imbarcarli. La punizione per qualunque abitante del Regno che trasgredisca sarà due anni nelle galere e per i comandanti e proprietari di barche la morte e la confisca dei beni. Non solo pene severe ma perfino incentivi alla denuncia: il viceré promette che, chiunque fornisca alle autorità informazioni su schiavi fuggitivi tenuti nascosti o imbarcati o qualunque notizia in merito a tentativi di protezione o favoreggiamento, otterrebbe un terzo dei beni dei trasgressori.
Pregone del viceré sugli schiavi Il viceré de Erill ordina tutti i moriscos affrancati che vivono e abitano nella città di Cagliari si presentino davanti a lui entro due giorni dalla pubblicazione del pregone, sia uomini che donne. Chi si trova nel resto del Regno di Sardegna ha otto giorni di tempo per fare lo stesso. La pena in caso di mancato rispetto sarà la galera perpetua per gli uomini e 200 frustate e la confisca dei beni per le donne. Impone ancora che nessuno abbia alcun tipo di rapporto con gli schiavi o li ospiti o li nutra; ai padroni di imbarcazioni ancora si intima di non imbarcarli. La punizione per qualunque abitante del Regno che trasgredisca sarà due anni nelle galere e per i comandanti e proprietari di barche la morte e la confisca dei beni. Non solo pene severe ma perfino incentivi alla denuncia: il viceré promette che, chiunque fornisca alle autorità informazioni su schiavi fuggitivi tenuti nascosti o imbarcati o qualunque notizia in merito a tentativi di protezione o favoreggiamento, otterrebbe un terzo dei beni dei trasgressori.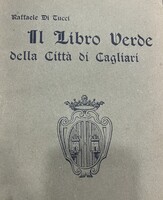 Limitazione alla concessione di salvacondotti agli schiavi mori Il re Filippo III scrive ai Consiglieri, al Presidente del Regno, al Reggente la Real Cancelleria e ai dottori della Reale Udienza del Regno di Sardegna. Afferma di comprendere i disagi e i danni (prigionie, rapine, disgrazie e morti) dovuti ai salvacondotti che finora sono stati concessi e vengono concessi agli schiavi mori e turchi che vengono riscattati in questo Regno e ritornano alle loro terre. Infatti essi, come ladri di case e persone, conoscono i territori, avvertono e accompagnano gli infedeli a sbarcare e compiere i delitti già menzionati a danno degli abitanti di questo Regno. Per questo saranno puniti severamente e saranno ritenuti responsabili.
Limitazione alla concessione di salvacondotti agli schiavi mori Il re Filippo III scrive ai Consiglieri, al Presidente del Regno, al Reggente la Real Cancelleria e ai dottori della Reale Udienza del Regno di Sardegna. Afferma di comprendere i disagi e i danni (prigionie, rapine, disgrazie e morti) dovuti ai salvacondotti che finora sono stati concessi e vengono concessi agli schiavi mori e turchi che vengono riscattati in questo Regno e ritornano alle loro terre. Infatti essi, come ladri di case e persone, conoscono i territori, avvertono e accompagnano gli infedeli a sbarcare e compiere i delitti già menzionati a danno degli abitanti di questo Regno. Per questo saranno puniti severamente e saranno ritenuti responsabili.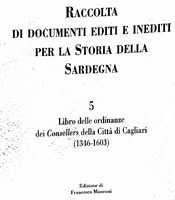 Crida del Veguer real Antioco Barbarà sul buon governo della città e sull'amministrazione della giustizia. Il veghiere reale Antiogo Barbarà informa che per volontà dei consiglieri di Cagliari sono state emesse le seguenti ordinanze che chiunque deve rispettare per provvedere al buon governo e amministrazione della giustizia e tranquillità della città e ovviare ai disordini, sinistri e pericoli che possono capitare. Ordina che nessuno possa andare in giro di notte dopo il suono della campana senza luce. Chi sarà trovato dovrà passare tre giorni in prigione, e se sarà uno schiavo riceverà 50 frustate. Ordina che gli schiavi, le schiave e i giovani in età da matrimonio di età inferiore o uguale a 15 anni non vengano accolti in nessuna taverna o casa né di notte né di giorno, sotto la pena di cinque lire. Ordina che nessuno possa acquistare da schiavi o servi di età inferiore ai 15 anni nessuna merce, né possano tenere loro merce nelle proprie case né prendere ordini da quelli. La pena in caso di disobbedienza è di 25 lire. Ordina che nessun proprietario di barche osi tenerle slegate e con gli arnesi da navigazioni e le armi all’interno, né di notte né di giorno. La pena in caso di contravvenzione dell’ordine sarà di 25 lire più il risarcimento ai legittimi proprietari del valore degli schiavi che con dette barche saranno fuggiti. Si fa eccezione per le barche grosse più di 120 quintali in su, le quali possono stare senza catena e non incorrere in nessuna pena. Infine ordina che nessun moro affrancato, che sia sposato o celibe, entro 15 giorni dalla pubblicazione di queste ordinanze, possa risiedere in una casa dentro la città e il castello di Cagliari sotto pena di 10 lire e 100 frustate; inoltre non possono essere accolti in nessuna casa o taverna da nessuno sotto pena di 5 lire per ogni volta che l’ordine sarà contravvenuto.
Crida del Veguer real Antioco Barbarà sul buon governo della città e sull'amministrazione della giustizia. Il veghiere reale Antiogo Barbarà informa che per volontà dei consiglieri di Cagliari sono state emesse le seguenti ordinanze che chiunque deve rispettare per provvedere al buon governo e amministrazione della giustizia e tranquillità della città e ovviare ai disordini, sinistri e pericoli che possono capitare. Ordina che nessuno possa andare in giro di notte dopo il suono della campana senza luce. Chi sarà trovato dovrà passare tre giorni in prigione, e se sarà uno schiavo riceverà 50 frustate. Ordina che gli schiavi, le schiave e i giovani in età da matrimonio di età inferiore o uguale a 15 anni non vengano accolti in nessuna taverna o casa né di notte né di giorno, sotto la pena di cinque lire. Ordina che nessuno possa acquistare da schiavi o servi di età inferiore ai 15 anni nessuna merce, né possano tenere loro merce nelle proprie case né prendere ordini da quelli. La pena in caso di disobbedienza è di 25 lire. Ordina che nessun proprietario di barche osi tenerle slegate e con gli arnesi da navigazioni e le armi all’interno, né di notte né di giorno. La pena in caso di contravvenzione dell’ordine sarà di 25 lire più il risarcimento ai legittimi proprietari del valore degli schiavi che con dette barche saranno fuggiti. Si fa eccezione per le barche grosse più di 120 quintali in su, le quali possono stare senza catena e non incorrere in nessuna pena. Infine ordina che nessun moro affrancato, che sia sposato o celibe, entro 15 giorni dalla pubblicazione di queste ordinanze, possa risiedere in una casa dentro la città e il castello di Cagliari sotto pena di 10 lire e 100 frustate; inoltre non possono essere accolti in nessuna casa o taverna da nessuno sotto pena di 5 lire per ogni volta che l’ordine sarà contravvenuto.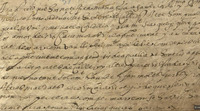 Sulla fuga degli schiavi L’Arcivescovo Lasso Sedeño con questa ordinanza riprende precedenti prescrizioni in merito agli schiavi e torna a proibire che essi girino di notte liberamente per Castello e per le appendici di Cagliari in quanto porebbero commettere furti e altri delitti o perfino fuggire. Dopo il suono della preghiera della notte gli schiavi di Castello dovevano rientrare nel Castello e quelli delle tre appendici non potevano lasciare la propria abitazione a eccezione di trovarsi in compagnia del padrone. La pena sarebbe di cento frustate per la prima trasgressione, 200 per la seconda ed essere mandati alla Galera nella squadra del re, perpetuamente, per la terza. Per la stessa ragione si afferma che gli schiavi non possano andare in giro in gruppo ma al massimo in due, con eccezione di quando si recano alle fontane per compiere servizio al proprio padrone portandogli l’acqua. In caso di contravvenzione alla norma sarebbero puniti con 100 frustate e la condanna ai servizi per la costruzione di opere regie. Ancora l’ordinanza dell’arcivescovo sottolinea, nell’ottica di prevenire le fughe degli schiavi dal Regno, l’obbligo dei padroni di imbarcazioni di tenerle ben legate e custodite e senza armi o utensili da navigazione a bordo. La pena, in caso di mancato rispetto, sarebbe la confisca della barca e l’esilio perpetuo per i padroni delle barche e, per gli schiavi trovati a fuggire con le stesse, la condanna perpetua al remo nelle galere di Sua Maestà. Ancora viene proibito agli schiavi mori di portare con sé armi poiché, si dice, sono soliti affrontarsi in risse e aggredire altri schiavi o perfino cristiani. Si ripropone la norma già più volte emanata per la quale nessuno schiavo, musulmano o convertito, possa recarsi nelle taverne e nessun taverniere, dal canto suo, possa accoglierli: si vuole impedire che si ubriachino, omettendo i propri compiti o perpetrando atti delittuosi.
Sulla fuga degli schiavi L’Arcivescovo Lasso Sedeño con questa ordinanza riprende precedenti prescrizioni in merito agli schiavi e torna a proibire che essi girino di notte liberamente per Castello e per le appendici di Cagliari in quanto porebbero commettere furti e altri delitti o perfino fuggire. Dopo il suono della preghiera della notte gli schiavi di Castello dovevano rientrare nel Castello e quelli delle tre appendici non potevano lasciare la propria abitazione a eccezione di trovarsi in compagnia del padrone. La pena sarebbe di cento frustate per la prima trasgressione, 200 per la seconda ed essere mandati alla Galera nella squadra del re, perpetuamente, per la terza. Per la stessa ragione si afferma che gli schiavi non possano andare in giro in gruppo ma al massimo in due, con eccezione di quando si recano alle fontane per compiere servizio al proprio padrone portandogli l’acqua. In caso di contravvenzione alla norma sarebbero puniti con 100 frustate e la condanna ai servizi per la costruzione di opere regie. Ancora l’ordinanza dell’arcivescovo sottolinea, nell’ottica di prevenire le fughe degli schiavi dal Regno, l’obbligo dei padroni di imbarcazioni di tenerle ben legate e custodite e senza armi o utensili da navigazione a bordo. La pena, in caso di mancato rispetto, sarebbe la confisca della barca e l’esilio perpetuo per i padroni delle barche e, per gli schiavi trovati a fuggire con le stesse, la condanna perpetua al remo nelle galere di Sua Maestà. Ancora viene proibito agli schiavi mori di portare con sé armi poiché, si dice, sono soliti affrontarsi in risse e aggredire altri schiavi o perfino cristiani. Si ripropone la norma già più volte emanata per la quale nessuno schiavo, musulmano o convertito, possa recarsi nelle taverne e nessun taverniere, dal canto suo, possa accoglierli: si vuole impedire che si ubriachino, omettendo i propri compiti o perpetrando atti delittuosi. Sul maltrattamento degli schiavi L’arcivescovo di Cagliari Alonso Lasso Sedeño, reggente della carica vicereale nel Regno di Sardegna, afferma che molti abitanti del Regno trattano molto male gli schiavi, con violenze fisiche e verbali. Sia gli schiavi musulmani che quelli convertiti al cristianesimo ne sono vittima. Ritiene che queste violenze siano la causa dell’allontanamento dei convertiti dalla religione cattolica e il mancato avvicinamento ad essa dei mori. Ordina, perciò, che nessuno osi più praticare nessun tipo di violenza e che solamente i padroni degli schiavi possano, personalmente e per giusta causa, punire i propri schiavi.
Sul maltrattamento degli schiavi L’arcivescovo di Cagliari Alonso Lasso Sedeño, reggente della carica vicereale nel Regno di Sardegna, afferma che molti abitanti del Regno trattano molto male gli schiavi, con violenze fisiche e verbali. Sia gli schiavi musulmani che quelli convertiti al cristianesimo ne sono vittima. Ritiene che queste violenze siano la causa dell’allontanamento dei convertiti dalla religione cattolica e il mancato avvicinamento ad essa dei mori. Ordina, perciò, che nessuno osi più praticare nessun tipo di violenza e che solamente i padroni degli schiavi possano, personalmente e per giusta causa, punire i propri schiavi.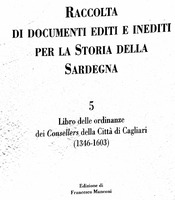 Crida del veghiere reale relativa all'osservanza di varie ordinanze Il veghiere reale di Cagliari Hieroni Vigili de Alagò annuncia, per volontà dei consiglieri di Cagliari, che sono state prescritte le seguenti ordinazioni per provvedere al buon governo e all'amministrazione della giustizia, alla tranquillità e al riposo degli abitanti della città e delle sue appendici e per ovviare ai disordini, ai sinistri pericoli e agli inconvenienti che potrebbero derivare. Tutti dovranno obbedire a quanto indicato. Ordina che nessuno possa andare in giro di notte dopo il suono della campana senza luce. Chi sarà trovato dovrà passare tre giorni in prigione, e se sarà uno schiavo riceverà 50 frustate. Ordina che gli schiavi, le schiave e i giovani in età da matrimonio di età inferiore o uguale a 15 anni non vengano accolti in nessuna taverna o casa né di notte né di giorno, sotto la pena di cinque lire. Ordina che nessuno possa acquistare da schiavi o servi di età inferiore ai 15 anni nessuna merce, né possano tenere loro merce nelle proprie case né prendere ordini da quelli. La pena in caso di disobbedienza è di 25 lire. Ordina che nessun proprietario di barche osi tenerle slegate e con gli arnesi da navigazioni e le armi all’interno, né di notte né di giorno. La pena in caso di contravvenzione dell’ordine sarà di 25 lire più il risarcimento del valore degli schiavi che non dette barche saranno fuggiti ai legittimi proprietari. Infine ordina che nessun moro affrancato, che sia sposato o celibe, entro 15 giorni dalla pubblicazione di queste ordinanze, possa risiedere in una casa dentro la città e il castello di Cagliari sotto pena di 10 lire e 100 frustate. Infine stabilisce che i mori non possano accogliere nessuno in casa propria, sotto pena di 5 lire per ogni volta che l’ordine sarà contravvenuto.
Crida del veghiere reale relativa all'osservanza di varie ordinanze Il veghiere reale di Cagliari Hieroni Vigili de Alagò annuncia, per volontà dei consiglieri di Cagliari, che sono state prescritte le seguenti ordinazioni per provvedere al buon governo e all'amministrazione della giustizia, alla tranquillità e al riposo degli abitanti della città e delle sue appendici e per ovviare ai disordini, ai sinistri pericoli e agli inconvenienti che potrebbero derivare. Tutti dovranno obbedire a quanto indicato. Ordina che nessuno possa andare in giro di notte dopo il suono della campana senza luce. Chi sarà trovato dovrà passare tre giorni in prigione, e se sarà uno schiavo riceverà 50 frustate. Ordina che gli schiavi, le schiave e i giovani in età da matrimonio di età inferiore o uguale a 15 anni non vengano accolti in nessuna taverna o casa né di notte né di giorno, sotto la pena di cinque lire. Ordina che nessuno possa acquistare da schiavi o servi di età inferiore ai 15 anni nessuna merce, né possano tenere loro merce nelle proprie case né prendere ordini da quelli. La pena in caso di disobbedienza è di 25 lire. Ordina che nessun proprietario di barche osi tenerle slegate e con gli arnesi da navigazioni e le armi all’interno, né di notte né di giorno. La pena in caso di contravvenzione dell’ordine sarà di 25 lire più il risarcimento del valore degli schiavi che non dette barche saranno fuggiti ai legittimi proprietari. Infine ordina che nessun moro affrancato, che sia sposato o celibe, entro 15 giorni dalla pubblicazione di queste ordinanze, possa risiedere in una casa dentro la città e il castello di Cagliari sotto pena di 10 lire e 100 frustate. Infine stabilisce che i mori non possano accogliere nessuno in casa propria, sotto pena di 5 lire per ogni volta che l’ordine sarà contravvenuto.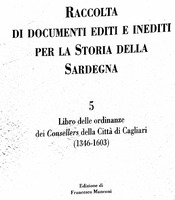 Crida del veghiere di Cagliari sull’igiene pubblica. Miquel Serra, Veguer reale della città e castello di Cagliari, emana le seguenti ordinazioni per volere dei consiglieri della città in merito all'igiene pubblica di Cagliari e delle sue appendici. Per evitare lo stato indecoroso della città e il diffondersi di malattie e morbi è ordinato a tutti di tenerla pulita da ogni immondizia e sporcizia. Nessuno dovrà più gettare rifiuti nelle strade, negli angoli e nelle piazze ma vengono predisposti luoghi appositi della città adibiti al conferimento degli stessi. Il Veguer precisa anche l'ammontare delle pene stabilite per chi non rispetterà le prescrizioni e specifica che, se saranno schiavi a contravvenire alle norme, la pena per loro non sarà pecuniaria ma consisterà in cento frustate.
Crida del veghiere di Cagliari sull’igiene pubblica. Miquel Serra, Veguer reale della città e castello di Cagliari, emana le seguenti ordinazioni per volere dei consiglieri della città in merito all'igiene pubblica di Cagliari e delle sue appendici. Per evitare lo stato indecoroso della città e il diffondersi di malattie e morbi è ordinato a tutti di tenerla pulita da ogni immondizia e sporcizia. Nessuno dovrà più gettare rifiuti nelle strade, negli angoli e nelle piazze ma vengono predisposti luoghi appositi della città adibiti al conferimento degli stessi. Il Veguer precisa anche l'ammontare delle pene stabilite per chi non rispetterà le prescrizioni e specifica che, se saranno schiavi a contravvenire alle norme, la pena per loro non sarà pecuniaria ma consisterà in cento frustate.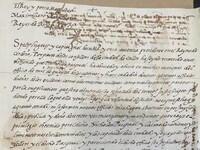 Sugli abusi perpetrati dal Mestre de Guayta Nicolau Pasqual Massimiliano di Boemia scrive, in nome del re Carlo V, al luogotenente e capitano generale del Regno da parte dei Consiglieri della città di Cagliari in merito alla condotta del Mestre de Guayta Nicolau Pasqual. Egli, in base a quanto riferito, abusa e ha abusato in molte maniere del proprio ufficio di Mestre de Guayta degli schiavi. Ogni giorno fa diversi torti sia ai padroni di schiavi e agli schiavi stessi. Pertanto il re ordina che si verifichi il privilegio ottenuto da Pasqual e le moderazioni e le limitazioni che esso contiene. Il suddetto ufficio, inoltre, pare essere infruttuoso e dannoso per il Regno. Col previo consenso del Reggente la Reale Cancelleria, chiamate e ascoltate le parti, prega di stabilire quello che si riterrà opportuno per il migliore servizio al Re e per la buona amministrazione della giustizia e del Regno.
Sugli abusi perpetrati dal Mestre de Guayta Nicolau Pasqual Massimiliano di Boemia scrive, in nome del re Carlo V, al luogotenente e capitano generale del Regno da parte dei Consiglieri della città di Cagliari in merito alla condotta del Mestre de Guayta Nicolau Pasqual. Egli, in base a quanto riferito, abusa e ha abusato in molte maniere del proprio ufficio di Mestre de Guayta degli schiavi. Ogni giorno fa diversi torti sia ai padroni di schiavi e agli schiavi stessi. Pertanto il re ordina che si verifichi il privilegio ottenuto da Pasqual e le moderazioni e le limitazioni che esso contiene. Il suddetto ufficio, inoltre, pare essere infruttuoso e dannoso per il Regno. Col previo consenso del Reggente la Reale Cancelleria, chiamate e ascoltate le parti, prega di stabilire quello che si riterrà opportuno per il migliore servizio al Re e per la buona amministrazione della giustizia e del Regno.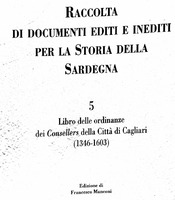 Crida generale del veghiere di Cagliari: provvedimenti sugli schiavi. Il veguer reale, per volontà dei consiglieri di Cagliari nella volontà di preservare la sicurezza della città, visti i molti pericoli che vi si possono incontrare, ordina quanto segue: nessuno si trovi in giro per la città senza luce dopo il suono della campana, sotto pena di tre giorni di prigione. Se sarà uno schiavo a contravvenire, gli verranno date 50 frustate. Ancora ordina che gli schiavi non siano accolti in nessuna taverna né casa, né di notte é di giorno sotto pena di 5 lire. Nessuno possa comprare da schiavi alcuna mercanzia, né nascondere mercanzie di schiavi nella propria casa, né prendere ordini dagli schiavi. Pena 25 lire. Infine si ordina che chiunque possieda barche debba custodirle attentamente, mai lasciarle slegate o con a bordo gli strumenti per la navigazione. La pena è di 25 lire, aggiunte all’obbligo di ripagare i padroni degli schiavi che avranno usato quelle imbarcazioni per fuggire del valore degli schiavi.
Crida generale del veghiere di Cagliari: provvedimenti sugli schiavi. Il veguer reale, per volontà dei consiglieri di Cagliari nella volontà di preservare la sicurezza della città, visti i molti pericoli che vi si possono incontrare, ordina quanto segue: nessuno si trovi in giro per la città senza luce dopo il suono della campana, sotto pena di tre giorni di prigione. Se sarà uno schiavo a contravvenire, gli verranno date 50 frustate. Ancora ordina che gli schiavi non siano accolti in nessuna taverna né casa, né di notte é di giorno sotto pena di 5 lire. Nessuno possa comprare da schiavi alcuna mercanzia, né nascondere mercanzie di schiavi nella propria casa, né prendere ordini dagli schiavi. Pena 25 lire. Infine si ordina che chiunque possieda barche debba custodirle attentamente, mai lasciarle slegate o con a bordo gli strumenti per la navigazione. La pena è di 25 lire, aggiunte all’obbligo di ripagare i padroni degli schiavi che avranno usato quelle imbarcazioni per fuggire del valore degli schiavi.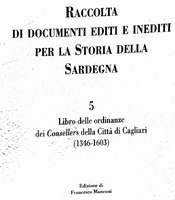 Ordinanza sul Mestre de Guayta degli schiavi Per volontà dei consiglieri e in virtù del privilegio concesso loro di ordinare in materia civile e penale sopra gli schiavi mori, turchi e cristiani che si trovano a Cagliari e nelle sue appendici, viene costituito l'ufficio di Mestre de Guaita, guardiano e custode degli schiavi musulmani e non, per evitare i molti danni che di solito vengono arrecati. Il Mestre de Guayta dovrà controllare gli schiavi sia di notte che di giorno, mentre sono riuniti o giocano, e può confiscare il denaro con cui giocano e punirli con 50 frustate nella cella della dogana. Nessuno schiavo moro, né turco o cristiano possa recarsi di notte dopo le nove di sera in giro per Cagliari, se non mandati dai propri padroni, o se saranno trovati dal Mestre de Guayta li dovrà prendere e l’indomani fargli dare 50 frustate. Nessun locandiere o locandiere dia cibo o bevande nell'osteria a schiavi mori, turchi o cristiani, sotto pena di quaranta soldi. E agli schiavi che si troveranno in dette taverne si daranno cinquanta frustate. Della pena 10 soldi andranno all'ospedale e il resto al detto Mestre de Guayta. Tutti gli schiavi mori, turchi o cristiani devono obbedire al Mestre de Guayta sotto la pena di 100 frustate. Se qualche schiavo fuggirà dai suoi padroni, il Mestre de Guayta dovrà cercarlo e prendere le dovute misure per catturarlo e dovrà avvisare le guardie dei capi di Sant’Elia, Pula e Carbonara, raggruppare le barche sia dal mare che dallo stagno, e avvisare Uta, Assemini e Quartu, e restituirli ai loro proprietari. Le spese saranno a carico del suddetto Mestre de Guayta, che se le avrà fatte non sarà obbligato a fare nient'altro. I consiglieri ordinano ancora che qualsiasi schiavo sia trovato a rubare, perderà la taglia se ha rubato al suo padrone. Se non sarà attallato sarà punito secondo la sua colpa. Inoltre, se il Mestre de Guayta troverà al porto di Cagliari barche che non siano legate con la catena o chiave o se troverà remi, timoni, vele e materiale da navigazione, i padroni delle barche dovranno pagargli ogni volta cinque lire. Ancora si ordina che ogni padrone di schiavo debba versare per il compenso che spetta all'ufficiale 20 soldi in moneta cagliaritana per ciascuno schiavo che possiede. Il re precisa che pagheranno solo quelli che vorranno pagare, e altrimenti paghino gli schiavi. Ordinano che il Mestre de Guayta venga eletto dal viceré e debba giurare di osservare queste ordinanze, di girare per Cagliari ogni notte e giorno facendo la perlustrazione e portando con sé l’insegna del suo titolo. Il viceré elegge Nicolau Pasqual come Mestre de Guayta degli schiavi.
Ordinanza sul Mestre de Guayta degli schiavi Per volontà dei consiglieri e in virtù del privilegio concesso loro di ordinare in materia civile e penale sopra gli schiavi mori, turchi e cristiani che si trovano a Cagliari e nelle sue appendici, viene costituito l'ufficio di Mestre de Guaita, guardiano e custode degli schiavi musulmani e non, per evitare i molti danni che di solito vengono arrecati. Il Mestre de Guayta dovrà controllare gli schiavi sia di notte che di giorno, mentre sono riuniti o giocano, e può confiscare il denaro con cui giocano e punirli con 50 frustate nella cella della dogana. Nessuno schiavo moro, né turco o cristiano possa recarsi di notte dopo le nove di sera in giro per Cagliari, se non mandati dai propri padroni, o se saranno trovati dal Mestre de Guayta li dovrà prendere e l’indomani fargli dare 50 frustate. Nessun locandiere o locandiere dia cibo o bevande nell'osteria a schiavi mori, turchi o cristiani, sotto pena di quaranta soldi. E agli schiavi che si troveranno in dette taverne si daranno cinquanta frustate. Della pena 10 soldi andranno all'ospedale e il resto al detto Mestre de Guayta. Tutti gli schiavi mori, turchi o cristiani devono obbedire al Mestre de Guayta sotto la pena di 100 frustate. Se qualche schiavo fuggirà dai suoi padroni, il Mestre de Guayta dovrà cercarlo e prendere le dovute misure per catturarlo e dovrà avvisare le guardie dei capi di Sant’Elia, Pula e Carbonara, raggruppare le barche sia dal mare che dallo stagno, e avvisare Uta, Assemini e Quartu, e restituirli ai loro proprietari. Le spese saranno a carico del suddetto Mestre de Guayta, che se le avrà fatte non sarà obbligato a fare nient'altro. I consiglieri ordinano ancora che qualsiasi schiavo sia trovato a rubare, perderà la taglia se ha rubato al suo padrone. Se non sarà attallato sarà punito secondo la sua colpa. Inoltre, se il Mestre de Guayta troverà al porto di Cagliari barche che non siano legate con la catena o chiave o se troverà remi, timoni, vele e materiale da navigazione, i padroni delle barche dovranno pagargli ogni volta cinque lire. Ancora si ordina che ogni padrone di schiavo debba versare per il compenso che spetta all'ufficiale 20 soldi in moneta cagliaritana per ciascuno schiavo che possiede. Il re precisa che pagheranno solo quelli che vorranno pagare, e altrimenti paghino gli schiavi. Ordinano che il Mestre de Guayta venga eletto dal viceré e debba giurare di osservare queste ordinanze, di girare per Cagliari ogni notte e giorno facendo la perlustrazione e portando con sé l’insegna del suo titolo. Il viceré elegge Nicolau Pasqual come Mestre de Guayta degli schiavi.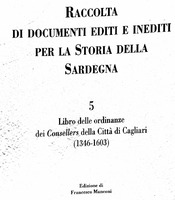 Grida del Mostazzaffo Si ordina che, da ora in avanti, chiunque sia stato schiavo o sia schiavo non possa vendere né vino, né olio e né altre cose da mangiare nella sua casa o bottega di Cagliari e nelle sue appendici. La pena è di 25 lire. Si fa eccezione per coloro che avranno una moglie e figli: costoro sono esenti da questo capitolo.
Grida del Mostazzaffo Si ordina che, da ora in avanti, chiunque sia stato schiavo o sia schiavo non possa vendere né vino, né olio e né altre cose da mangiare nella sua casa o bottega di Cagliari e nelle sue appendici. La pena è di 25 lire. Si fa eccezione per coloro che avranno una moglie e figli: costoro sono esenti da questo capitolo.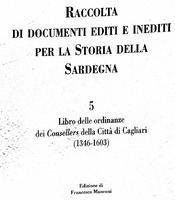 Ordinanza sugli schiavi mori e turchi Il Veghiere di Cagliari Francesch Decena informa tutti delle ordinazioni sui mori e turchi fatte dai consiglieri e probi uomini di Cagliari Arnau Vicent Roca, Pau Comelles, Joan Seguarra, Sabestia del Seu e Pere Desì, e i probiviri Joan Nicolau Aymerich, Miquel Benaprés, Nicolau Marquet, Nicolau Torrella, Antoni Sabrià e altri. In primo luogo si comanda e si ordina che chiunque, di qualsiasi rango o condizione, che abbia o avrà uno o più schiavi mori o turchi, metta una catena del peso di venti libbre di ferro alla gamba di quello o quelli. Successivamente ordinano che chiunque voglia avere o avrà uno o più schiavi mori o turchi, dovrà tenerli ben custoditi e chiusi a chiave dal suono della campana in avanti perché non se ne vadano in giro e per evitare mali e scandali che potrebbero verificarsi. Se gli schiavi verranno trovati in giro per la città fuori orario, subiranno cento frustate e i loro padroni dovranno pagare ogni volta 10 lire. Inoltre ordinano che gli schiavi cristiani e gli schiavi neri, suonata la campana, tornino a casa e non si facciano trovare in giro, sotto pena di 10 lire e di 5 giorni in prigione. I consiglieri ordinano inoltre che qualunque persona che da ora in avanti comprerà schiavi mori o turchi dovrà, entro tre giorni, mettergli la catena al piede come sopra indicato. Comandano ancora che venga nominato Antoni Xarra come Mestre de Guayta della città, col compito di sorvegliare gli schiavi e prevenire comportamenti scorretti da parte loro. Gli schiavi dovranno obbedire all'ufficiale e se non lo faranno la pena sarà di 100 frustate per loro e dieci lire per i padroni. Inoltre il Mestre de Guayta sarà autorizzato a confiscare il denaro, fino a tre soldi, degli schiavi che sorprenderà a giocare. Antoni Xarra è anche corridore pubblico della città. Poiché è necessario che il detto Antoni Xarra sia soddisfatto e debitamente pagato per il suo lavoro, si comanda che ogni proprietario di schiavi mori e turchi paghi in due rate ogni anno per ogni schiavo turco o moro che possiede 12 soldi, per ogni cristiano 10 soldi e per ogni nero 5 soldi e per i bambini 3 soldi. Inoltre, i consiglieri ordinano che se qualcuno degli schiavi mori o turchi sarà assente o fuggirà, i padroni di tali schiavi lo dovranno denunciare ad Antoni Xarra, il quale, a sue spese, dovrà occuparsi di ritrovarli e riconsegnarli ai proprietari. Ancora, ordinano che le barche siano tenute incatenate e ben chiuse a chiave dai loro proprietari che altrimenti saranno passibili di 10 lire di multa per ogni barca trovata sciolta. Inoltre i detti magnifici consiglieri ordinano che nessun proprietario di barche da commercio o da pesca o qualunque altra persona di qualsiasi condizione osi lasciare le vele, i remi, il timone o qualsiasi utensile senza due uomini armati, sotto la pena di lire dieci e perdita della barca.
Ordinanza sugli schiavi mori e turchi Il Veghiere di Cagliari Francesch Decena informa tutti delle ordinazioni sui mori e turchi fatte dai consiglieri e probi uomini di Cagliari Arnau Vicent Roca, Pau Comelles, Joan Seguarra, Sabestia del Seu e Pere Desì, e i probiviri Joan Nicolau Aymerich, Miquel Benaprés, Nicolau Marquet, Nicolau Torrella, Antoni Sabrià e altri. In primo luogo si comanda e si ordina che chiunque, di qualsiasi rango o condizione, che abbia o avrà uno o più schiavi mori o turchi, metta una catena del peso di venti libbre di ferro alla gamba di quello o quelli. Successivamente ordinano che chiunque voglia avere o avrà uno o più schiavi mori o turchi, dovrà tenerli ben custoditi e chiusi a chiave dal suono della campana in avanti perché non se ne vadano in giro e per evitare mali e scandali che potrebbero verificarsi. Se gli schiavi verranno trovati in giro per la città fuori orario, subiranno cento frustate e i loro padroni dovranno pagare ogni volta 10 lire. Inoltre ordinano che gli schiavi cristiani e gli schiavi neri, suonata la campana, tornino a casa e non si facciano trovare in giro, sotto pena di 10 lire e di 5 giorni in prigione. I consiglieri ordinano inoltre che qualunque persona che da ora in avanti comprerà schiavi mori o turchi dovrà, entro tre giorni, mettergli la catena al piede come sopra indicato. Comandano ancora che venga nominato Antoni Xarra come Mestre de Guayta della città, col compito di sorvegliare gli schiavi e prevenire comportamenti scorretti da parte loro. Gli schiavi dovranno obbedire all'ufficiale e se non lo faranno la pena sarà di 100 frustate per loro e dieci lire per i padroni. Inoltre il Mestre de Guayta sarà autorizzato a confiscare il denaro, fino a tre soldi, degli schiavi che sorprenderà a giocare. Antoni Xarra è anche corridore pubblico della città. Poiché è necessario che il detto Antoni Xarra sia soddisfatto e debitamente pagato per il suo lavoro, si comanda che ogni proprietario di schiavi mori e turchi paghi in due rate ogni anno per ogni schiavo turco o moro che possiede 12 soldi, per ogni cristiano 10 soldi e per ogni nero 5 soldi e per i bambini 3 soldi. Inoltre, i consiglieri ordinano che se qualcuno degli schiavi mori o turchi sarà assente o fuggirà, i padroni di tali schiavi lo dovranno denunciare ad Antoni Xarra, il quale, a sue spese, dovrà occuparsi di ritrovarli e riconsegnarli ai proprietari. Ancora, ordinano che le barche siano tenute incatenate e ben chiuse a chiave dai loro proprietari che altrimenti saranno passibili di 10 lire di multa per ogni barca trovata sciolta. Inoltre i detti magnifici consiglieri ordinano che nessun proprietario di barche da commercio o da pesca o qualunque altra persona di qualsiasi condizione osi lasciare le vele, i remi, il timone o qualsiasi utensile senza due uomini armati, sotto la pena di lire dieci e perdita della barca.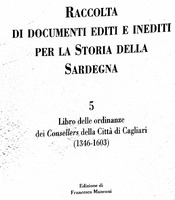 Crida del viceré Fernando de Rebolledo per spronare il Regno a catturare e cacciare i mori Don Ferrando Girón de Rebolledo, viceré di Sardegna, emana questo avviso a causa del fatto che turchi, mori e infedeli, nemici della santa fede cattolica, si recano nel Regno di Sardegna su imbarcazioni, sia in estate che in inverno, per riparare nei porti e insenature e uscire sulla terraferma in flotte armate prendendo e catturando la popolazione, predando e distruggendo tutto ciò che possono, facendo male e danno con crudeltà. Il viceré con il presente appello incoraggia gli abitanti del Regno a sollevarsi contro gli infedeli, informa tutti gli individui del Regno che, chiunque vada per mare o per terra a inseguire, espellere e cacciare dal Regno i mori, e chiunque li catturi otterrà i beni del catturato. Del valore di questi dovrà pagare al re solo una parte e il resto sarà legittimamente suo. Potrà fare quello che vorrà delle persone catturate come se fossero cose proprie guadagnate “de bona guerra”, purché non vada contro i diritti e gli interessi del re.
Crida del viceré Fernando de Rebolledo per spronare il Regno a catturare e cacciare i mori Don Ferrando Girón de Rebolledo, viceré di Sardegna, emana questo avviso a causa del fatto che turchi, mori e infedeli, nemici della santa fede cattolica, si recano nel Regno di Sardegna su imbarcazioni, sia in estate che in inverno, per riparare nei porti e insenature e uscire sulla terraferma in flotte armate prendendo e catturando la popolazione, predando e distruggendo tutto ciò che possono, facendo male e danno con crudeltà. Il viceré con il presente appello incoraggia gli abitanti del Regno a sollevarsi contro gli infedeli, informa tutti gli individui del Regno che, chiunque vada per mare o per terra a inseguire, espellere e cacciare dal Regno i mori, e chiunque li catturi otterrà i beni del catturato. Del valore di questi dovrà pagare al re solo una parte e il resto sarà legittimamente suo. Potrà fare quello che vorrà delle persone catturate come se fossero cose proprie guadagnate “de bona guerra”, purché non vada contro i diritti e gli interessi del re. Crida dei Veghieri di Cagliari Scarper, de Monpalau e Torrella dal 1488 al 1491: ordini sopra gli schiavi. I Veghieri di Cagliari ordinano che ogni schiavo e schiava che verrà trovato di notte dopo il suono della campana riceva il castigo di 26 giorni di prigione senza luce oppure 50 frustate alla pietra della vergogna. Inoltre nessun locandiere o locandiera deve osare accoglierli né di notte né di giorno, sotto pena di tre lire. Ordinano ancora che nessuno acquisti alcun bene dagli schiavi e che nessuno li ospiti nella propria casa o in nessun altro modo, a pena di pagare 26 lire, di perdere la roba e di restituire ciò che ha ricevuto o comprato. Infine ordinano che nessuno, né pescatore né chiunque possieda barche, tenga durante la notte i remi e le vele dentro la sua imbarcazione, sotto la pena di 25 lire. Le imbarcazioni devono essere tenute incatenate. A chi non obbedirà sarà comminata una multa dello stesso ammontare. Se uno schiavo dovesse fuggire per aver trovato barche non legate, i proprietari delle stesse imbarcazioni saranno tenuti a pagare la pena pecuniaria indicata sopra e a pagare il valore dello schiavo al padrone di questo.
Crida dei Veghieri di Cagliari Scarper, de Monpalau e Torrella dal 1488 al 1491: ordini sopra gli schiavi. I Veghieri di Cagliari ordinano che ogni schiavo e schiava che verrà trovato di notte dopo il suono della campana riceva il castigo di 26 giorni di prigione senza luce oppure 50 frustate alla pietra della vergogna. Inoltre nessun locandiere o locandiera deve osare accoglierli né di notte né di giorno, sotto pena di tre lire. Ordinano ancora che nessuno acquisti alcun bene dagli schiavi e che nessuno li ospiti nella propria casa o in nessun altro modo, a pena di pagare 26 lire, di perdere la roba e di restituire ciò che ha ricevuto o comprato. Infine ordinano che nessuno, né pescatore né chiunque possieda barche, tenga durante la notte i remi e le vele dentro la sua imbarcazione, sotto la pena di 25 lire. Le imbarcazioni devono essere tenute incatenate. A chi non obbedirà sarà comminata una multa dello stesso ammontare. Se uno schiavo dovesse fuggire per aver trovato barche non legate, i proprietari delle stesse imbarcazioni saranno tenuti a pagare la pena pecuniaria indicata sopra e a pagare il valore dello schiavo al padrone di questo.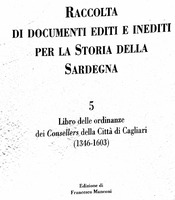 Ordinanza sull’elezione dei consiglieri di Cagliari Nell’ordinanza sull’elezione dei consiglieri della città si precisa che nessun ebreo o moro possa avere incarichi o benefici nella città di Cagliari e possa essere consigliere o giurato della stessa.
Ordinanza sull’elezione dei consiglieri di Cagliari Nell’ordinanza sull’elezione dei consiglieri della città si precisa che nessun ebreo o moro possa avere incarichi o benefici nella città di Cagliari e possa essere consigliere o giurato della stessa.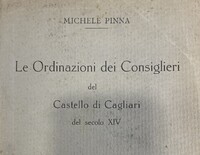 Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari dal 1422 al 1603: provvedimenti sopra gli schiavi Tra le numerose ordinanze dei Consiglieri si leggono le seguenti in merito agli schiavi: ogni persona nel Castello che ha o d'ora in avanti avrà schiavi saraceni, tartari o turchi, siano essi sottoposti a taglia o no, dovrà chiuderli a chiave in casa entro il suono della campana della sera, cosicché non possano uscire senza il permesso del padrone. Ogni volta che, suonata campana, gli schiavi verranno trovati senza catena o senza guardiano, riceveranno 50 frustate e il loro padrone pagherà 5 soldi. In questa disposizione non sono compresi gli schiavi posseduti per servizio personale; nessuno può ricevere mercanzie o denaro dagli schiavi, portati o dati in pegno, palesemente o segretamente. E se le cose rubate saranno del valore di 5 lire in giù, si pagheranno 10 lire di pena, invece se sarà più di 5 lire paghi 25 lire; chiunque sia autore od organizzatore di evasioni, per terra o per mare, se sarà cristiano sarà appeso per il collo affinché muoia, se sarà schiavo o ebreo sarà trascinato per terra affinché muoia. E se uno schiavo che per detta ragione verrà trascinato, sarà saraceno, si risarcirà il suo padrone con uno schiavo scelto tra tutti gli altri schiavi saracini; e se sarà schiavo greco, battezzato, o di altra nazione, il padrone verrà risarcito da parte di tutti gli altri schiavi del prezzo che gli era costato; ogni capitano di imbarcazione deve tirare a terra e rimuovere i remi, le vele e il timone appena avrà toccato il porto. E i remi, vele e timoni devono essere riposti in luoghi sicuri affinché che i mori o gli schiavi non abbiano possibilità di utilizzarli per scappare. Se faranno diversamente incorreranno nella multa di due lire per ogni volta nel tribunale Veghiere di Cagliari. E se, per caso, uno o più schiavi scapperanno con una barca nella quale sono stati lasciati gli attrezzi, il padrone della barca dovrà pagare ai padroni il prezzo degli schiavi oltre che i danni e le spese che dovranno affrontare, oltre a incorrere nella pena prevista; ogni uomo che sarà trovato in congiunzione carnale – e il fatto sarà provato in forma legittima – con schiava, balia o serva del padrone, sarà impiccato e, allo stesso modo, ogni uomo che ingraviderà una schiava d’altri con cui non conviva, sia tenuto a pagare il prezzo della detta schiava al padrone della medesima se per caso la schiava abortisca il bambino o esso muoia dopo la nascita. Se colui che compie il misfatto è uno schiavo, si stabilisce che esso venga diviso in parti uguali tra il padrone della schiava morta e del proprio padrone. E qualora sorga dubbio da chi sia stata ingravidata la schiava, si dovrà credere alla sua parola e al suo giuramento. Il padrone della schiava sia tenuto a rilasciare il bambino avuto dalla schiava con beneficio di libertà e franchigia per 10 lire di moneta corrente. Se però, entro tre giorni dalla sua nascita, il padre del bambino non lo avrà riscattato, il padrone della schiava potrà tenerlo per sé ed averne il prezzo che potrà ricavarne.
Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari dal 1422 al 1603: provvedimenti sopra gli schiavi Tra le numerose ordinanze dei Consiglieri si leggono le seguenti in merito agli schiavi: ogni persona nel Castello che ha o d'ora in avanti avrà schiavi saraceni, tartari o turchi, siano essi sottoposti a taglia o no, dovrà chiuderli a chiave in casa entro il suono della campana della sera, cosicché non possano uscire senza il permesso del padrone. Ogni volta che, suonata campana, gli schiavi verranno trovati senza catena o senza guardiano, riceveranno 50 frustate e il loro padrone pagherà 5 soldi. In questa disposizione non sono compresi gli schiavi posseduti per servizio personale; nessuno può ricevere mercanzie o denaro dagli schiavi, portati o dati in pegno, palesemente o segretamente. E se le cose rubate saranno del valore di 5 lire in giù, si pagheranno 10 lire di pena, invece se sarà più di 5 lire paghi 25 lire; chiunque sia autore od organizzatore di evasioni, per terra o per mare, se sarà cristiano sarà appeso per il collo affinché muoia, se sarà schiavo o ebreo sarà trascinato per terra affinché muoia. E se uno schiavo che per detta ragione verrà trascinato, sarà saraceno, si risarcirà il suo padrone con uno schiavo scelto tra tutti gli altri schiavi saracini; e se sarà schiavo greco, battezzato, o di altra nazione, il padrone verrà risarcito da parte di tutti gli altri schiavi del prezzo che gli era costato; ogni capitano di imbarcazione deve tirare a terra e rimuovere i remi, le vele e il timone appena avrà toccato il porto. E i remi, vele e timoni devono essere riposti in luoghi sicuri affinché che i mori o gli schiavi non abbiano possibilità di utilizzarli per scappare. Se faranno diversamente incorreranno nella multa di due lire per ogni volta nel tribunale Veghiere di Cagliari. E se, per caso, uno o più schiavi scapperanno con una barca nella quale sono stati lasciati gli attrezzi, il padrone della barca dovrà pagare ai padroni il prezzo degli schiavi oltre che i danni e le spese che dovranno affrontare, oltre a incorrere nella pena prevista; ogni uomo che sarà trovato in congiunzione carnale – e il fatto sarà provato in forma legittima – con schiava, balia o serva del padrone, sarà impiccato e, allo stesso modo, ogni uomo che ingraviderà una schiava d’altri con cui non conviva, sia tenuto a pagare il prezzo della detta schiava al padrone della medesima se per caso la schiava abortisca il bambino o esso muoia dopo la nascita. Se colui che compie il misfatto è uno schiavo, si stabilisce che esso venga diviso in parti uguali tra il padrone della schiava morta e del proprio padrone. E qualora sorga dubbio da chi sia stata ingravidata la schiava, si dovrà credere alla sua parola e al suo giuramento. Il padrone della schiava sia tenuto a rilasciare il bambino avuto dalla schiava con beneficio di libertà e franchigia per 10 lire di moneta corrente. Se però, entro tre giorni dalla sua nascita, il padre del bambino non lo avrà riscattato, il padrone della schiava potrà tenerlo per sé ed averne il prezzo che potrà ricavarne.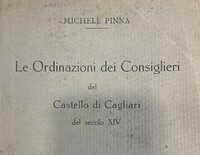 Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del 1346-1347: provvedimenti sopra gli schiavi Tra le ordinanze per la città di Cagliari si rilevano quelle in merito agli schiavi: che nessuno schiavo saracino che faccia settimana (turno di servizio settimanale) non possa andare sprovvisto di ferri nelle gambe, che pesino sei libbre, né passare nel Castello senza guardia dopo il suono della campana, ogni sera al vespro. E se si contravverrà a queste cose il padrone del detto schiavo pagherà la pena di 20 soldi per ogni contravvenzione della norma; che alcuna persona non osi trattare né dar mano a che alcuno schiavo saracino o greco o battezzato o schiava fugga per mare o per terra. E chi contravverrà, se è cristiano sarà impiccato in guisa che muoia e se sarà saracino, battezzato o greco, sarà trascinato per terra in guisa che muoia. E ciò che quello schiavo sarà costato, verrà risarcito e pagato al suo padrone da tutti gli altri schiavi del detto Castello e dai loro padroni; che nessuna persona osi né presuma comprare roba da alcuno schiavo o schiava, né a quello schiavo o schiava concedere prestiti di alcun tipo. E chi contravverrà pagherà ogni volta 100 soldi e perderà quel che avrà prestato e la roba che avrà comprato; che nessuna persona cristiana, ebrea o di altra religione presuma fare dei prestiti a schiavi o schiave altrui. Chi contravverrà dovrà pagare 20 soldi e perderà ciò che ha prestato.
Le ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del 1346-1347: provvedimenti sopra gli schiavi Tra le ordinanze per la città di Cagliari si rilevano quelle in merito agli schiavi: che nessuno schiavo saracino che faccia settimana (turno di servizio settimanale) non possa andare sprovvisto di ferri nelle gambe, che pesino sei libbre, né passare nel Castello senza guardia dopo il suono della campana, ogni sera al vespro. E se si contravverrà a queste cose il padrone del detto schiavo pagherà la pena di 20 soldi per ogni contravvenzione della norma; che alcuna persona non osi trattare né dar mano a che alcuno schiavo saracino o greco o battezzato o schiava fugga per mare o per terra. E chi contravverrà, se è cristiano sarà impiccato in guisa che muoia e se sarà saracino, battezzato o greco, sarà trascinato per terra in guisa che muoia. E ciò che quello schiavo sarà costato, verrà risarcito e pagato al suo padrone da tutti gli altri schiavi del detto Castello e dai loro padroni; che nessuna persona osi né presuma comprare roba da alcuno schiavo o schiava, né a quello schiavo o schiava concedere prestiti di alcun tipo. E chi contravverrà pagherà ogni volta 100 soldi e perderà quel che avrà prestato e la roba che avrà comprato; che nessuna persona cristiana, ebrea o di altra religione presuma fare dei prestiti a schiavi o schiave altrui. Chi contravverrà dovrà pagare 20 soldi e perderà ciò che ha prestato. Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Miquel Mitzavila Il patrone Miquel Mitzavila, maiorchino, afferma di aver venduto e consegnato al pubblico incanto gli schiavi che ha catturato nei giorni passati col suo brigantino nei mari di Sant’Antioco. Riconosce che il prezzo di questi schiavi gli è stato pagato in denaro contante. Le vendite sono state le seguenti: a don Gaspar Pira per 265 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Ali; a don Juseph dela Mata per 282 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo canonico Augusti Murtas per 125 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di cui non è scritto il nome; a don Hieroni Fadda per 270 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Muda; a Marco Furnels per275 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Francesch Taxillo per 288 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo canonico Llorens Sampero per 302 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Bernardo Paulins per 280 lire e un reale di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo don Pere Folgiari per 300 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Cassam; a Antonio Caneu per 300 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Dionis Capai per 252 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Antonio Sauni per 295 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Matheo Benedeto per 275 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a don Gavi Capai per 287 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a padre frate Joan Baptista Leande, vicario generale del convento della santissima trinità, per 256 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Gregori Odger per 175 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Adalla; a Melchior de Castro per 181 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a don Melchior Pirella per 250 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al magnifico don Silverio Bernardi, reggente la reale cancelleria, per 230 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Cassam; a don Pau de Castelvì procuratore reale e giudice del real patrimonio, per 500 lire di moneta di Cagliari, due schiavi di cui non è scritto il nome; al magnifico don Juseph dela Matta per 81 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet. Testimoni sono il dottor Juan Baptista Masons e Pere Sanna, abitanti di Cagliari; Diego Carreli e Francesch Fadda abitanti di Cagliari; Juan Leoni e Andrea Paulis abitanti di Cagliari.
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Miquel Mitzavila Il patrone Miquel Mitzavila, maiorchino, afferma di aver venduto e consegnato al pubblico incanto gli schiavi che ha catturato nei giorni passati col suo brigantino nei mari di Sant’Antioco. Riconosce che il prezzo di questi schiavi gli è stato pagato in denaro contante. Le vendite sono state le seguenti: a don Gaspar Pira per 265 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Ali; a don Juseph dela Mata per 282 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo canonico Augusti Murtas per 125 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di cui non è scritto il nome; a don Hieroni Fadda per 270 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Muda; a Marco Furnels per275 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Francesch Taxillo per 288 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo canonico Llorens Sampero per 302 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Bernardo Paulins per 280 lire e un reale di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al reverendo don Pere Folgiari per 300 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Cassam; a Antonio Caneu per 300 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Dionis Capai per 252 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Antonio Sauni per 295 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al dottor Matheo Benedeto per 275 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a don Gavi Capai per 287 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a padre frate Joan Baptista Leande, vicario generale del convento della santissima trinità, per 256 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a Gregori Odger per 175 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Adalla; a Melchior de Castro per 181 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; a don Melchior Pirella per 250 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet; al magnifico don Silverio Bernardi, reggente la reale cancelleria, per 230 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Cassam; a don Pau de Castelvì procuratore reale e giudice del real patrimonio, per 500 lire di moneta di Cagliari, due schiavi di cui non è scritto il nome; al magnifico don Juseph dela Matta per 81 lire di moneta di Cagliari, uno schiavo di nome Amet. Testimoni sono il dottor Juan Baptista Masons e Pere Sanna, abitanti di Cagliari; Diego Carreli e Francesch Fadda abitanti di Cagliari; Juan Leoni e Andrea Paulis abitanti di Cagliari.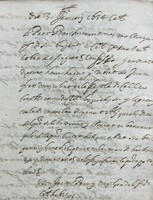 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Barthumeu Torres Il patrone Barhumeu Torres Maiorchino, patrone del suo brigantino, trovandosi personalmente a Cagliari, afferma di aver venduto al pubblico incanto alcuni schiavi catturati col suo brigantino nei mari di Barbaria. Riconosce di aver ricevuto da Juan Font, domiciliato nella Lapola di Cagliari, 100 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Ali; da Juan Lluis Fiorillo 230 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Amor; dal reverendo canonico Thomas Rachis, vicario generale, 200 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Amet. Testimoni sono Jacinto Peiz e Diego Gandulfo abitanti di Cagliari
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Barthumeu Torres Il patrone Barhumeu Torres Maiorchino, patrone del suo brigantino, trovandosi personalmente a Cagliari, afferma di aver venduto al pubblico incanto alcuni schiavi catturati col suo brigantino nei mari di Barbaria. Riconosce di aver ricevuto da Juan Font, domiciliato nella Lapola di Cagliari, 100 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Ali; da Juan Lluis Fiorillo 230 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Amor; dal reverendo canonico Thomas Rachis, vicario generale, 200 lire di moneta cagliaritana, prezzo di uno schiavo di nome Amet. Testimoni sono Jacinto Peiz e Diego Gandulfo abitanti di Cagliari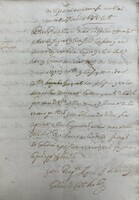 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Barthomeu Didià Il patrone Barthumeu Didià afferma di aver venduto al pubblico incanto alcuni schiavi catturati nei mari di San Pietro. Riconosce di aver ricevuto da Sisinni Geruna, mercante domiciliato a Cagliari, 327 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari prezzo e valore di uno schiavo di nome Cassam, che gli è stato venduto e consegnato nel pubblico incanto il 26 ottobre; da Grabriel Picarall di Stampace, 300 lire di moneta di Cagliari, prezzo di uno schiavo di nome Ali acquistato il 28 di ottobre; da Diego Alonço, negoziante, 255 lire li moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Cassam che gli ha venduto e consegnato nel pubblico incanto il 26 del mese; dal nobile don Gironi Torrella 280 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dall’illustrissimo e reverendissimo signor arcivescovo di Cagliari 278 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; don Gironi Soliman 294 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Mamet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Simoni Montanacho 300 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Augustì Boi 282 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Yaya che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre;dal nobile don Joan Dexart, dottore della reale udienza, 287 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Francesco Abella 308 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Anton de Robles 275 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Augustì Boi 276 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Baptista Murteo 350 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly di Algeri che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Gabriell Picanell 228 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joseph de Taragona 250 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Sisini Adseni 325 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Jeronimo Montañer, segretario di Sua Eccellenza, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi 29 ottobre; da Juan Battista Montanio 75 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet consegnato nel pubblico incanto nella giornata odierna; dal magnifico don Michel Bonfant, giudice di corte per Sua Maestà, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico; dal nobile don Paulo Castelvì, procuratore reale e giudice del real patrimonio, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico; dal magnifico don Antonio Caneles de Vega 250 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Ali che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico. Testimoni sono Baptista Agus e Sisinni Gallus, abitanti di Cagliari.
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Barthomeu Didià Il patrone Barthumeu Didià afferma di aver venduto al pubblico incanto alcuni schiavi catturati nei mari di San Pietro. Riconosce di aver ricevuto da Sisinni Geruna, mercante domiciliato a Cagliari, 327 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari prezzo e valore di uno schiavo di nome Cassam, che gli è stato venduto e consegnato nel pubblico incanto il 26 ottobre; da Grabriel Picarall di Stampace, 300 lire di moneta di Cagliari, prezzo di uno schiavo di nome Ali acquistato il 28 di ottobre; da Diego Alonço, negoziante, 255 lire li moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Cassam che gli ha venduto e consegnato nel pubblico incanto il 26 del mese; dal nobile don Gironi Torrella 280 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dall’illustrissimo e reverendissimo signor arcivescovo di Cagliari 278 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; don Gironi Soliman 294 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Mamet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Simoni Montanacho 300 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Augustì Boi 282 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Yaya che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre;dal nobile don Joan Dexart, dottore della reale udienza, 287 lire e 10 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Francesco Abella 308 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; dal nobile don Anton de Robles 275 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Augustì Boi 276 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Baptista Murteo 350 lire e 5 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly di Algeri che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Gabriell Picanell 228 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Aly che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joseph de Taragona 250 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Sisini Adseni 325 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato nell’incanto pubblico il 26 ottobre; da Joan Jeronimo Montañer, segretario di Sua Eccellenza, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi 29 ottobre; da Juan Battista Montanio 75 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet consegnato nel pubblico incanto nella giornata odierna; dal magnifico don Michel Bonfant, giudice di corte per Sua Maestà, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico; dal nobile don Paulo Castelvì, procuratore reale e giudice del real patrimonio, 200 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Amet che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico; dal magnifico don Antonio Caneles de Vega 250 lire di moneta di Cagliari per uno schiavo di nome Ali che gli ha venduto e consegnato oggi nell’incanto pubblico. Testimoni sono Baptista Agus e Sisinni Gallus, abitanti di Cagliari.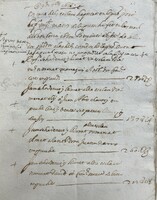 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Miquel Matos Vendita al pubblico incanto degli schiavi che ha portato nel porto di Cagliari il patrone Miquel Matos, catturati nella presa che egli ha fatto nei mari di Barberia col suo brigantino per istanza di Salvador Puddo, altro dei corridori della città. Della presa il patrone non paga diritto alla regia corte secondo una determinazione del regio patrimonio. Primo si vende uno schiavo bianco di nome Marraquis a don Francesco Corts per 250 lire Un altro schiavo di nome Ali a Juan Abros Chavari per 137 lire e 10 soldi Un altro schiavo di nome Amet a donna Juana Narro per 260 lire Un altro schiavo di nome David a Francesch Manca sabater per 202 lire e 15 soldi Un altro schiavo di nome Asach a don Gaspar Pira, dottore della reale udienza, per 161 lire Un altro schiavo di nome Ali a don Juan de Andrada per 120 lire. Nelle sei carte successive si trovano i singoli atti di vendita degli schiavi e i nomi dei testimoni che sono gli stessi per tutte le vendite: Jacinto Peris e Diego Cau, abitanti di Cagliari.
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Miquel Matos Vendita al pubblico incanto degli schiavi che ha portato nel porto di Cagliari il patrone Miquel Matos, catturati nella presa che egli ha fatto nei mari di Barberia col suo brigantino per istanza di Salvador Puddo, altro dei corridori della città. Della presa il patrone non paga diritto alla regia corte secondo una determinazione del regio patrimonio. Primo si vende uno schiavo bianco di nome Marraquis a don Francesco Corts per 250 lire Un altro schiavo di nome Ali a Juan Abros Chavari per 137 lire e 10 soldi Un altro schiavo di nome Amet a donna Juana Narro per 260 lire Un altro schiavo di nome David a Francesch Manca sabater per 202 lire e 15 soldi Un altro schiavo di nome Asach a don Gaspar Pira, dottore della reale udienza, per 161 lire Un altro schiavo di nome Ali a don Juan de Andrada per 120 lire. Nelle sei carte successive si trovano i singoli atti di vendita degli schiavi e i nomi dei testimoni che sono gli stessi per tutte le vendite: Jacinto Peris e Diego Cau, abitanti di Cagliari.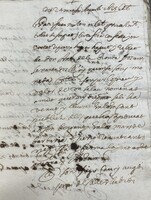 Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Juan Maltes Patrone Juan Maltes ha venduto al pubblico incanto alcuni schiavi che ha catturato nei mari di Barbaria col suo brigantino. Afferma di aver ricevuto da don Anton de la Bronda 262 lire e 15 soldi di moneta cagliaritana per uno schiavo di nome Amet; da Salvator Fontana 162 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari prezzo di uno schiavo di nome Monsor; da Guillem Visent 175 lire e 10 soldi di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Saim; da Pere Vaquer 250 lire e 5 soldi di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Famut; dal reverendo Antoni Quensa, canonico della sede di Cagliari, 300 lire di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Ali. Testimoni sono Diego Cau e Augusti Pixi, abitanti di Cagliari.
Vendite al pubblico incanto gestite dal patrone Juan Maltes Patrone Juan Maltes ha venduto al pubblico incanto alcuni schiavi che ha catturato nei mari di Barbaria col suo brigantino. Afferma di aver ricevuto da don Anton de la Bronda 262 lire e 15 soldi di moneta cagliaritana per uno schiavo di nome Amet; da Salvator Fontana 162 lire e 15 soldi di moneta di Cagliari prezzo di uno schiavo di nome Monsor; da Guillem Visent 175 lire e 10 soldi di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Saim; da Pere Vaquer 250 lire e 5 soldi di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Famut; dal reverendo Antoni Quensa, canonico della sede di Cagliari, 300 lire di moneta cagliaritana prezzo di uno schiavo di nome Ali. Testimoni sono Diego Cau e Augusti Pixi, abitanti di Cagliari.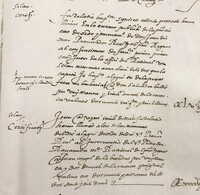 Incanto di schiavi svolto nell’agosto 1605 Il giorno 23 agosto del 1605 a Cagliari Baptista Squirro afferma di aver venduto nel pubblico incanto della città nei giorni precedenti, per ordine del procuratore reale Joan Deixar, e con autorizzazione di Francisco Pinna, primo coadiutore del maestro razionale, uno schiavo di nome Amet Charì dei due che il capitano Johannes Baptista Alaqui (Loqui) aveva preso in Berberia, a don Salvador Bellit per 255 lire. Due giorni dopo, il 25 agosto, ancora afferma di aver venduto uno schiavo di cui non scrive il nome, sempre catturato dal detto Alagui, a Joan Angel dela Bronda per 296 lire, 2 soldi e 6 denari. Sul prezzo degli schiavi venduti si deve prelevare il sei percento da consegnare al regio patrimonio. Firma Miquel Angel Bonfant, notaio.
Incanto di schiavi svolto nell’agosto 1605 Il giorno 23 agosto del 1605 a Cagliari Baptista Squirro afferma di aver venduto nel pubblico incanto della città nei giorni precedenti, per ordine del procuratore reale Joan Deixar, e con autorizzazione di Francisco Pinna, primo coadiutore del maestro razionale, uno schiavo di nome Amet Charì dei due che il capitano Johannes Baptista Alaqui (Loqui) aveva preso in Berberia, a don Salvador Bellit per 255 lire. Due giorni dopo, il 25 agosto, ancora afferma di aver venduto uno schiavo di cui non scrive il nome, sempre catturato dal detto Alagui, a Joan Angel dela Bronda per 296 lire, 2 soldi e 6 denari. Sul prezzo degli schiavi venduti si deve prelevare il sei percento da consegnare al regio patrimonio. Firma Miquel Angel Bonfant, notaio.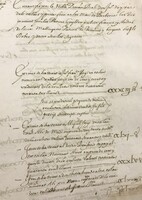 Incanto di schiavi svolto dal 9 al 18 febbraio 1605 Incanto degli schiavi presi dai capitani Andres de Lorca, maiorchino, e Guillelm Prebost, francese, patroni di un brigantino e una tartana, nei mari di Berberia. L’incanto si fa per ordine del procuratore real Joan Deixar e la prima giornata di vendite è il 15 febbraio. Si vendono i seguenti schiavi: a Joan Francisco Jorgi uno schiavo di nome Xaban per 393 lire; a Miquel Jorji uno schiavo piccolo (xich) di nome Ali de Madi per 261 lire; al dottor Bonifacio Capay uno schiavo nominato Amet per 345 lire; don Antonio Brondo acquista un altro schiavo piccolo di nome Ali per 273 lire; il dottor Francesch Adceni compra una schiava di nome Axa per 153 lire; Phelipe Sylvestre acquista uno schiavo di nome Morat de Amet proveniente da Bona per 123 lire; uno schiavo il cui nome non è indicato è venduto a Dionis Bonfant per 189 lire e 5 soldi. Il giorno successivo, 16 febbraio, si prosegue l’incanto e vengono venduti i seguenti schiavi: Amet al dottor Angelo Giagarachio per 348 lire; Say al capitano Andres de Lorca per lo stesso prezzo; uno schiavo di nome Sayeta a Julia’ Tola per 333 lire; a Pere Blancafort si vende uno schiavo di nome Amet per 339 lire e 5 soldi; al reverendo Antonio Marti uno schiavo di nome Sanson, ebreo, per 400 lire. Due giorni dopo continua l’incanto, il 18 febbraio. Pau Orda acquista Ali per 180 lire; Gaspar Bonato acquista Abraim per 360 lire e 5 soldi; Andreu Ramassa compra Amet per 201 lire; Andreas de Lorca compra un altro schiavo di cui non viene specificato il nome per 90 lire e 5 soldi; Catalina Alemania compra uno schiavo di cui non viene indicato il nome per 161 lire e 5 soldi; Thomas Brondo acquista Ambarch per 360 lire e 5 soldi; Nicolao Cachuto compra uno schiavo senza indicazione del nome per 90 lire e 5 soldi; il dottor Soler compra un altro schiavo senza nome per 192 lire e 5 soldi; Antonio Molarja un altro schiavo senza nome per 303 lire; la viceregina acquista una schiava con un figlio per 200 lire. Il 16 marzo dello stesso anno si legge la testimonianza di Antonio Trino, genovese, testimone che giura di dire tutta la verità. Egli riferisce che il viaggio di Prebost è avvenuto nel dicembre del 1604 e si è concluso con una presa di mori. Di questi mori uno, di nome Ambarch, è morto. Inoltre dell'ultima presa, fatta nel mese di febbraio, ne sono morti tre: uno che si chiamava Ali e degli altri due riferisce di non sapere il nome. Il testimone dice di essere a conoscenza di queste cose per aver visto morire quegli uomini in prima persona. Lo stesso giorno viene interrogato un secondo testimone, Sebastianus Palermo di Consevera, che, come il precedente, giura di dire tutta la verità di sua conoscenza. Afferma che dei mori catturati nella presa fatta nel dicembre 1604 dal patrone Guillelm Prebost, ne morì uno che si chiamava Ambarch. Inoltre di quelli catturati nell'ultima presa fatta lo scorso febbraio ne ha visti morire tre, che tuttavia non ricorda. Afferma di avere questa informazione perché li ha visti morire lui stesso.
Incanto di schiavi svolto dal 9 al 18 febbraio 1605 Incanto degli schiavi presi dai capitani Andres de Lorca, maiorchino, e Guillelm Prebost, francese, patroni di un brigantino e una tartana, nei mari di Berberia. L’incanto si fa per ordine del procuratore real Joan Deixar e la prima giornata di vendite è il 15 febbraio. Si vendono i seguenti schiavi: a Joan Francisco Jorgi uno schiavo di nome Xaban per 393 lire; a Miquel Jorji uno schiavo piccolo (xich) di nome Ali de Madi per 261 lire; al dottor Bonifacio Capay uno schiavo nominato Amet per 345 lire; don Antonio Brondo acquista un altro schiavo piccolo di nome Ali per 273 lire; il dottor Francesch Adceni compra una schiava di nome Axa per 153 lire; Phelipe Sylvestre acquista uno schiavo di nome Morat de Amet proveniente da Bona per 123 lire; uno schiavo il cui nome non è indicato è venduto a Dionis Bonfant per 189 lire e 5 soldi. Il giorno successivo, 16 febbraio, si prosegue l’incanto e vengono venduti i seguenti schiavi: Amet al dottor Angelo Giagarachio per 348 lire; Say al capitano Andres de Lorca per lo stesso prezzo; uno schiavo di nome Sayeta a Julia’ Tola per 333 lire; a Pere Blancafort si vende uno schiavo di nome Amet per 339 lire e 5 soldi; al reverendo Antonio Marti uno schiavo di nome Sanson, ebreo, per 400 lire. Due giorni dopo continua l’incanto, il 18 febbraio. Pau Orda acquista Ali per 180 lire; Gaspar Bonato acquista Abraim per 360 lire e 5 soldi; Andreu Ramassa compra Amet per 201 lire; Andreas de Lorca compra un altro schiavo di cui non viene specificato il nome per 90 lire e 5 soldi; Catalina Alemania compra uno schiavo di cui non viene indicato il nome per 161 lire e 5 soldi; Thomas Brondo acquista Ambarch per 360 lire e 5 soldi; Nicolao Cachuto compra uno schiavo senza indicazione del nome per 90 lire e 5 soldi; il dottor Soler compra un altro schiavo senza nome per 192 lire e 5 soldi; Antonio Molarja un altro schiavo senza nome per 303 lire; la viceregina acquista una schiava con un figlio per 200 lire. Il 16 marzo dello stesso anno si legge la testimonianza di Antonio Trino, genovese, testimone che giura di dire tutta la verità. Egli riferisce che il viaggio di Prebost è avvenuto nel dicembre del 1604 e si è concluso con una presa di mori. Di questi mori uno, di nome Ambarch, è morto. Inoltre dell'ultima presa, fatta nel mese di febbraio, ne sono morti tre: uno che si chiamava Ali e degli altri due riferisce di non sapere il nome. Il testimone dice di essere a conoscenza di queste cose per aver visto morire quegli uomini in prima persona. Lo stesso giorno viene interrogato un secondo testimone, Sebastianus Palermo di Consevera, che, come il precedente, giura di dire tutta la verità di sua conoscenza. Afferma che dei mori catturati nella presa fatta nel dicembre 1604 dal patrone Guillelm Prebost, ne morì uno che si chiamava Ambarch. Inoltre di quelli catturati nell'ultima presa fatta lo scorso febbraio ne ha visti morire tre, che tuttavia non ricorda. Afferma di avere questa informazione perché li ha visti morire lui stesso.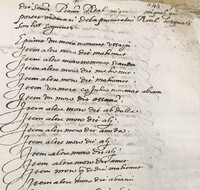 Inventario di schiavi del 3 e 4 febbraio 1605 Inventario degli schiavi, del brigantino e delle robe che Guglielmo Prevost ha preso nei mari di Berberia. Inventario fatto per ordine del signor don Juan Deixer procuratore reale e giudice del reale patrimonio del regno. Dopo aver inventariato il brigantino e gli oggetti il 3 febbraio, gli schiavi vengono inventariati il 4 febbraio alla presenza di Miquel Guasch portiere ordinario della procurazione reale. Gli schiavi catturati sono i seguenti: un moro di nome Ussayn; un altro moro di nome Mahomet; un altro nominato Scander; Mahomet; un altro di nome anch’esso Mahomet; un moro ebreo di nome Abram; Assanam; Abdalla; Ali; Amida; Ali; un altro Ali; Amet; Mahomet; Abraim; Ali; Mahomet; Ali; Ali; Ali; una mora di nome Aissa; Ali; un’altra Aissa; uno schiavetto di nome Mahomet; un ebreo detto Sanson; un altro moro detto Mahomet; Sayte; Charif; Mahomet; Belassem; un moro detto Raban; un altro chiamato Mahomet; un altro moro chiamato Abdalla; Ambarch; Sayt; Ansa Cego; Ambarch; un altro Ambarch; un moro di nome Moratanebi; Sabrit; Mostafa; Ambarch; Mahomet; un moro detto Abraim e un moro ebreo detto Abram; un moro di nome Ali. Si fa nota che sono stati presi due schiavi per il diritto di joya per essere capitani di due diversi vascelli. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio. Firma il notaio Bonfant.
Inventario di schiavi del 3 e 4 febbraio 1605 Inventario degli schiavi, del brigantino e delle robe che Guglielmo Prevost ha preso nei mari di Berberia. Inventario fatto per ordine del signor don Juan Deixer procuratore reale e giudice del reale patrimonio del regno. Dopo aver inventariato il brigantino e gli oggetti il 3 febbraio, gli schiavi vengono inventariati il 4 febbraio alla presenza di Miquel Guasch portiere ordinario della procurazione reale. Gli schiavi catturati sono i seguenti: un moro di nome Ussayn; un altro moro di nome Mahomet; un altro nominato Scander; Mahomet; un altro di nome anch’esso Mahomet; un moro ebreo di nome Abram; Assanam; Abdalla; Ali; Amida; Ali; un altro Ali; Amet; Mahomet; Abraim; Ali; Mahomet; Ali; Ali; Ali; una mora di nome Aissa; Ali; un’altra Aissa; uno schiavetto di nome Mahomet; un ebreo detto Sanson; un altro moro detto Mahomet; Sayte; Charif; Mahomet; Belassem; un moro detto Raban; un altro chiamato Mahomet; un altro moro chiamato Abdalla; Ambarch; Sayt; Ansa Cego; Ambarch; un altro Ambarch; un moro di nome Moratanebi; Sabrit; Mostafa; Ambarch; Mahomet; un moro detto Abraim e un moro ebreo detto Abram; un moro di nome Ali. Si fa nota che sono stati presi due schiavi per il diritto di joya per essere capitani di due diversi vascelli. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio. Firma il notaio Bonfant.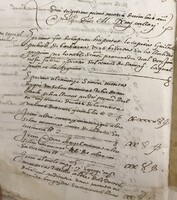 Incanto di schiavi del 31 dicembre 1604 Incanto della presa fatta da Guglielmo Prevost in Berberia, verso Biserta. Incanto fatto per ordine del nobile signor procuratore reale don Nofre Fabra e Deixer. Sono stati venduti: al canonico Simon Montanagio uno schiavo di nome Reba de Ambarch per 240 lire e un altro schiavo di nome Amar de Abdalla per 300 lire; a don Angel Manca Ali de Abraim per 300 lire; al magnifico egregio Monserrat Rossello, dottore della reale udienza, una moretta di nome Bengaida per 300 lire e una schiava di nome Salima de Ali per 357 lire e 5 soldi; a Nicholau Montelles uno schiavo di nome Califi per 171 lire; a Miguel Calabres Tamalla per 150 lire; al viceré uno schiavo di nome Ali per 275 lire, un altro di nome Ottoman per 263 lire; a Nicholau Ventallols una mora con due figli per 363 lire; al canonico Baccallar uno schiavo di nome Amet per 150 lire; al patrone Baptista Frances una schiava nominata Massauda per 30 lire; al marchese di Quirra uno schiavo di nome Sarch per 213 lire; al capitano Christofol Franco Rach per 150 lire.
Incanto di schiavi del 31 dicembre 1604 Incanto della presa fatta da Guglielmo Prevost in Berberia, verso Biserta. Incanto fatto per ordine del nobile signor procuratore reale don Nofre Fabra e Deixer. Sono stati venduti: al canonico Simon Montanagio uno schiavo di nome Reba de Ambarch per 240 lire e un altro schiavo di nome Amar de Abdalla per 300 lire; a don Angel Manca Ali de Abraim per 300 lire; al magnifico egregio Monserrat Rossello, dottore della reale udienza, una moretta di nome Bengaida per 300 lire e una schiava di nome Salima de Ali per 357 lire e 5 soldi; a Nicholau Montelles uno schiavo di nome Califi per 171 lire; a Miguel Calabres Tamalla per 150 lire; al viceré uno schiavo di nome Ali per 275 lire, un altro di nome Ottoman per 263 lire; a Nicholau Ventallols una mora con due figli per 363 lire; al canonico Baccallar uno schiavo di nome Amet per 150 lire; al patrone Baptista Frances una schiava nominata Massauda per 30 lire; al marchese di Quirra uno schiavo di nome Sarch per 213 lire; al capitano Christofol Franco Rach per 150 lire.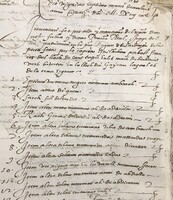 Inventario di schiavi del 27 dicembre 1604 Inventario della presa fatta da Guglielmo Prevost, francese di Sant Torpè, nei mari di Berberia, a Biserta nel luogo di Gayram. L’inventario è fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio don Nofre Fabra y Deixer. Sono inventariati: un moro negro di nome Ambarch; Amet di Quem; Sarch figlio di Amet di quem; noro di nome Ali di Adarailm; Raih, fratello di Ali de Adraim; Reba de Ambarch; schiava di nome Massauda; altra schiava di nome Atega di Nasar; schiava di nome Sada; un bambino piccolo nato sul vascello di nome Joan; un altro schiavo di nome Amar de Abdalla; un altro di nome Ali di Abdicarim; un altro di nome Calif; un altro schiavo di nome Tomalla di Naser; una mora di nome Taila; un’altra mora di nome Salima; un’altra di nome Mangaida; un altro schiavo di nome Ottoman de Ali. Si specifica che di questi ne ha preso alcuni – non si indica quanti né quali – il viceré per il diritto di joya: questo diritto o privilegio consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio. Tutti i mori catturati vengono affidati al capitano Prevost. Testimoni sono Miguel Guasch, portiere ordinario della procurazione reale e Pere Pau Bonfant, mercante abitante in Cagliari.
Inventario di schiavi del 27 dicembre 1604 Inventario della presa fatta da Guglielmo Prevost, francese di Sant Torpè, nei mari di Berberia, a Biserta nel luogo di Gayram. L’inventario è fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio don Nofre Fabra y Deixer. Sono inventariati: un moro negro di nome Ambarch; Amet di Quem; Sarch figlio di Amet di quem; noro di nome Ali di Adarailm; Raih, fratello di Ali de Adraim; Reba de Ambarch; schiava di nome Massauda; altra schiava di nome Atega di Nasar; schiava di nome Sada; un bambino piccolo nato sul vascello di nome Joan; un altro schiavo di nome Amar de Abdalla; un altro di nome Ali di Abdicarim; un altro di nome Calif; un altro schiavo di nome Tomalla di Naser; una mora di nome Taila; un’altra mora di nome Salima; un’altra di nome Mangaida; un altro schiavo di nome Ottoman de Ali. Si specifica che di questi ne ha preso alcuni – non si indica quanti né quali – il viceré per il diritto di joya: questo diritto o privilegio consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio. Tutti i mori catturati vengono affidati al capitano Prevost. Testimoni sono Miguel Guasch, portiere ordinario della procurazione reale e Pere Pau Bonfant, mercante abitante in Cagliari.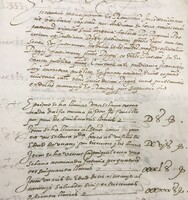 Incanto di schiavi del 21 e 22 ottobre 1604 Incanto degli schiavi presi da Andream de Lorca, maiorchino, nei mari di Berberia con suo brigantino. Incanto fatto per ordine del procuratore reale del regno alla presenza del corridore pubblico Francesco Loi, giurato della curia della città di Cagliari. Sono venduti i seguenti schiavi: Daifa, morena, a don Joan Carillo per 500 lire; al conte di Quirra una schiava di nome Barca con un figlio di un anno per 606 lire; a Miquel Rocca una schiava di nome Fatima per 450 lire; un bambino di sei o sette anni al canonico Salvador Sini per 330 lire. Seconda giornata dell’incanto, 22 ottobre. Si vende uno schiavo moreno a Francesco Volo per 408 lire; uno schiavo di nome Belgassan a Joan Antoni Marti per 462 lire; Odiguit a Miguel Angel Bonfant, notaio, per 347 lire; Belgassan a don Thomas Brondo per 447 lire; al dottor Salvador Carcassona uno schiavo di nome Ali per 501 lire; una schiava di nome Asseminidia con un figlio per 600 lire al dottor Joan Francesco Fundoni; un’altra di nome Amada a Pedro de Ravaneda per 522 lire; uno schiavo mulatto di nome Adalla ad Antoni de Tola per 339 lire insieme ad un altro schiavetto mulatto per 270 lire; una schiava di nome Axia con un figlio a donna Maria Cani per 511 lire; Monsor a Bernard Concas per 33 lire e 5 soldi; Amor a Pedro de Ravaneda per 500 lire e 5 soldi; Adalla a don Joan Naharro de Ruecas, reggente la real tesoreria, per 375 lire; a Francesco Terreros, tesoriere della crociata (thesorer dela crusada), uno schiavo di nome Soliman per 375 lire; al visconte di Sanluri Francesco di Castelvì uno schiavo di nome Abraim per 360 lire e 5 soldi; al maestro Pere Garau del Burgo una schiava di nome Embarca per 600 lire; al magnifico Francesco Pinna (primo coadiutore del razionale) uno schiavetto di nome Ali per 290 lire e 5 soldi; il magnifico Francesco Giagarachio compra un bambino di circa due anni per 172 lire; il patrone Andres de Lorca compra una schiava nera di nome Gemar per 253 lire e una schiava di nome Fatima per 500 lire; Miguel Angel Bonfant, notaio, compra una schiava detta Maria Negra per 282 lire e 5 soldi; il canonico Soler compra una schiava con una figlia di nome Tunes per 679 lire e 5 soldi; il canonico Spiga compra una schiava non identificata per 130 lire; il signor presidente del regno compra un’altra schiava per 500 lire.
Incanto di schiavi del 21 e 22 ottobre 1604 Incanto degli schiavi presi da Andream de Lorca, maiorchino, nei mari di Berberia con suo brigantino. Incanto fatto per ordine del procuratore reale del regno alla presenza del corridore pubblico Francesco Loi, giurato della curia della città di Cagliari. Sono venduti i seguenti schiavi: Daifa, morena, a don Joan Carillo per 500 lire; al conte di Quirra una schiava di nome Barca con un figlio di un anno per 606 lire; a Miquel Rocca una schiava di nome Fatima per 450 lire; un bambino di sei o sette anni al canonico Salvador Sini per 330 lire. Seconda giornata dell’incanto, 22 ottobre. Si vende uno schiavo moreno a Francesco Volo per 408 lire; uno schiavo di nome Belgassan a Joan Antoni Marti per 462 lire; Odiguit a Miguel Angel Bonfant, notaio, per 347 lire; Belgassan a don Thomas Brondo per 447 lire; al dottor Salvador Carcassona uno schiavo di nome Ali per 501 lire; una schiava di nome Asseminidia con un figlio per 600 lire al dottor Joan Francesco Fundoni; un’altra di nome Amada a Pedro de Ravaneda per 522 lire; uno schiavo mulatto di nome Adalla ad Antoni de Tola per 339 lire insieme ad un altro schiavetto mulatto per 270 lire; una schiava di nome Axia con un figlio a donna Maria Cani per 511 lire; Monsor a Bernard Concas per 33 lire e 5 soldi; Amor a Pedro de Ravaneda per 500 lire e 5 soldi; Adalla a don Joan Naharro de Ruecas, reggente la real tesoreria, per 375 lire; a Francesco Terreros, tesoriere della crociata (thesorer dela crusada), uno schiavo di nome Soliman per 375 lire; al visconte di Sanluri Francesco di Castelvì uno schiavo di nome Abraim per 360 lire e 5 soldi; al maestro Pere Garau del Burgo una schiava di nome Embarca per 600 lire; al magnifico Francesco Pinna (primo coadiutore del razionale) uno schiavetto di nome Ali per 290 lire e 5 soldi; il magnifico Francesco Giagarachio compra un bambino di circa due anni per 172 lire; il patrone Andres de Lorca compra una schiava nera di nome Gemar per 253 lire e una schiava di nome Fatima per 500 lire; Miguel Angel Bonfant, notaio, compra una schiava detta Maria Negra per 282 lire e 5 soldi; il canonico Soler compra una schiava con una figlia di nome Tunes per 679 lire e 5 soldi; il canonico Spiga compra una schiava non identificata per 130 lire; il signor presidente del regno compra un’altra schiava per 500 lire.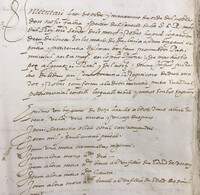 Inventario di schiavi del 18 ottobre 1604 In data 18 ottobre 1604, nel luogo detto La Gruta del Rey a Cagliari, si stila l'inventario della presa fatta da Andreu de Lorca nei mari di Berberia col suo brigantino. L’inventario è fatto per ordine del procuratore reale don Nofre Fabra y Deixer, in presenza di Joan Bonfant procuratore patrimoniale e dell’alcaide reale Matheo Lopez e del notaio e scrivano della procurazione reale. Di questa presa spetta alla regia corte il 2%. L’inventario riporta: una mora di nome Nigenim, una mora di nome Dia, una mora di nome Barca e suo figlietto di un anno, una mora nominata Gauta, una di nome Tunes con sui figlietto di 5 anni, una nominata Aixa, una nominata Fatima, un’altra di nome Fatima con due figli di un anno e di tre anni, una nominata Barca, un’altra Fatima, una mora nominata Deifa, un’altra detta Maria Negra; una mora di nome Gemar; due bambini piccoli di 4 e 8 anni; altri due bambini piccoli di 5 e 7 anni; altri 4 bambini piccoli di 8, 2, 12 e 13 anni; uno schiavo di nome Soliman; un altro di nome Monsor; un altro di nome Oguidet; un altro di nome Ali, un altro di nome Barc; due schiavi chiamati entrambi Belgassan; un altro di nome Abraim. Di questi schiavi alcuni sono stai presi dal viceré per il diritto di joya, ma non viene specificato né quanti né quali. Tutti loro vengono affidati ad Andres de Lorca. Testimoni sono Miguel Vidal, mercante maiorchino e un marinaio abitante di Cagliari di cui non si legge il nome. Il totale è di 33 schiavi inventariati.
Inventario di schiavi del 18 ottobre 1604 In data 18 ottobre 1604, nel luogo detto La Gruta del Rey a Cagliari, si stila l'inventario della presa fatta da Andreu de Lorca nei mari di Berberia col suo brigantino. L’inventario è fatto per ordine del procuratore reale don Nofre Fabra y Deixer, in presenza di Joan Bonfant procuratore patrimoniale e dell’alcaide reale Matheo Lopez e del notaio e scrivano della procurazione reale. Di questa presa spetta alla regia corte il 2%. L’inventario riporta: una mora di nome Nigenim, una mora di nome Dia, una mora di nome Barca e suo figlietto di un anno, una mora nominata Gauta, una di nome Tunes con sui figlietto di 5 anni, una nominata Aixa, una nominata Fatima, un’altra di nome Fatima con due figli di un anno e di tre anni, una nominata Barca, un’altra Fatima, una mora nominata Deifa, un’altra detta Maria Negra; una mora di nome Gemar; due bambini piccoli di 4 e 8 anni; altri due bambini piccoli di 5 e 7 anni; altri 4 bambini piccoli di 8, 2, 12 e 13 anni; uno schiavo di nome Soliman; un altro di nome Monsor; un altro di nome Oguidet; un altro di nome Ali, un altro di nome Barc; due schiavi chiamati entrambi Belgassan; un altro di nome Abraim. Di questi schiavi alcuni sono stai presi dal viceré per il diritto di joya, ma non viene specificato né quanti né quali. Tutti loro vengono affidati ad Andres de Lorca. Testimoni sono Miguel Vidal, mercante maiorchino e un marinaio abitante di Cagliari di cui non si legge il nome. Il totale è di 33 schiavi inventariati.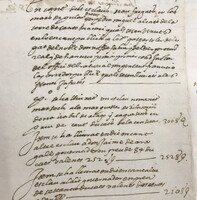 Incanto di schiavi del 25 maggio 1604 Incanto degli schiavi catturati nei mari di Pula da Pedro Miquel, alcaide della torre di San Macario, fatto per ordine di Gaspar Soler, delegato del procuratore reale Fabra y Deixer, e del primo coadiutore del maestro razionale, Francesco Pinna, e alla presenza del corridore pubblico Francesco Loi. Sono state vendute le seguenti persone: uno schiavo di nome Marsoch alla marchesa di Villasor donna Isabel de Alagon e Requenses per 300 lire sarde; due schiavi a don Jaime de Aragall, governatore, uno per 252 lire sarde e l’altro per 210 lire sarde; a Pedro Virde Melone è stato venduto uno schiavo per 279 lire. Si segnala che l’inventario che per prassi avrebbe preceduto questo incanto è assente nel registro BC 31.
Incanto di schiavi del 25 maggio 1604 Incanto degli schiavi catturati nei mari di Pula da Pedro Miquel, alcaide della torre di San Macario, fatto per ordine di Gaspar Soler, delegato del procuratore reale Fabra y Deixer, e del primo coadiutore del maestro razionale, Francesco Pinna, e alla presenza del corridore pubblico Francesco Loi. Sono state vendute le seguenti persone: uno schiavo di nome Marsoch alla marchesa di Villasor donna Isabel de Alagon e Requenses per 300 lire sarde; due schiavi a don Jaime de Aragall, governatore, uno per 252 lire sarde e l’altro per 210 lire sarde; a Pedro Virde Melone è stato venduto uno schiavo per 279 lire. Si segnala che l’inventario che per prassi avrebbe preceduto questo incanto è assente nel registro BC 31.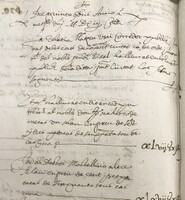 Incanto di schiavi del 5 novembre 1603 In data 5 novembre 1603 il pubblico corridore Matheo Usai stila la relazione del pubblico incanto fatto per ordine del procuratore reale nella città di Cagliari. Sono stati venduti: al nobile don Johan Naharro de Ruecas uno schiavo per 262 lire sarde; un altro schiavo al dottor Mostellino per 267 lire sarde; a Joan Antonio Marti un altro schiavo per 270 lire sarde. Il 4% del valore delle vendite spetta alla regia corte.
Incanto di schiavi del 5 novembre 1603 In data 5 novembre 1603 il pubblico corridore Matheo Usai stila la relazione del pubblico incanto fatto per ordine del procuratore reale nella città di Cagliari. Sono stati venduti: al nobile don Johan Naharro de Ruecas uno schiavo per 262 lire sarde; un altro schiavo al dottor Mostellino per 267 lire sarde; a Joan Antonio Marti un altro schiavo per 270 lire sarde. Il 4% del valore delle vendite spetta alla regia corte.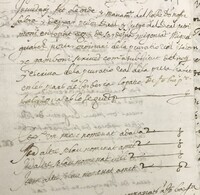 Inventario di schiavi del 17 agosto 1603 Inventario della presa realizzata dal patrone Joan Baptiste Lalgiu nei mari di Berberia, fatto per ordine del nobile procuratore reale e giudice del reale patrimonio alla presenza del portiere ordinario della reale procurazione e dello scrivano sostituto del notaio e scrivano della procurazione reale. L’inventario registra un moro di nome Adalla, uno schiavo di nome Amet, un altro di nome Ali e un altro di nome Amet. Tutti gli schiavi sono affidati a Johan Baptista Loqui. Testimoni: Damia de Ziruli di Sassari e Francesco Guasch, scrivano e abitante di Cagliari. Si fa nota che il viceré ha preso un moro per il diritto di joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.
Inventario di schiavi del 17 agosto 1603 Inventario della presa realizzata dal patrone Joan Baptiste Lalgiu nei mari di Berberia, fatto per ordine del nobile procuratore reale e giudice del reale patrimonio alla presenza del portiere ordinario della reale procurazione e dello scrivano sostituto del notaio e scrivano della procurazione reale. L’inventario registra un moro di nome Adalla, uno schiavo di nome Amet, un altro di nome Ali e un altro di nome Amet. Tutti gli schiavi sono affidati a Johan Baptista Loqui. Testimoni: Damia de Ziruli di Sassari e Francesco Guasch, scrivano e abitante di Cagliari. Si fa nota che il viceré ha preso un moro per il diritto di joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.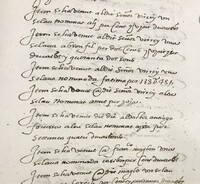 Incanto di schiavi del 2 aprile 1603 Incanto degli schiavi predetti, fatto per ordine del procuratore reale con il consenso del maestro razionale. Il 4% della vendita spetta alla regia corte. Il viceré acquista 7 schiavi: Turquis e Embargua per 220 ducatoni, Ali per 120 ducatoni, una schiava con figlioletto per 227 ducatoni e 42 soldi, Fatima per 138 ducatoni e 48 soldi, Amet preso per il privilegio di joya. Il dottor Antiogo Fortesa acquista Aisse per 74 ducatoni. Francesco Maglon acquista Casiba per 100 ducatoni e Ferech per 140. Il conte di Laconi acquista Malorica per 150 ducatoni, Amet e Salem per 240 ducatoni. A Joan Pere Soler, reggente la real cancelleria, viene venduto Amet per 100 ducatoni. All’arcivescovo di Cagliari vengono venduti Ali e Amet per 220 ducatoni ed Embarga e Amira per 240 ducatoni. Il conte di Quirra acquista Monsor per 125 ducatoni e altri due schiavi per 250 ducatoni. Joan Francesco Jorgi acquista Sale per 120 ducatoni. Al dottor Salvador Carcassona viene venduta Enbarca per 140 ducatoni. Johan Naharro de Ruecas, tesoriere, acquista una schiava con una figlia per 168 ducatoni e 40 soldi. Al reverendo Cristofol Gessa, commissario del Santo Offizio, viene venduta una schiava di nome Aisa per 68 ducatoni. Don Nofre Fabra e Deixer, procuratore reale, compra una schiavetta di nome Embarco per 90 ducatoni. Antonio de Tola compra Embargue, schiavo, per 80 ducatoni. Joan Angel Concas compra una schiava con suo figlio per 133 ducatoni e 18 soldi. Ramon Cetrilla compra Aisa per 70 ducatoni. A Hieroni Pintor viene venduto uno schiavetto di nome Ali per 50 ducatoni. Marianna Aragones e Montelles compra una mora e suo figlio per 117 ducatoni. Balthasar Caseri compra uno schiavo di nome Marquie per 38 ducatoni. Joseph Garous, siciliano, acquista uno schiavetto di due mesi per 11ducatoni e mezzo. Francesco Giagarachio compra una mora e due figli per 150 ducatoni.
Incanto di schiavi del 2 aprile 1603 Incanto degli schiavi predetti, fatto per ordine del procuratore reale con il consenso del maestro razionale. Il 4% della vendita spetta alla regia corte. Il viceré acquista 7 schiavi: Turquis e Embargua per 220 ducatoni, Ali per 120 ducatoni, una schiava con figlioletto per 227 ducatoni e 42 soldi, Fatima per 138 ducatoni e 48 soldi, Amet preso per il privilegio di joya. Il dottor Antiogo Fortesa acquista Aisse per 74 ducatoni. Francesco Maglon acquista Casiba per 100 ducatoni e Ferech per 140. Il conte di Laconi acquista Malorica per 150 ducatoni, Amet e Salem per 240 ducatoni. A Joan Pere Soler, reggente la real cancelleria, viene venduto Amet per 100 ducatoni. All’arcivescovo di Cagliari vengono venduti Ali e Amet per 220 ducatoni ed Embarga e Amira per 240 ducatoni. Il conte di Quirra acquista Monsor per 125 ducatoni e altri due schiavi per 250 ducatoni. Joan Francesco Jorgi acquista Sale per 120 ducatoni. Al dottor Salvador Carcassona viene venduta Enbarca per 140 ducatoni. Johan Naharro de Ruecas, tesoriere, acquista una schiava con una figlia per 168 ducatoni e 40 soldi. Al reverendo Cristofol Gessa, commissario del Santo Offizio, viene venduta una schiava di nome Aisa per 68 ducatoni. Don Nofre Fabra e Deixer, procuratore reale, compra una schiavetta di nome Embarco per 90 ducatoni. Antonio de Tola compra Embargue, schiavo, per 80 ducatoni. Joan Angel Concas compra una schiava con suo figlio per 133 ducatoni e 18 soldi. Ramon Cetrilla compra Aisa per 70 ducatoni. A Hieroni Pintor viene venduto uno schiavetto di nome Ali per 50 ducatoni. Marianna Aragones e Montelles compra una mora e suo figlio per 117 ducatoni. Balthasar Caseri compra uno schiavo di nome Marquie per 38 ducatoni. Joseph Garous, siciliano, acquista uno schiavetto di due mesi per 11ducatoni e mezzo. Francesco Giagarachio compra una mora e due figli per 150 ducatoni. Inventario di schiavi del 27 marzo 1603 Inventario, fatto per ordine del procuratore reale e del portiere ordinario della procurazione reale, alla presenza del sostituto del notaio e scrivano della stessa, della presa di mori fatta nei mari di Berberia dal patrone Guilhelm Prebost con la sua tartana. Del valore della detta presa il 4% spetta alla regia corte. I mori catturati sono: Turquis e Embarga di 12 e 8 anni, Amet, Casiba di 14 anni, Ferech di due anni, Malorica di 17anni, Amet e Salem di 14 e 13 anni, Amet di due anni, Ali e Amet di 8 e 5 anni, Embarga e Amira di 6 e 5 anni, Monsor di 18 anni, due schiavi di cui non indica i nomi di 14 e 8 anni, Sale di 14 anni, Embarca di 18 anni, una schiava e una schiavetta senza nome di 22 anni e 3 anni, Embarca di 5 anni, Embarque di 4 anni, una schiava e uno schiavetto senza nome di 45 e 15 anni madre e figlio, Aisse di 40 anni, Ali di 8 anni, una schiava e uno schiavetto madre e figlio di 30 anni e un mese, Marque di 45 anni, un moretto senza nome né età, una schiava e due figli di 27, 4 e 6 anni. Il totale delle persone catturate è di 42. Tutti gli schiavi sono stato affidati al capitano Guilhelm Prebost. Testimoni sono Gasper Rovira e Francesco Guasch, abitanti di Cagliari.
Inventario di schiavi del 27 marzo 1603 Inventario, fatto per ordine del procuratore reale e del portiere ordinario della procurazione reale, alla presenza del sostituto del notaio e scrivano della stessa, della presa di mori fatta nei mari di Berberia dal patrone Guilhelm Prebost con la sua tartana. Del valore della detta presa il 4% spetta alla regia corte. I mori catturati sono: Turquis e Embarga di 12 e 8 anni, Amet, Casiba di 14 anni, Ferech di due anni, Malorica di 17anni, Amet e Salem di 14 e 13 anni, Amet di due anni, Ali e Amet di 8 e 5 anni, Embarga e Amira di 6 e 5 anni, Monsor di 18 anni, due schiavi di cui non indica i nomi di 14 e 8 anni, Sale di 14 anni, Embarca di 18 anni, una schiava e una schiavetta senza nome di 22 anni e 3 anni, Embarca di 5 anni, Embarque di 4 anni, una schiava e uno schiavetto senza nome di 45 e 15 anni madre e figlio, Aisse di 40 anni, Ali di 8 anni, una schiava e uno schiavetto madre e figlio di 30 anni e un mese, Marque di 45 anni, un moretto senza nome né età, una schiava e due figli di 27, 4 e 6 anni. Il totale delle persone catturate è di 42. Tutti gli schiavi sono stato affidati al capitano Guilhelm Prebost. Testimoni sono Gasper Rovira e Francesco Guasch, abitanti di Cagliari.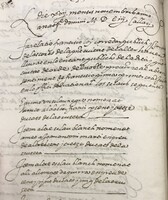 Incanto di schiavi del 17 novembre 1603 Il pubblico corridore Francisco Loi fa relazione in merito alla vendita nel pubblico incanto della città di Cagliari, per ordine del procuratore reale e col consenso del primo coadiutore del razionale, Francisco Pinna, i seguenti schiavi: uno schiavo negro di nome Amet al dottor Franci per 339 lire sarde; uno schiavo bianco di nome Amet per lo stesso prezzo a Joan Antoni Marti; uno schiavo bianco di nome Ali al conte di Quirra per 351,5 lire sarde. Si aggiunge che il viceré ha preso uno schiavo per il diritto di joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.
Incanto di schiavi del 17 novembre 1603 Il pubblico corridore Francisco Loi fa relazione in merito alla vendita nel pubblico incanto della città di Cagliari, per ordine del procuratore reale e col consenso del primo coadiutore del razionale, Francisco Pinna, i seguenti schiavi: uno schiavo negro di nome Amet al dottor Franci per 339 lire sarde; uno schiavo bianco di nome Amet per lo stesso prezzo a Joan Antoni Marti; uno schiavo bianco di nome Ali al conte di Quirra per 351,5 lire sarde. Si aggiunge che il viceré ha preso uno schiavo per il diritto di joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.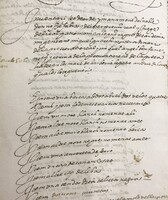 Inventario di schiavi del 4 novembre 1603 Inventario, fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio alla presenza del portiere ordinario della reale procurazione e del notaio e scrivano della stessa, della presa fatta da Andres de Lorca nei mari di Berberia. Sono stati catturati i seguenti schiavi: un modo bianco di nome Alì, un moro bianco di nome Amet, un moro bianco di nome Barca, un moro negro di nome Amet. I mori sono stati affidati a Joan Baptista Loqui.
Inventario di schiavi del 4 novembre 1603 Inventario, fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio alla presenza del portiere ordinario della reale procurazione e del notaio e scrivano della stessa, della presa fatta da Andres de Lorca nei mari di Berberia. Sono stati catturati i seguenti schiavi: un modo bianco di nome Alì, un moro bianco di nome Amet, un moro bianco di nome Barca, un moro negro di nome Amet. I mori sono stati affidati a Joan Baptista Loqui.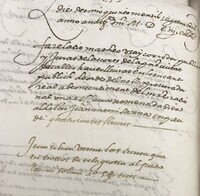 Incanto di schiavi del 15 settembre 1603 Il pubblico corridore e giurato della corte di Cagliari Matheo Usai fa relazione in merito alla vendita da lui effettuata al pubblico incanto per volontà del procuratore reale col consenso del maestro razionale una schiava di nome Sisa al dottor Joan Antoni Sanna per 400 lire sarde.
Incanto di schiavi del 15 settembre 1603 Il pubblico corridore e giurato della corte di Cagliari Matheo Usai fa relazione in merito alla vendita da lui effettuata al pubblico incanto per volontà del procuratore reale col consenso del maestro razionale una schiava di nome Sisa al dottor Joan Antoni Sanna per 400 lire sarde.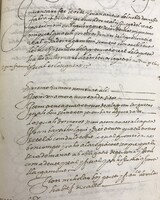 Inventario di schiavi del 6 settembre 1603 Inventario della presa compiuta da Andreu Gisbert nei mari di Berberia fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio, alla presenza del portiere ordinario della procurazione reale e dello scrivano della procurazione reale. Sono stati trovati un moro di nome Ali e una mora di nome Sisa che sono stati affidati al capitano Joan Baptista Loqui. Testimoni sono Nicholao Boi, portiere e Francesco Devila abitante di Cagliari. Si fa nota che il viceré ha preso il moro per la joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.
Inventario di schiavi del 6 settembre 1603 Inventario della presa compiuta da Andreu Gisbert nei mari di Berberia fatto per ordine del procuratore reale e giudice del reale patrimonio, alla presenza del portiere ordinario della procurazione reale e dello scrivano della procurazione reale. Sono stati trovati un moro di nome Ali e una mora di nome Sisa che sono stati affidati al capitano Joan Baptista Loqui. Testimoni sono Nicholao Boi, portiere e Francesco Devila abitante di Cagliari. Si fa nota che il viceré ha preso il moro per la joya. Il diritto detto di "joya" era un privilegio che consisteva nell'usanza del viceré e del procuratore reale di pretendere, ad ogni pubblico incanto, uno schiavo o una schiava per sé a titolo di omaggio.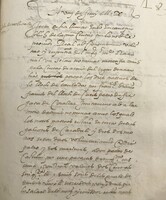 Incanto di schiavi del 9 giugno 1600 Il 9 giugno del 1600 si fa pubblico incanto nella città di Cagliari, alla presenza del nobile Procuratore Reale, per consenso, volontà e in presenza del magnifico Maestro Razionale e del pubblico Corridore. Si vende uno schiavo di nome Mustafa, turco di Smirne del regno di Anatolia, portato da Teulada dal capitano Francesc Bramon, francese di Cassis, patrone di una fregata da corallo. Insieme a lui un altro moro di Tunisi di nome Amet. I due mori sono stati acquistati da don Pedro de Castelvì per 250 lire sarde e 5 soldi in totale. Nel prezzo totale sono compresi i salari del notaio e del corridore: 8 lire 17 soldi e 8 denari. Alla regia corte spettano 241 lire, 8 soldi e 4 denari. Lo stesso giorno viene venduto anche un altro schiavo di nome Amet di Tunisi a don Hieroni Delitala di Alghero per 205 lire di moneta di Cagliari. Dal prezzo totale si devono sottrarre i soldi per il salario del notaio e del corridore (6 lire 17 soldi e 8 denari), pertanto restano nette alla regia corte 198 lire sarde 3 soldi e 4 denari.
Incanto di schiavi del 9 giugno 1600 Il 9 giugno del 1600 si fa pubblico incanto nella città di Cagliari, alla presenza del nobile Procuratore Reale, per consenso, volontà e in presenza del magnifico Maestro Razionale e del pubblico Corridore. Si vende uno schiavo di nome Mustafa, turco di Smirne del regno di Anatolia, portato da Teulada dal capitano Francesc Bramon, francese di Cassis, patrone di una fregata da corallo. Insieme a lui un altro moro di Tunisi di nome Amet. I due mori sono stati acquistati da don Pedro de Castelvì per 250 lire sarde e 5 soldi in totale. Nel prezzo totale sono compresi i salari del notaio e del corridore: 8 lire 17 soldi e 8 denari. Alla regia corte spettano 241 lire, 8 soldi e 4 denari. Lo stesso giorno viene venduto anche un altro schiavo di nome Amet di Tunisi a don Hieroni Delitala di Alghero per 205 lire di moneta di Cagliari. Dal prezzo totale si devono sottrarre i soldi per il salario del notaio e del corridore (6 lire 17 soldi e 8 denari), pertanto restano nette alla regia corte 198 lire sarde 3 soldi e 4 denari. Don Alonso di Castelvì sconta il tempo rimanente dalla taglia di due schiavi Il nobile e molto reverendo don Alonso de Castelvi, canonico della sede di Cagliari, aveva precedentemente stipulato un accordo di affrancamento con Assia, sua schiava, e con il figlio di lei, Joan Pere, anche lui suo schiavo. Le condizioni affinché il patto fosse valido erano che i due lo avrebbero servito per altri 4 anni ciascuno, avrebbero pagato 300 lire e Assia non avrebbe potuto dimorare in altra casa fino al momento in cui avrebbe lasciato il regno. Al momento della stipula del presente atto, delle 300 lire pattuite, i due schiavi ne hanno pagato 130. Nonostante questo Castelvì, per sua esclusiva volontà, abbuona loro sia le lire rimanenti delle 300 da pagare, che il tempo della schiavitù che gli rimane da servire, rendendoli liberi e affrancati da oggi in poi, cosicché possano andare e venire come vorranno, che possano fare ciò che desiderano come persone libere. Permane la condizione che Assia non possa dimorare in un’altra abitazione. L’affrancamento vale anche per tutta la prole dei due schiavi. Assia e Joan Pere accettano questo accordo con reverenze e baciando le mani del Castelvì, al quale restituiscono tutti i vestiti che possiedono. Testimoni sono Joan Antiogo Caviano, pescatore di Cagliati, e Mauro Ramires, prete di Stampace.
Don Alonso di Castelvì sconta il tempo rimanente dalla taglia di due schiavi Il nobile e molto reverendo don Alonso de Castelvi, canonico della sede di Cagliari, aveva precedentemente stipulato un accordo di affrancamento con Assia, sua schiava, e con il figlio di lei, Joan Pere, anche lui suo schiavo. Le condizioni affinché il patto fosse valido erano che i due lo avrebbero servito per altri 4 anni ciascuno, avrebbero pagato 300 lire e Assia non avrebbe potuto dimorare in altra casa fino al momento in cui avrebbe lasciato il regno. Al momento della stipula del presente atto, delle 300 lire pattuite, i due schiavi ne hanno pagato 130. Nonostante questo Castelvì, per sua esclusiva volontà, abbuona loro sia le lire rimanenti delle 300 da pagare, che il tempo della schiavitù che gli rimane da servire, rendendoli liberi e affrancati da oggi in poi, cosicché possano andare e venire come vorranno, che possano fare ciò che desiderano come persone libere. Permane la condizione che Assia non possa dimorare in un’altra abitazione. L’affrancamento vale anche per tutta la prole dei due schiavi. Assia e Joan Pere accettano questo accordo con reverenze e baciando le mani del Castelvì, al quale restituiscono tutti i vestiti che possiedono. Testimoni sono Joan Antiogo Caviano, pescatore di Cagliati, e Mauro Ramires, prete di Stampace.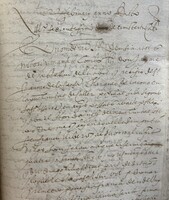 Don Jaume de Castelvì libera Diego, suo schiavo, prima del tempo stabilito dall’atto di taglia Don Jaume de Castelvì, cavaliere dell’ordine di San Giacomo e marchese di Laconi, libera Diego, suo schiavo che lo ha servito per parte dei 4 o 5 anni che doveva in base all’atto di taglia redatto per mano del notaio Alessio Gabriele Horda. Il marchese vuole che il restante tempo del servizio gli sia abbuonato. Quindi rende libero Diego da qualsiasi servitù insieme a tutta la sua prole, cosicché potrà andare e venire come più gli piacerà come un qualsiasi libero cittadino, trattare, stipulare contratti e testimoniare. Testimoni sono Thomas Scano, prete abitante a Cagliari, Antonio Mannu, negoziante di Sassari al presente abitante a Cagliari.
Don Jaume de Castelvì libera Diego, suo schiavo, prima del tempo stabilito dall’atto di taglia Don Jaume de Castelvì, cavaliere dell’ordine di San Giacomo e marchese di Laconi, libera Diego, suo schiavo che lo ha servito per parte dei 4 o 5 anni che doveva in base all’atto di taglia redatto per mano del notaio Alessio Gabriele Horda. Il marchese vuole che il restante tempo del servizio gli sia abbuonato. Quindi rende libero Diego da qualsiasi servitù insieme a tutta la sua prole, cosicché potrà andare e venire come più gli piacerà come un qualsiasi libero cittadino, trattare, stipulare contratti e testimoniare. Testimoni sono Thomas Scano, prete abitante a Cagliari, Antonio Mannu, negoziante di Sassari al presente abitante a Cagliari. Atto di liberazione di Axa che ha servito e pagato quanto dovuto Elisabetta Alagon y Requesens, marchesa di Villasor, vedova di don Martino de Alagon, marchese di Villasor, signore dell’incontrada di Trexenta e di Parte Barigad’e Susu, libera la sua serva e schiava bianca di nome Axa, di 24 anni circa, del luogo di Bona, che per qualche anno ha servito bene, fedelmente e legalmente nella sua casa e per la sua famiglia. Axa ha inoltre ripagato la sua padrona delle 360 lire che era costato il suo acquisto, parte delle quali messe di tasca sua e parte pagate grazie al prestito del patrone Salvatore Izzo, napoletano di Torre del Greco. Donna Elisabetta libera con Axa anche tutta la sua prole: potranno muoversi e risiedere dove vorranno, testimoniare, trattare e stipulare in giudizio e scegliere un padrone che vorranno, se vorranno, senza limitazione. Testimoni sono Joanne Thoma Mundo di Cagliari e Joanne Maceddo, negoziante di Stampace, e Antiocho Falco, scrivano di Cagliari, intervenuto comes sostituto del notaio.
Atto di liberazione di Axa che ha servito e pagato quanto dovuto Elisabetta Alagon y Requesens, marchesa di Villasor, vedova di don Martino de Alagon, marchese di Villasor, signore dell’incontrada di Trexenta e di Parte Barigad’e Susu, libera la sua serva e schiava bianca di nome Axa, di 24 anni circa, del luogo di Bona, che per qualche anno ha servito bene, fedelmente e legalmente nella sua casa e per la sua famiglia. Axa ha inoltre ripagato la sua padrona delle 360 lire che era costato il suo acquisto, parte delle quali messe di tasca sua e parte pagate grazie al prestito del patrone Salvatore Izzo, napoletano di Torre del Greco. Donna Elisabetta libera con Axa anche tutta la sua prole: potranno muoversi e risiedere dove vorranno, testimoniare, trattare e stipulare in giudizio e scegliere un padrone che vorranno, se vorranno, senza limitazione. Testimoni sono Joanne Thoma Mundo di Cagliari e Joanne Maceddo, negoziante di Stampace, e Antiocho Falco, scrivano di Cagliari, intervenuto comes sostituto del notaio.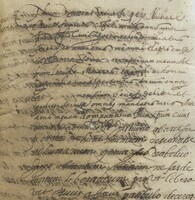 Miquel Roca libera Bonor che ha servito per tre anni e pagato 380 lire Miquel Roca, quarto consigliere della città di Cagliari nel presente anno, afferma di aver comprato anni fa lo schiavo bianco Bonor. Consideranto che Bonor, come da accordi, ha servito bene e fedelmente in casa sua e per la sua famiglia, obbedendo a ogni ordine del suo padrone per tre anni e qualche mese e ha pagato al suo padrone 380 lire di moneta sarda, Roca libera il suo schiavo e tutta la sua prole: da ora in avanti potranno muoversi, andare e venire, abitare dove vorranno, fare ciò che vorranno come liberi cittadini senza più alcun obbligo di servitù. Testimoni sono Joan Angelo Concas, mercante di Cagliari, e Paulo Morteo, mercante genovese abitante a Cagliari.
Miquel Roca libera Bonor che ha servito per tre anni e pagato 380 lire Miquel Roca, quarto consigliere della città di Cagliari nel presente anno, afferma di aver comprato anni fa lo schiavo bianco Bonor. Consideranto che Bonor, come da accordi, ha servito bene e fedelmente in casa sua e per la sua famiglia, obbedendo a ogni ordine del suo padrone per tre anni e qualche mese e ha pagato al suo padrone 380 lire di moneta sarda, Roca libera il suo schiavo e tutta la sua prole: da ora in avanti potranno muoversi, andare e venire, abitare dove vorranno, fare ciò che vorranno come liberi cittadini senza più alcun obbligo di servitù. Testimoni sono Joan Angelo Concas, mercante di Cagliari, e Paulo Morteo, mercante genovese abitante a Cagliari. Atto di liberazione di Amet che ha pagato il proprio riscatto e servito per gli anni dovuti Donna Elisabetta Alagon y Requesens, marchesa di Villasor, vedova e curatrice dell’eredità di don Martino de Alagon, marchese di Villasor, signore dell’incontrada di Trexenta e di Parte Barigad’e Susu, rispettando le ultime volontà testamentarie del marito libera Amet, schiavo bianco del luogo di Bona. Amet ha servito bene e fedelmente per alcuni anni (nel testo vi è uno spazio bianco in luogo del numero di anni serviti), obbedendo a ogni ordine che gli è stato impartito e ha pagato a donna Isabella, come da accordi presi con don Martino, 300 lire di moneta sarda, valenti 100 ducati d’oro. La libertà e l’affrancamento valgono anche per tutta la prole di Amet, che d’ora in avanti potrà andare e venire come vorrà, dimorare dove vorrà, comparire in giudizio, testimoniare, stipulare accordi, senza più alcun obbligo di servitù come un qualsiasi uomo libero. Testimoni sono Vincentio Zonca, causidico di Stampace, e Petro Meloni di Villanova.
Atto di liberazione di Amet che ha pagato il proprio riscatto e servito per gli anni dovuti Donna Elisabetta Alagon y Requesens, marchesa di Villasor, vedova e curatrice dell’eredità di don Martino de Alagon, marchese di Villasor, signore dell’incontrada di Trexenta e di Parte Barigad’e Susu, rispettando le ultime volontà testamentarie del marito libera Amet, schiavo bianco del luogo di Bona. Amet ha servito bene e fedelmente per alcuni anni (nel testo vi è uno spazio bianco in luogo del numero di anni serviti), obbedendo a ogni ordine che gli è stato impartito e ha pagato a donna Isabella, come da accordi presi con don Martino, 300 lire di moneta sarda, valenti 100 ducati d’oro. La libertà e l’affrancamento valgono anche per tutta la prole di Amet, che d’ora in avanti potrà andare e venire come vorrà, dimorare dove vorrà, comparire in giudizio, testimoniare, stipulare accordi, senza più alcun obbligo di servitù come un qualsiasi uomo libero. Testimoni sono Vincentio Zonca, causidico di Stampace, e Petro Meloni di Villanova. Accordo di taglia tra Amet Mardaix e Jaume Santoro Il reverendo canonico Jaume Santoro, domiciliato nell’appendice di Llapola, dichiara di aver ricevuto dal suo schiavo Amet Mardaix, moro bianco di Tunisi, 81 lire di moneta cagliaritana. Si tratta della prima parte di un totale di 200 lire totali che Amet deve consegnare al suo padrone in cambio del proprio riscatto. Santoro afferma che la condizione imposta per l'affrancamento di Amet è che mentre pagherà le 119 lire restanti, egli dovrà prestare servizio in tutto ciò che gli verrà comandato. A sua volta il canonico Santoro dichiara di accettare gli accordi e promette di affrancare e rendere libero Amet nel momento in cui terminerà di pagare quanto dovuto. Amet accetta questi patti e giura, con il dito alzato e con il viso rivolto a oriente, di rispettarli . Testimoni sono Francesch Leca, sarto, e Jacinto Faris, scrivano della Lapola, abitante a Cagliari.
Accordo di taglia tra Amet Mardaix e Jaume Santoro Il reverendo canonico Jaume Santoro, domiciliato nell’appendice di Llapola, dichiara di aver ricevuto dal suo schiavo Amet Mardaix, moro bianco di Tunisi, 81 lire di moneta cagliaritana. Si tratta della prima parte di un totale di 200 lire totali che Amet deve consegnare al suo padrone in cambio del proprio riscatto. Santoro afferma che la condizione imposta per l'affrancamento di Amet è che mentre pagherà le 119 lire restanti, egli dovrà prestare servizio in tutto ciò che gli verrà comandato. A sua volta il canonico Santoro dichiara di accettare gli accordi e promette di affrancare e rendere libero Amet nel momento in cui terminerà di pagare quanto dovuto. Amet accetta questi patti e giura, con il dito alzato e con il viso rivolto a oriente, di rispettarli . Testimoni sono Francesch Leca, sarto, e Jacinto Faris, scrivano della Lapola, abitante a Cagliari.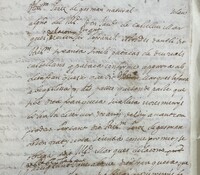 Accordo di taglia tra don Jaume di Castelvì e il suo schiavo Hieronim Perez de Gusman Don Jaume de Castelvì, marchese di Laconi, intende liberare il suo schiavo Hieronim Perez de Gusman. Infatti Hieronim ha consegnato al suo padrone, in cambio della propria libertà, 65 patacche da 2 reali castigliani ciascuna. L’accordo di liberazione prevede che lo schiavo, oltre al pagamento della suddetta cifra, presti altri due anni di servizio fedele, trascorsi i quali sarà libero e affrancato senza più alcun obbligo di schiavitù. Testimoni sono Thomas Moreno, scrivano, e Simoni Carta, causidico, abitanti entrambi a Stampace di Cagliari.
Accordo di taglia tra don Jaume di Castelvì e il suo schiavo Hieronim Perez de Gusman Don Jaume de Castelvì, marchese di Laconi, intende liberare il suo schiavo Hieronim Perez de Gusman. Infatti Hieronim ha consegnato al suo padrone, in cambio della propria libertà, 65 patacche da 2 reali castigliani ciascuna. L’accordo di liberazione prevede che lo schiavo, oltre al pagamento della suddetta cifra, presti altri due anni di servizio fedele, trascorsi i quali sarà libero e affrancato senza più alcun obbligo di schiavitù. Testimoni sono Thomas Moreno, scrivano, e Simoni Carta, causidico, abitanti entrambi a Stampace di Cagliari.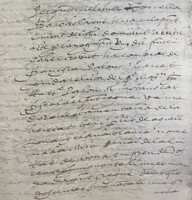 Monço, schiavo attallato, tratta per riscattare la schiava Mira Don Melchiorre Torrella, barone di Capoterra, ha comprato da Francisca Palou e Garcet, vedova di Joan Antonio Palou, ex avvocato fiscale del regno, una schiava bianca di nome Mira, nata a Bona, per 250 lire di moneta del presente regno. Delle 250 lire ne ha pagato 220 il barone Torrella stesso e 30 lire gliele ha date Monço, schiavo di Joan Angel Quessa, mercante di Cagliari. Si specifica che Monço e il suo padrone Joan Angel Quessa hanno stipulato un patto di taglia che avrà termine nel mese di dicembre di questo stesso anno, e dopo la fine della taglia lo schiavo sarà libero. Il barone Torrella dice di aver comprato la schiava Mira in nome, per conto e commissione dello schiavo Monço stipulando i seguenti accordi. Il Torrella promette che, non appena Monço gli avrà ripagato le 220 lire che ha anticipato per l’acquisto di Mira, lui gli consegnerà la schiava affrancata e libera e Monço ne potrà fare ciò che vorrà nella sua piena volontà. Monço inoltre si obbliga a Melchior Torrella affinché, nel frattempo che non avrà terminato di ripagargli il suo debito, starà in casa sua insieme a Mira e lo servirà da schiavo in tutti i servizi che lui gli comanderà, e il suo precedente padrone, quando finirà la taglia, gli permetterà di trasferirsi nella casa del Torrella. Inoltre promette che, durante il tempo rimanente della taglia, ogni giorno porterà, a spese di Torrella, due barili d’acqua al Quessa e due barili di pescato. Ancora il barone Torrella pro mette a Monço per tutto il tempo che lui e Mira staranno a casa sua lui li nutrirà con cibo e bevande. D’accordo le due parti decidono che Monço non potrà ricevere soldi da nessuna persona di Cagliari né del resto del regno di Sardegna per restituire i soldi che deve al barone, ma devono essere soldi di giornate lavorate, guadagnati o che gli verranno inviati dalla Barberia. Ancora d’accordo stabiliscono che se Monço non adempie a tutte le cose stabilite, Mira rimarrà schiava di Melchior Torrella come se questo atto non fosse mai stato fatto. Se invece Monço ne paga solo parte e il rimanente viene pagato da Mira, allora Mira sarà libera e franca. Tutte le parti promettono di adempiere agli accordi senza ritardi. Testimoni sono Nicolao Montelles, mercante di Cagliari e Nicolao Porxella della villa di Serdiana.
Monço, schiavo attallato, tratta per riscattare la schiava Mira Don Melchiorre Torrella, barone di Capoterra, ha comprato da Francisca Palou e Garcet, vedova di Joan Antonio Palou, ex avvocato fiscale del regno, una schiava bianca di nome Mira, nata a Bona, per 250 lire di moneta del presente regno. Delle 250 lire ne ha pagato 220 il barone Torrella stesso e 30 lire gliele ha date Monço, schiavo di Joan Angel Quessa, mercante di Cagliari. Si specifica che Monço e il suo padrone Joan Angel Quessa hanno stipulato un patto di taglia che avrà termine nel mese di dicembre di questo stesso anno, e dopo la fine della taglia lo schiavo sarà libero. Il barone Torrella dice di aver comprato la schiava Mira in nome, per conto e commissione dello schiavo Monço stipulando i seguenti accordi. Il Torrella promette che, non appena Monço gli avrà ripagato le 220 lire che ha anticipato per l’acquisto di Mira, lui gli consegnerà la schiava affrancata e libera e Monço ne potrà fare ciò che vorrà nella sua piena volontà. Monço inoltre si obbliga a Melchior Torrella affinché, nel frattempo che non avrà terminato di ripagargli il suo debito, starà in casa sua insieme a Mira e lo servirà da schiavo in tutti i servizi che lui gli comanderà, e il suo precedente padrone, quando finirà la taglia, gli permetterà di trasferirsi nella casa del Torrella. Inoltre promette che, durante il tempo rimanente della taglia, ogni giorno porterà, a spese di Torrella, due barili d’acqua al Quessa e due barili di pescato. Ancora il barone Torrella pro mette a Monço per tutto il tempo che lui e Mira staranno a casa sua lui li nutrirà con cibo e bevande. D’accordo le due parti decidono che Monço non potrà ricevere soldi da nessuna persona di Cagliari né del resto del regno di Sardegna per restituire i soldi che deve al barone, ma devono essere soldi di giornate lavorate, guadagnati o che gli verranno inviati dalla Barberia. Ancora d’accordo stabiliscono che se Monço non adempie a tutte le cose stabilite, Mira rimarrà schiava di Melchior Torrella come se questo atto non fosse mai stato fatto. Se invece Monço ne paga solo parte e il rimanente viene pagato da Mira, allora Mira sarà libera e franca. Tutte le parti promettono di adempiere agli accordi senza ritardi. Testimoni sono Nicolao Montelles, mercante di Cagliari e Nicolao Porxella della villa di Serdiana. Don Joan Naharro de Ruecas libera in anticipo Barquet di Bona rispetto ai tempi previsti dal contratto di taglia Don Joannes Naharro de Ruecas ha concesso taglia al suo schiavo Barquet di Bona nel 1599. Barquet ha servito nella casa del padrone per tre anni e ha pagato 85 scudi, prezzo del proprio riscatto nonché cifra che l’acquisto dello schiavo era costato a don Joan. Nel presente atto don Joan sconta a Barquet i tre mesi e 21 giorni che rimarrebbero del servizio e lo libera in anticipo: dal giorno presente Barquet potrà muoversi, spostarsi e andare dove vorrà nel mondo come uomo libero, testimoniare, fare contratti e tutto quello che un uomo libero può fare. La libertà di Barquet è estesa anche a tutta la sua prole. Testimoni sono Antonius Maynes, sarto di Stampace, e Luca de Vico di Sassari, abitante a Villanova di Cagliari.
Don Joan Naharro de Ruecas libera in anticipo Barquet di Bona rispetto ai tempi previsti dal contratto di taglia Don Joannes Naharro de Ruecas ha concesso taglia al suo schiavo Barquet di Bona nel 1599. Barquet ha servito nella casa del padrone per tre anni e ha pagato 85 scudi, prezzo del proprio riscatto nonché cifra che l’acquisto dello schiavo era costato a don Joan. Nel presente atto don Joan sconta a Barquet i tre mesi e 21 giorni che rimarrebbero del servizio e lo libera in anticipo: dal giorno presente Barquet potrà muoversi, spostarsi e andare dove vorrà nel mondo come uomo libero, testimoniare, fare contratti e tutto quello che un uomo libero può fare. La libertà di Barquet è estesa anche a tutta la sua prole. Testimoni sono Antonius Maynes, sarto di Stampace, e Luca de Vico di Sassari, abitante a Villanova di Cagliari.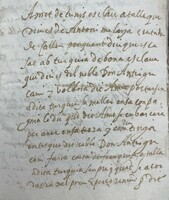 Amet di Tunisi, schiavo attallato, fa un accordo col padrone della propria moglie, la schiava Turquia Amet di Tunisi, schiavo di Antoni Molarja, sottoposto a taglia e sposato con Turquia di Bona, schiava del nobile don Antiogo Cani, afferma di voler portare Turquia con sé quando si imbarcherà per la Barbaria. Dunque Amet si accorda con don Antiogo Cani per pagare il riscatto di Turquia 500 lire di moneta cagliaritana, pagate poco a poco, e così don Antiogo consente che quando Amet si imbarcherà porterà con sé Turquia. Per garanzia delle cose concordate, Amet obbliga la sua persona e i suoi beni mobili e immobili. Lo firma e giura more saracenorum. Testimoni sono Visent Guiso e Miquel Angel Bonfant, abitanti di Cagliari.
Amet di Tunisi, schiavo attallato, fa un accordo col padrone della propria moglie, la schiava Turquia Amet di Tunisi, schiavo di Antoni Molarja, sottoposto a taglia e sposato con Turquia di Bona, schiava del nobile don Antiogo Cani, afferma di voler portare Turquia con sé quando si imbarcherà per la Barbaria. Dunque Amet si accorda con don Antiogo Cani per pagare il riscatto di Turquia 500 lire di moneta cagliaritana, pagate poco a poco, e così don Antiogo consente che quando Amet si imbarcherà porterà con sé Turquia. Per garanzia delle cose concordate, Amet obbliga la sua persona e i suoi beni mobili e immobili. Lo firma e giura more saracenorum. Testimoni sono Visent Guiso e Miquel Angel Bonfant, abitanti di Cagliari.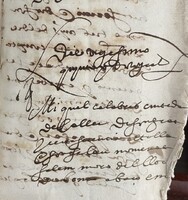 Accordo di taglia tra Miquel Calabres e Salem di Bona Miquel Calabres, cittadino di Cagliari, dà talla al suo schiavo Salem, moro di Bona, purché Salem sia obbligato alla stessa servitù e schiavitù per altri tre anni a partire da oggi. Inoltre entro la fine dei tre anni Salem sarà obbligato a pagare 160 lire, prezzo che costò a Calabres il suo acquisto, compreso lo stipendio del pubblico corridore. Di queste 160 lire Calabres ne ha già ricevute 25, dunque ne restano da pagare a Salem 135. Testimoni sono Simo Merea, mercante genovese, e Joan Jaco Rubio di Nuoro, abitante di Cagliari. Tre anni dopo, il 2 novembre 1614, Calabres riconosce a Salem che ha ricevuto da lui in diverse partite e giorni diversi 160 lire che sono il prezzo del suo riscatto, conformemente all’atto di taglia firmato il 25 giugno 1611. Quindi firmando l’apoca di pagamento lo fa anche libero e affrancato dalla schiavitù, così che possa andare e venire come vorrà e fare ciò che vorrà come un uomo libero. Testimoni sono il reverendo Pere [Cavassa], prete e benificiato della sede primaziale di Cagliari e Jaime Gamboi, abitante di Cagliari.
Accordo di taglia tra Miquel Calabres e Salem di Bona Miquel Calabres, cittadino di Cagliari, dà talla al suo schiavo Salem, moro di Bona, purché Salem sia obbligato alla stessa servitù e schiavitù per altri tre anni a partire da oggi. Inoltre entro la fine dei tre anni Salem sarà obbligato a pagare 160 lire, prezzo che costò a Calabres il suo acquisto, compreso lo stipendio del pubblico corridore. Di queste 160 lire Calabres ne ha già ricevute 25, dunque ne restano da pagare a Salem 135. Testimoni sono Simo Merea, mercante genovese, e Joan Jaco Rubio di Nuoro, abitante di Cagliari. Tre anni dopo, il 2 novembre 1614, Calabres riconosce a Salem che ha ricevuto da lui in diverse partite e giorni diversi 160 lire che sono il prezzo del suo riscatto, conformemente all’atto di taglia firmato il 25 giugno 1611. Quindi firmando l’apoca di pagamento lo fa anche libero e affrancato dalla schiavitù, così che possa andare e venire come vorrà e fare ciò che vorrà come un uomo libero. Testimoni sono il reverendo Pere [Cavassa], prete e benificiato della sede primaziale di Cagliari e Jaime Gamboi, abitante di Cagliari.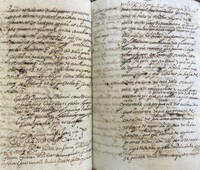 Accordo di taglia tra Gregori Guerau e Ibraim di Niemsa Il molto reverendo dottore in sacra teologia Gregori Guerau de Pinna, canonico e vicario nell’arcivescovato di Cagliari per l’illustrissimo e reverendissimo don Francesco Esquivell, arcivescovo di Cagliari, dona taglia a Ibraym. ungaro di Niemsa nelle parti di tramontana o levante, suo schiavo bianco, di statura alta, di più di 40 anni. La taglia prevede che lo schiavo debba servire per 4 anni il suo padrone e la sua famiglia in casa, bene e lealmente, cominciando i 4 anni dal giorno presente. Dovrà inoltre pagare 300 lire di moneta di Cagliari e dovrà essere leale, non rubare niente né in casa né fuori, non fuggire, tornare a casa ogni notte al tocco della preghiera, non ubriacarsi. Se non seguirà ognuno degli obblighi, la taglia sarà nulla. Per il sostentamento della casa del padrone lo schiavo dovrà andare a prendere l’acqua da bere a Palabanda e promette che per ogni anno darà 4 scudi per la raccolta dell’acqua che si conserverà nella cisterna. E questo oltre alle 300 lire che deve pagare. Il suo padrone promette di alimentarlo e vestirlo e, alla fine della taglia, promette fargli carta di affrancamento. Lo schiavo non potrà spostarsi dalla casa del padrone finché non avrà modo di imbarcarsi per tornare nella sua terra e se il viaggio non dovesse avere buon esito dovrà tornare al servizio del padrone finché non riuscirà a uscire dal regno di Sardegna. Abraim (Ibraim) accetta e promette di osservare i patti. Testimoni sono Antiochus Holla, boscaiolo di lapola e Gavinus Penducho, scrivano di Cagliari.
Accordo di taglia tra Gregori Guerau e Ibraim di Niemsa Il molto reverendo dottore in sacra teologia Gregori Guerau de Pinna, canonico e vicario nell’arcivescovato di Cagliari per l’illustrissimo e reverendissimo don Francesco Esquivell, arcivescovo di Cagliari, dona taglia a Ibraym. ungaro di Niemsa nelle parti di tramontana o levante, suo schiavo bianco, di statura alta, di più di 40 anni. La taglia prevede che lo schiavo debba servire per 4 anni il suo padrone e la sua famiglia in casa, bene e lealmente, cominciando i 4 anni dal giorno presente. Dovrà inoltre pagare 300 lire di moneta di Cagliari e dovrà essere leale, non rubare niente né in casa né fuori, non fuggire, tornare a casa ogni notte al tocco della preghiera, non ubriacarsi. Se non seguirà ognuno degli obblighi, la taglia sarà nulla. Per il sostentamento della casa del padrone lo schiavo dovrà andare a prendere l’acqua da bere a Palabanda e promette che per ogni anno darà 4 scudi per la raccolta dell’acqua che si conserverà nella cisterna. E questo oltre alle 300 lire che deve pagare. Il suo padrone promette di alimentarlo e vestirlo e, alla fine della taglia, promette fargli carta di affrancamento. Lo schiavo non potrà spostarsi dalla casa del padrone finché non avrà modo di imbarcarsi per tornare nella sua terra e se il viaggio non dovesse avere buon esito dovrà tornare al servizio del padrone finché non riuscirà a uscire dal regno di Sardegna. Abraim (Ibraim) accetta e promette di osservare i patti. Testimoni sono Antiochus Holla, boscaiolo di lapola e Gavinus Penducho, scrivano di Cagliari.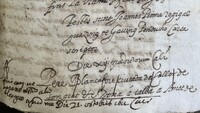 Accordo di taglia tra Pere Blancafort e Amet di Algeri Pere Blancafort cittadino di Cagliari concorda i capitoli di taglia con Amet di Algeri, suo schiavo. Amet dovrà servire lui e la sua famiglia con tutti i doveri di che gli saranno comandati per sei anni contati dal giorno presente; dovrà pagare 400 lire di moneta cagliaritana da pagare secondo quanto guadagnerà dal suo lavoro: dovrà dare al suo padrone tutto quello che guadagnerà giornalmente. Amet promette che non fuggirà, non ruberà in casa né fuori casa, non si ubriacherà e ogni notte, suonata la preghiera, si farà trovare in casa del padrone. Se mancherà di fare una di queste cose la taglia sarà nulla. Inoltre Blancafort non sarà obbligato a vestirlo, farlo sposare e nutrirlo con cibo e acqua. Alla fine di questa taglia, se Amet avrà adempiuto a tutti gli obblighi, Blancafort promette di dargli la libertà. Inoltre si stabilisce che, nel caso finisca la taglia e abbia pagato come detto, che lo schiavo non possa cambiare casa se non per tornare a casa sua nella sua terra, e se il viaggio non dovesse rivelarsi fruttuoso e non riuscisse ad arrivare nella sua terra, allora dovrà tornare a casa del padrone e servirlo nuovamente secondo i patti. Amet accetta questa taglia e i patti, promettendo di servire bene e lealmente e di pagare le 400 lire. Per maggiore sicurezza del suo padrone, in caso fuggisse, porta come garanzia Amet di Algeri schiavo di don Gaspar de Requesens e Abarca schiavo del quondam Joan Antonio Palou di Tabarca e uno schiavo di Miquel Calabres proveniente da Gerbens ma di cui non viene indicato il nome, tutti presenti per far sì che ciò che Amet promette sia obbligato a mantenere. Non solo, ma se lui fuggirà e non dovesse tornare, si impegnano a pagare loro stessi le 400 lire di taglia a Blancafort e a servirlo in vece di Amet oppure a pagare perché venga svolto per il Blancafort lo stesso servizio che avrebbe dovuto svolgere Amet durante il periodo di taglia come se non fosse mai fuggito. Blancafort accetta queste garanzie ad ulteriore patto che se uno di questi schiavi venisse nel frattempo liberato, provvederà a sua volta a trovare un’altra garanzia. Testimoni: mestre Antiogo Meli e Francesch Jorgii, filatori abitanti a stampace e marina e lo schiavo (di cui non scrivono il nome) di Miquel Calabres. Il 24 luglio dello stesso anno, Abarca, schiavo appartenuto prima al dottor Juan Antoni Palou, avvocato fiscale e patrimoniale e, dopo la sua morte, a sua moglie Francesca Palou y Garcet, essendo stato nel frattempo affrancato, firma un atto in merito alla sua partecipazione in qualità di garante all’atto di taglia del 12 maggio 1606 a favore di Amet di Algeri. La condizione della sua garanzia nell’atto di taglia era che, nel caso fosse stato liberato nel frattempo, avrebbe provveduto a dare un altro moro in suo luogo come garante. Quindi considerato che ora Abarca intende ritornare nella sua terra, essendo stato liberato, in presenza di Pere Blancafort dà in cambio di se stesso come garante Abrahim di Bona, presente a questo atto, schiavo di Gaspar Bonato, mercante di Cagliari, con le medesime obbligazioni. Abrahim accetta le responsabilità di garanzia. Promette che sarà tenuto a tutte le cose che Abarca promettè. Tesimoni sono Gavinus Penducho Carta, scrivano, e Jacobus Gamboa, portario regio.
Accordo di taglia tra Pere Blancafort e Amet di Algeri Pere Blancafort cittadino di Cagliari concorda i capitoli di taglia con Amet di Algeri, suo schiavo. Amet dovrà servire lui e la sua famiglia con tutti i doveri di che gli saranno comandati per sei anni contati dal giorno presente; dovrà pagare 400 lire di moneta cagliaritana da pagare secondo quanto guadagnerà dal suo lavoro: dovrà dare al suo padrone tutto quello che guadagnerà giornalmente. Amet promette che non fuggirà, non ruberà in casa né fuori casa, non si ubriacherà e ogni notte, suonata la preghiera, si farà trovare in casa del padrone. Se mancherà di fare una di queste cose la taglia sarà nulla. Inoltre Blancafort non sarà obbligato a vestirlo, farlo sposare e nutrirlo con cibo e acqua. Alla fine di questa taglia, se Amet avrà adempiuto a tutti gli obblighi, Blancafort promette di dargli la libertà. Inoltre si stabilisce che, nel caso finisca la taglia e abbia pagato come detto, che lo schiavo non possa cambiare casa se non per tornare a casa sua nella sua terra, e se il viaggio non dovesse rivelarsi fruttuoso e non riuscisse ad arrivare nella sua terra, allora dovrà tornare a casa del padrone e servirlo nuovamente secondo i patti. Amet accetta questa taglia e i patti, promettendo di servire bene e lealmente e di pagare le 400 lire. Per maggiore sicurezza del suo padrone, in caso fuggisse, porta come garanzia Amet di Algeri schiavo di don Gaspar de Requesens e Abarca schiavo del quondam Joan Antonio Palou di Tabarca e uno schiavo di Miquel Calabres proveniente da Gerbens ma di cui non viene indicato il nome, tutti presenti per far sì che ciò che Amet promette sia obbligato a mantenere. Non solo, ma se lui fuggirà e non dovesse tornare, si impegnano a pagare loro stessi le 400 lire di taglia a Blancafort e a servirlo in vece di Amet oppure a pagare perché venga svolto per il Blancafort lo stesso servizio che avrebbe dovuto svolgere Amet durante il periodo di taglia come se non fosse mai fuggito. Blancafort accetta queste garanzie ad ulteriore patto che se uno di questi schiavi venisse nel frattempo liberato, provvederà a sua volta a trovare un’altra garanzia. Testimoni: mestre Antiogo Meli e Francesch Jorgii, filatori abitanti a stampace e marina e lo schiavo (di cui non scrivono il nome) di Miquel Calabres. Il 24 luglio dello stesso anno, Abarca, schiavo appartenuto prima al dottor Juan Antoni Palou, avvocato fiscale e patrimoniale e, dopo la sua morte, a sua moglie Francesca Palou y Garcet, essendo stato nel frattempo affrancato, firma un atto in merito alla sua partecipazione in qualità di garante all’atto di taglia del 12 maggio 1606 a favore di Amet di Algeri. La condizione della sua garanzia nell’atto di taglia era che, nel caso fosse stato liberato nel frattempo, avrebbe provveduto a dare un altro moro in suo luogo come garante. Quindi considerato che ora Abarca intende ritornare nella sua terra, essendo stato liberato, in presenza di Pere Blancafort dà in cambio di se stesso come garante Abrahim di Bona, presente a questo atto, schiavo di Gaspar Bonato, mercante di Cagliari, con le medesime obbligazioni. Abrahim accetta le responsabilità di garanzia. Promette che sarà tenuto a tutte le cose che Abarca promettè. Tesimoni sono Gavinus Penducho Carta, scrivano, e Jacobus Gamboa, portario regio.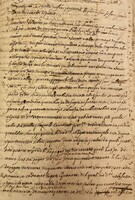 Accordo di taglia tra Joan Antonio Sanna e Antioco della Conpceçion e di Tetuan Capitoli di taglia stipulati tra il dottore in arti e medicina Joan Antoni Sanna, protomedico di Cagliari, e il suo schiavo, cristiano battezzato, Antiogo della Conpceçion della città di Tetuan in Marocco. Sanna concede taglia per il tempo di 4 anni a partire da oggi ad Antiogo a patto che in questo tempo gli faccia tutti i servizi che gli verranno ordinati sia di giorno che di notte, e che, terminati i servizi, chieda licenza per andare a servire altre persone per guadagnare il denaro necessario a pagare il prezzo del proprio riscatto e, se sarà necessario, per far sì che il dottor Sanna possa disporre di un altro uomo per fare il detto servizio di Antiogo nel caso in cui lui non si trovasse in casa per fare il suo dovere. Tutto ciò a condizione che non fuggirà, non ruberà né a casa del Sanna né a casa di nessun’altra persona e non si ubriacherà. In caso contrario la presente taglia sarà dichiarata nulla, il denaro che Antiogo gli avrà dato fino a quel momento sarà perduto e Antiogo dovrà tornare schiavo e rimanerlo perpetuamente. Un altro accordo è che entro i 4 anni dovrà pagare l’intero suo riscatto, stabilito in 250 lire in contanti e, se non avrà finito di pagare, dovrà continuare a servire il Sanna, alle stesse condizioni, finché non terminerà. Il Sanna specifica che ogni settimana o ogni mese Antiogo dovrà consegnargli il denaro che guadagnerà – fino al raggiungimento della somma totale – e lui gli rilascerà ogni volta ricevuta. A sua volta Sanna si impegna a nutrirlo, dargli da bere, curarlo se malato. Alla fine dei 4 anni, se tutto andrà bene, il Sanna farà carta di affrancamento ad Antiogo, il quale accetta tutti gli accordi. Testimoni sono Joan Bonungo e Thomas Fancello, scrivano, abitante a Cagliari.
Accordo di taglia tra Joan Antonio Sanna e Antioco della Conpceçion e di Tetuan Capitoli di taglia stipulati tra il dottore in arti e medicina Joan Antoni Sanna, protomedico di Cagliari, e il suo schiavo, cristiano battezzato, Antiogo della Conpceçion della città di Tetuan in Marocco. Sanna concede taglia per il tempo di 4 anni a partire da oggi ad Antiogo a patto che in questo tempo gli faccia tutti i servizi che gli verranno ordinati sia di giorno che di notte, e che, terminati i servizi, chieda licenza per andare a servire altre persone per guadagnare il denaro necessario a pagare il prezzo del proprio riscatto e, se sarà necessario, per far sì che il dottor Sanna possa disporre di un altro uomo per fare il detto servizio di Antiogo nel caso in cui lui non si trovasse in casa per fare il suo dovere. Tutto ciò a condizione che non fuggirà, non ruberà né a casa del Sanna né a casa di nessun’altra persona e non si ubriacherà. In caso contrario la presente taglia sarà dichiarata nulla, il denaro che Antiogo gli avrà dato fino a quel momento sarà perduto e Antiogo dovrà tornare schiavo e rimanerlo perpetuamente. Un altro accordo è che entro i 4 anni dovrà pagare l’intero suo riscatto, stabilito in 250 lire in contanti e, se non avrà finito di pagare, dovrà continuare a servire il Sanna, alle stesse condizioni, finché non terminerà. Il Sanna specifica che ogni settimana o ogni mese Antiogo dovrà consegnargli il denaro che guadagnerà – fino al raggiungimento della somma totale – e lui gli rilascerà ogni volta ricevuta. A sua volta Sanna si impegna a nutrirlo, dargli da bere, curarlo se malato. Alla fine dei 4 anni, se tutto andrà bene, il Sanna farà carta di affrancamento ad Antiogo, il quale accetta tutti gli accordi. Testimoni sono Joan Bonungo e Thomas Fancello, scrivano, abitante a Cagliari.