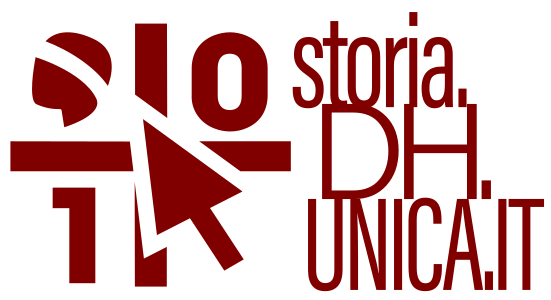-
 Saline di Pontis Beccius
Saline di Pontis Beccius Donna Maria Elisabetta Loddo, vedova del fu avvocato don Mauro Antonio Puggioni, ottiene nel 1778 la facoltà di ricavare delle saline negli stagni presenti fra le isolette della peschiera di Ponti Beccius, al di là della Scafa, della quale è già dal 1774 concessionaria
-
 Saline di Oristano
Saline di Oristano La salina è sempre stata "accensata". Dietro pagamento rifornisce di sale le città di Alghero e di Bosa, così come diverse altre comunità e singoli individui.
-
 Saline della città regia di Iglesias
Saline della città regia di Iglesias Fino al 1737, le saline situate nel territorio del Sulcis erano considerate parte integrante delle saline di Cagliari. La città di Iglesias godeva tuttavia di un trattamento privilegiato: in virtù di un diritto concesso da re Alfonso d’Aragona nel 1400, e successivamente confermato, seppure con alcune modifiche, dai sovrani sabaudi, gli abitanti avevano diritto a ricevere gratuitamente 400 quartare di sale.
Il sale rimanente veniva per lo più destinato alla vendita, in particolare a pastori e agricoltori della città e delle aree circostanti. I pastori iglesienti versavano una somma di 2,16 lire piemontesi ciascuno, mentre i pastori provenienti da altri luoghi pagavano con un capretto, considerato di pari valore. Gli agricoltori locali, insieme agli abitanti di Teulada, Villamassargia, Domusnovas e Musei, erano invece tenuti a versare un tributo di sei soldi sardi, equivalenti a circa 9,7 lire piemontesi. Le persone non privilegiate acquistavano il sale a un prezzo più alto, pari a nove soldi sardi, corrispondenti a circa 14,4 lire piemontesi.
Le fonti settecentesche non indicano con certezza la collocazione delle saline. Vittorio Angius, nella voce “Iglesias” del Dizionario Casalis, segnala che nel XVIII secolo il sale veniva estratto a Porto-Butis (Porto Botte), dove nell'Ottocento si trovava unaa peschiera, a Porto Pino, in un luogo in cui nel XIX secolo era ancora visibile un edificio prima usato come ricovero per gli operai e da deposito degli strumenti, sul fondo del golfo di Teulada e anche nello stagno dell’istmo.
Quest’ultimo sito, in particolare, era noto per la qualità superiore del sale prodotto.
La raccolta proseguì fino al 1830, quando si interruppe la produzione estiva e si iniziò semplicemente a impedire o disturbare il processo di cristallizzazione.
Da queste saline, il sale veniva distribuito gratuitamente agli abitanti di Iglesias, secondo quanto stabilito dal già citato privilegio aragonese, confermato dai re di Sardegna.
-
 Salina di Terranova
Salina di Terranova La salina di Terranova è stata assegnata al marchese Pes di Villamarina con diploma dell'Imperatore Carlo VI del 10 febbraio 1771, come ricompensa per i servigi prestati durante la guerra di successione spagnola. Il diploma è stato confermato dal re di Sardegna Vittorio Amedeo con patenti del 27 maggio 1720 e dal successore Carlo Emanuele III, il 21 marzo 1732. Il 12 luglio 1742 un contratto, confermato con diploma del 5 dicembre, le saline insieme a redditi, amministrazione e tonnara furono eretti in feudo improprio a favore del possessore don Bernardino Pes e suoi discendenti, dietro esborso di 12 mila lire di Piemonte. La patente del 1720 dispone la consegna di 9 cagliaresi per ogni cuba di sale estratto e di mezzo starello (1 emina di Piemonte) per pagare lo stipendio del reggente provinciale. Il sale prodotto nella salina di Terranova viene venduto a Tempio e nel resto della Gallura.
-
 Saline di Sassari
Saline di Sassari Le saline di Sassari nella seconda metà del XVII secolo producevano, al meglio, tra gli 8 ed i 9.000 rasieri, che venivano venduti (e in parte esportati) all'incirca per il 70%. In termini di produzione, di vendita e soprattutto di esportazione la salina sassarese è inferiore di circa la metà rispetto alle saline di Cagliari. Le saline di Sassari vengono concesse al migliore offerente. I profitti generati dal loro sfruttamento crescono significativamente nel corso del Settecento. Almeno dagli anni Trenta del Settecento, queste saline sono soggette all'obbligo di consegnare una certa quantità di sale all'Arcivescovo e ai canonici del Capitolo di Sassari.
-
 Salina Pompongias
Salina Pompongias Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tantomeno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.
-
 Salina Mistras
Salina Mistras Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli).
L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto.
Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tanto meno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.
-
 Salina di Pau Pirastru
Salina di Pau Pirastru Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tantomeno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.
 Saline di Pontis Beccius Donna Maria Elisabetta Loddo, vedova del fu avvocato don Mauro Antonio Puggioni, ottiene nel 1778 la facoltà di ricavare delle saline negli stagni presenti fra le isolette della peschiera di Ponti Beccius, al di là della Scafa, della quale è già dal 1774 concessionaria
Saline di Pontis Beccius Donna Maria Elisabetta Loddo, vedova del fu avvocato don Mauro Antonio Puggioni, ottiene nel 1778 la facoltà di ricavare delle saline negli stagni presenti fra le isolette della peschiera di Ponti Beccius, al di là della Scafa, della quale è già dal 1774 concessionaria Saline di Oristano La salina è sempre stata "accensata". Dietro pagamento rifornisce di sale le città di Alghero e di Bosa, così come diverse altre comunità e singoli individui.
Saline di Oristano La salina è sempre stata "accensata". Dietro pagamento rifornisce di sale le città di Alghero e di Bosa, così come diverse altre comunità e singoli individui. Saline della città regia di Iglesias Fino al 1737, le saline situate nel territorio del Sulcis erano considerate parte integrante delle saline di Cagliari. La città di Iglesias godeva tuttavia di un trattamento privilegiato: in virtù di un diritto concesso da re Alfonso d’Aragona nel 1400, e successivamente confermato, seppure con alcune modifiche, dai sovrani sabaudi, gli abitanti avevano diritto a ricevere gratuitamente 400 quartare di sale. Il sale rimanente veniva per lo più destinato alla vendita, in particolare a pastori e agricoltori della città e delle aree circostanti. I pastori iglesienti versavano una somma di 2,16 lire piemontesi ciascuno, mentre i pastori provenienti da altri luoghi pagavano con un capretto, considerato di pari valore. Gli agricoltori locali, insieme agli abitanti di Teulada, Villamassargia, Domusnovas e Musei, erano invece tenuti a versare un tributo di sei soldi sardi, equivalenti a circa 9,7 lire piemontesi. Le persone non privilegiate acquistavano il sale a un prezzo più alto, pari a nove soldi sardi, corrispondenti a circa 14,4 lire piemontesi. Le fonti settecentesche non indicano con certezza la collocazione delle saline. Vittorio Angius, nella voce “Iglesias” del Dizionario Casalis, segnala che nel XVIII secolo il sale veniva estratto a Porto-Butis (Porto Botte), dove nell'Ottocento si trovava unaa peschiera, a Porto Pino, in un luogo in cui nel XIX secolo era ancora visibile un edificio prima usato come ricovero per gli operai e da deposito degli strumenti, sul fondo del golfo di Teulada e anche nello stagno dell’istmo. Quest’ultimo sito, in particolare, era noto per la qualità superiore del sale prodotto. La raccolta proseguì fino al 1830, quando si interruppe la produzione estiva e si iniziò semplicemente a impedire o disturbare il processo di cristallizzazione. Da queste saline, il sale veniva distribuito gratuitamente agli abitanti di Iglesias, secondo quanto stabilito dal già citato privilegio aragonese, confermato dai re di Sardegna.
Saline della città regia di Iglesias Fino al 1737, le saline situate nel territorio del Sulcis erano considerate parte integrante delle saline di Cagliari. La città di Iglesias godeva tuttavia di un trattamento privilegiato: in virtù di un diritto concesso da re Alfonso d’Aragona nel 1400, e successivamente confermato, seppure con alcune modifiche, dai sovrani sabaudi, gli abitanti avevano diritto a ricevere gratuitamente 400 quartare di sale. Il sale rimanente veniva per lo più destinato alla vendita, in particolare a pastori e agricoltori della città e delle aree circostanti. I pastori iglesienti versavano una somma di 2,16 lire piemontesi ciascuno, mentre i pastori provenienti da altri luoghi pagavano con un capretto, considerato di pari valore. Gli agricoltori locali, insieme agli abitanti di Teulada, Villamassargia, Domusnovas e Musei, erano invece tenuti a versare un tributo di sei soldi sardi, equivalenti a circa 9,7 lire piemontesi. Le persone non privilegiate acquistavano il sale a un prezzo più alto, pari a nove soldi sardi, corrispondenti a circa 14,4 lire piemontesi. Le fonti settecentesche non indicano con certezza la collocazione delle saline. Vittorio Angius, nella voce “Iglesias” del Dizionario Casalis, segnala che nel XVIII secolo il sale veniva estratto a Porto-Butis (Porto Botte), dove nell'Ottocento si trovava unaa peschiera, a Porto Pino, in un luogo in cui nel XIX secolo era ancora visibile un edificio prima usato come ricovero per gli operai e da deposito degli strumenti, sul fondo del golfo di Teulada e anche nello stagno dell’istmo. Quest’ultimo sito, in particolare, era noto per la qualità superiore del sale prodotto. La raccolta proseguì fino al 1830, quando si interruppe la produzione estiva e si iniziò semplicemente a impedire o disturbare il processo di cristallizzazione. Da queste saline, il sale veniva distribuito gratuitamente agli abitanti di Iglesias, secondo quanto stabilito dal già citato privilegio aragonese, confermato dai re di Sardegna. Salina di Terranova La salina di Terranova è stata assegnata al marchese Pes di Villamarina con diploma dell'Imperatore Carlo VI del 10 febbraio 1771, come ricompensa per i servigi prestati durante la guerra di successione spagnola. Il diploma è stato confermato dal re di Sardegna Vittorio Amedeo con patenti del 27 maggio 1720 e dal successore Carlo Emanuele III, il 21 marzo 1732. Il 12 luglio 1742 un contratto, confermato con diploma del 5 dicembre, le saline insieme a redditi, amministrazione e tonnara furono eretti in feudo improprio a favore del possessore don Bernardino Pes e suoi discendenti, dietro esborso di 12 mila lire di Piemonte. La patente del 1720 dispone la consegna di 9 cagliaresi per ogni cuba di sale estratto e di mezzo starello (1 emina di Piemonte) per pagare lo stipendio del reggente provinciale. Il sale prodotto nella salina di Terranova viene venduto a Tempio e nel resto della Gallura.
Salina di Terranova La salina di Terranova è stata assegnata al marchese Pes di Villamarina con diploma dell'Imperatore Carlo VI del 10 febbraio 1771, come ricompensa per i servigi prestati durante la guerra di successione spagnola. Il diploma è stato confermato dal re di Sardegna Vittorio Amedeo con patenti del 27 maggio 1720 e dal successore Carlo Emanuele III, il 21 marzo 1732. Il 12 luglio 1742 un contratto, confermato con diploma del 5 dicembre, le saline insieme a redditi, amministrazione e tonnara furono eretti in feudo improprio a favore del possessore don Bernardino Pes e suoi discendenti, dietro esborso di 12 mila lire di Piemonte. La patente del 1720 dispone la consegna di 9 cagliaresi per ogni cuba di sale estratto e di mezzo starello (1 emina di Piemonte) per pagare lo stipendio del reggente provinciale. Il sale prodotto nella salina di Terranova viene venduto a Tempio e nel resto della Gallura. Saline di Sassari Le saline di Sassari nella seconda metà del XVII secolo producevano, al meglio, tra gli 8 ed i 9.000 rasieri, che venivano venduti (e in parte esportati) all'incirca per il 70%. In termini di produzione, di vendita e soprattutto di esportazione la salina sassarese è inferiore di circa la metà rispetto alle saline di Cagliari. Le saline di Sassari vengono concesse al migliore offerente. I profitti generati dal loro sfruttamento crescono significativamente nel corso del Settecento. Almeno dagli anni Trenta del Settecento, queste saline sono soggette all'obbligo di consegnare una certa quantità di sale all'Arcivescovo e ai canonici del Capitolo di Sassari.
Saline di Sassari Le saline di Sassari nella seconda metà del XVII secolo producevano, al meglio, tra gli 8 ed i 9.000 rasieri, che venivano venduti (e in parte esportati) all'incirca per il 70%. In termini di produzione, di vendita e soprattutto di esportazione la salina sassarese è inferiore di circa la metà rispetto alle saline di Cagliari. Le saline di Sassari vengono concesse al migliore offerente. I profitti generati dal loro sfruttamento crescono significativamente nel corso del Settecento. Almeno dagli anni Trenta del Settecento, queste saline sono soggette all'obbligo di consegnare una certa quantità di sale all'Arcivescovo e ai canonici del Capitolo di Sassari. Salina Pompongias Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tantomeno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.
Salina Pompongias Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tantomeno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo. Salina Mistras Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tanto meno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.
Salina Mistras Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tanto meno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo. Salina di Pau Pirastru Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tantomeno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.
Salina di Pau Pirastru Nel Seicento, la produzione delle saline di Oristano poteva arrivare a superare di poco i 2.000 quartini (1 quartino è pari a 1 rasiere e a 2 starelli). L'80% provenienti dalla salina grande (o di Sabocus), il 15% da Pau (o Pauli) Pirastu, il resto da Mistras. Nel 1675 si vendono poco meno di 1.200 quartini 80% Sabocus, Mistras 12%, Pompongias 4,5%, 1% Pau Pirastu). Il prodotto delle saline di Oristano era per un terzo circa costituito da sale nero, che si vendeva a 5 soldi lo starello, se acquistato all'origine, al doppio in dogana; il sale bianco costava due volte tanto. Per quantità, per qualità e per prezzi questo sale non era competitivo con quello di Sassari (che andava a 30 soldi il rasiere), tantomeno con quello di Cagliari (che costava 26 soldi il quartino, fino a 38 se imbarcato da altro porto). Il sale dell'Oristanese veniva comprato in città e nei suoi campidani, nelle incontrade di Parte Usellus, Parte Montis e Monreale, ad est verso Parte Ocier, nel Mandrolisai, Parte Barigadu Jossu e incontrada di Sedilo, a nord verso Bosa e la sua Planargia, nel Marghine, nel Goceano e nel Monteacuto, arrivando fino ad Alghero e, talvolta, ad est fino ad Orgosolo.