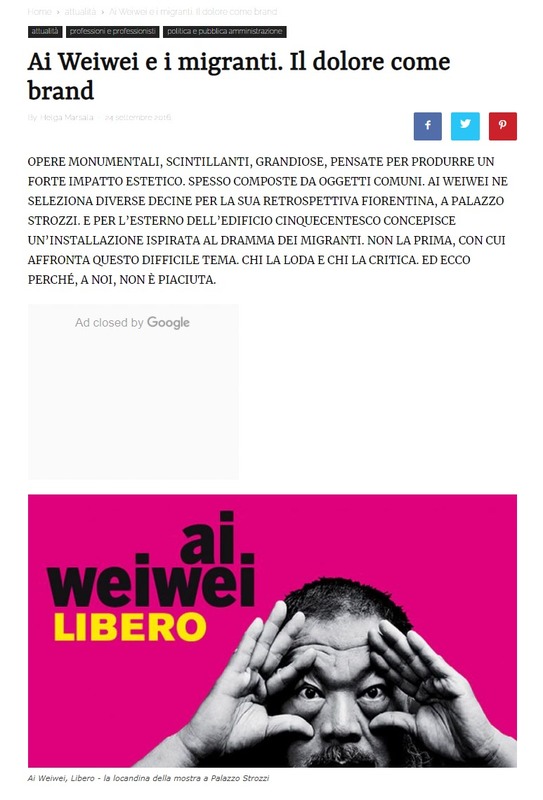-
Titolo
-
Ai Weiwei e i migranti. Il dolore come brand
-
Data di inizio
-
24 settembre 2016
-
Ambiti e contenuto
-
"Opere monumentali, scintillanti, grandiose, pensate per produrre un forte impatto estetico. Spesso composte da oggetti comuni. Ai Weiwei ne seleziona diverse decine per la sua retrospettiva fiorentina, a Palazzo Strozzi. E per l’esterno dell’edificio cinquecentesco concepisce un’installazione ispirata al dramma dei migranti. Non la prima, con cui affronta questo difficile tema. Chi la loda e chi la critica. Ed ecco perché, a noi, non è piaciuta."
-
Autore del documento
-
Helga Marsala
-
Segnatura o codice identificativo
-
URL
-
Lingua
-
Italiano
-
Condizioni che regolano l’accesso
-
Pubblico
-
Citazione bibliografica
-
Helga Marsala, Ai Weiwei e i migranti. Il dolore come brand, «Artribune», 24 settembre 2016, data ultima consultazione: 26/06/2021
-
Formato
-
.html
-
Creatore
-
Giacomo Carmagnini
-
Data di creazione
-
26/06/2021
-
Licenza d'uso
-
Libera
-
riassunto
-
ARTISTA E COMUNICATORE
Libero. È questa la parola chiave scelta da Ai Weiwei (Pechino, 1957) per presentarsi alla platea fiorentina, in occasione del suo attesissimo solo show a Palazzo Strozzi. I manifesti dai colori accesi – accompagnati da uno spot che più pop non si può – campeggiano da agosto tra le vie della città: un close up sul volto dell’artista e una scritta a caratteri cubitali. Ai Weiwei. Libero. Dal punto di vista della comunicazione una scelta “aggressiva”, efficace. Il titolo-slogan dischiude subito un immaginario politically oriented, tra impegno civico e sacrificio personale. Un manifesto biografico e politico che tocca il cuore.
Perché diciamolo: sulla sua esperienza di attivista e dissidente, sgradito al governo cinese, controllato, osteggiato, persino imprigionato (ufficialmente per un problema fiscale) Ai Weiwei ci ha costruito una carriera. La sua fama globale viene anche da lì. Artista non privo di talento e (soprattutto) abilissimo comunicatore, delle sue battaglie in difesa di cause scottanti e in favore della libertà d’espressione ha fatto una specie di brand.
Ai Weiwei ha certamente pagato – con 81 giorni di galera e col fiato delle istituzioni sul collo – il suo impegno per i diritti civili e la sua indipendenza intellettuale. Ma Ai Weiwei oggi è anche un uomo libero (per l’appunto), abbiente, celebrato in tutto il mondo e certo non accostabile a chi, attraverso azioni artistiche radicali, vive il rischio ogni giorno, militando in territori ostili e cercando lo scontro col potere fino alla fine. Tantomeno bisognerebbe farne una specie di martire o leader spirituale: quella di Martin Luther King è un’altra storia.
La retrospettiva fiorentina mette insieme opere di vario genere, selezionate dalla trentennale carriera dell’artistar, spesso con un chiaro carattere di denuncia. Sculture e installazioni, prevalentemente dei ready made, diventano metafore disciplinate per questioni controverse: dal serpentone fatto di zainetti, simili a quelli dei bambini morti durante il devastante terremoto del 2008, nel Sichuan, alle 3.144 biciclette, spogliate di ogni elemento meccanico, per sensibilizzare la gente sui temi dell’inquinamento e del trasporto green.
LA QUESTIONE MIGRANTI. CRITICHE E PLAUSI
Ma l’opera su cui si sono accesi riflettori e polemiche è quella progettata per l’esterno del palazzo cinquecentesco: 22 gommoni arancioni – che riportano al dramma dei migranti nel Mediterraneo – incorniciano le preziose finestre bifore, intagliate lungo le facciate.
L’opera richiama altre due installazioni del 2016, dedicate al tema dei profughi: i 14mila giubbotti di salvataggio, che lo scorso febbraio hanno ricoperto le imponenti colonne della Konzerthaus di Berlino; e poi gli stessi oggetti galleggianti, in forma di 201 ninfee, adagiati nella vasca barocca del parco del Belvedere Superiore, a Vienna.
Tema caldo, che tocca corde delicatissime. Nel mezzo storie di conflitti, massacri, scontri ideologici, strategie amministrative, lutti, naufragi ed eroiche imprese di soccorso. Ed ecco che, dinanzi all’ennesima opera pensata per riportare l’attenzione su un dramma epocale (se mai ce ne fosse bisogno), il dibattito s’infiamma. Sul ring, la fazione dei supporter e quella dei fustigatori.
A schierarsi a favore sono in tanti, tra estimatori dell’autore e professionisti del contemporaneo. Un parere positivo lo ha espresso anche Tomaso Montanari. Due, essenzialmente, le ragioni del suo plauso: la valenza politica del progetto e la sua natura site specific. “Quella di Ai Weiwei “, ha dichiarato lo storico dell’arte, “è un’opera pensata specificamente per Palazzo Strozzi: e trovo interessante, ad esempio, l’analogia tra la forma dei gommoni e quella dell’arco acuto che caratterizza le bifore. Un’analogia che rispetta le linee del palazzo e al contempo la altera con un messaggio fortissimo”.
Non si capisce però quale sia questo messaggio forte, veicolato da una fila di cimeli appesi come mercanzie o souvenir, e cosa ci sia di interessante nella sovrapposizione tra la silhouette delle imbarcazioni e il profilo delle finestre. Un incastro elementare, immediato, che non dischiude alcun senso particolare e che sconfina nella decorazione pura. La felice e auspicata relazione tra forma e contenuto qua pare del tutto dissolta, in favore di un giochino ornamentale.
Severo (ma giusto), invece, Francesco Bonami, che sulle colonne de La Stampa bolla l’artista come “furbo” e definisce le sue installazioni “lavori tirati a lucido, trasformati in oggetti di design, cancellando ogni traccia di quella umanità bistrattata dagli inefficienti politici cinesi della quale Ai Weiwei si fa paladino”. E ancora, rispetto ai canotti sulla facciata: “Potrebbe averli disegnati Philippe Stark. Diversi dai gommoni luridi usati dagli scafisti per trasportare branchi di diseredati in cerca di speranza. Ma l’artista è realista. Anche l’occhio, oltre che la tragedia, vuole la sua parte”
Non manca, poi, la solita spocchia di chi, anziché imbastire critiche circostanziate, si autopromuove a giudice supremo, rilasciando patenti di artisticità a destra e a manca (“E questo sarebbe un artista?!”. Esatto, lo è. A stabilirlo molti critici internazionali, il mercato globale e un po’ di musei che contano. Sulla forza del suo lavoro, poi, dobbiamo e possiamo discutere). Diffuso, infine, lo scetticismo nei confronti di una nuova presenza “contemporanea” nel contesto rinascimentale fiorentino. Contestazione incredibilmente inutile, polverosa, bacchettona. Il punto non è tradire un’architettura storica, nel cuore di una città consacrata alla memoria e alla conservazione. La “profanazione” del monumento e della classicità aulica è sempre possibile, là dove esistano logica, rispetto, criterio.
IMPEGNO SOCIALE O DECORAZIONE?
Il punto, semmai, è tradire la tragedia, tramutarla in raccontino, ridurla a un sfilza di segni composti, lucidi, ordinati, esibiti. Per dire cosa? Per accendere quale luce, quale spia? I gommoni di Firenze, messi in fila con diligenza, diventano un diversivo ottico, un diletto giocato tra la piacevolezza estetica e l’enormità del tema, tra il pop della plastica turgida e la densità porosa del bugnato, secondo registri più che codificati. Tutto odora di cliché, di formuletta facile. Giocattoli oversize, a misura di un art system senza rischio né stupore.
Quest’opera di Ai Weiwei non conosce la grazia, la commozione, la ferocia, l’empatia. Ma nemmeno la brutalità di un pensiero laterale, che inchiodi a una qualche verità scomoda. Macabri relitti del dolore vengono spostati dall’inferno della fuga, ripuliti, messi in scena e offerti allo sguardo dei passanti, in quanto prova inconfutabile della tragedia (anche qui: ce n’era bisogno?). Tutto sta in questo detournement, che però non innesca il cortocircuito. Anzi, l’effetto è quello del pretesto furbo, del tema acchiappa-click, per dirla con il linguaggio della rete. Il ritornello colorato degli objet trouvé campeggia in superficie e stride con lo status – brutale – della realtà.
Il rapporto col reale: qui è il nodo. Da una parte c’è la cronaca, che a volte magnetizza l’arte e la trasforma in rituale, in esperienza simbolica o relazionale, o ancora in militanza pura, in progetto umanitario, in processo di trasformazione sociale: da Tania Brugera a Santiago Sierra, da Fabio Mauri a Jochen Gerz, da Regina José Galindo ai Voina, da Artur Zmijewski agli Yes Men, giusto per fare qualche nome.
All’opposto c’è un’arte che proietta se stessa sulla cronaca e che la piega a sé. Arte che illustra, estetizza, espone feticci e spettacolarizza. Le ultime opere di Ai Weiwei, in parte, sembrano rientrare in questo perimetro. E se lungo le colonne berlinesi la pratica dell’accumulazione risolveva meglio la faccenda, grazie all’effetto di un’entropia monumentale, a Firenze ha vinto la tentazione del ricamo, della gradevolezza leziosa. La potenza dell’architettura rinascimentale ha forse condizionato il progetto, finendo con l’indebolirlo.
Eppure, nemmeno il lavoro di Berlino, o quello realizzato a Vienna, convincono davvero. Tantomeno l’autoritratto a pancia in giù sulla battigia, nei panni di Aylan Kurdi, il piccolo profugo siriano annegato. Scatto di dubbio gusto, perché semplicemente inutile, retorico, egoico. L’ombra del gesto speculativo, mediatico, unicamente scenografico, compromette in tutti questi casi l’intenzione sincera. Senza considerare l’aspetto commerciale: fare mercato, a partire dai resti di una tragedia, lascia sempre un po’ interdetti. Quanto vale un gommone della morte, dopo il tocco concettuale di Ai Weiwei?
QUANDO L’ARTE È POLITICA?
A gettare uno sguardo sulle tante produzioni artistiche recenti, ispirate a esodi, guerre, migrazioni, la domanda a un certo punto viene. Abbiamo davvero bisogno di un’arte che ci metta sotto al naso la brutalità del mondo, collezionando feticci residuali e apparecchiandoli in una forma gradevole, compiuta, lineare? Abbiamo davvero bisogno che la morte si faccia mainstream, che il dolore si traduca in una scrittura politicamente corretta, edulcorata, borghese, e che la cronaca – la più crudele – trovi un ennesimo palco artefatto, per milioni di sguardi distratti? Da un lato la tv e specialmente il web, dispensatori frequenti di melassa, qualunquismo, violenza. Dall’altro l’arte, che insegue una possibilità di slittamento poetico/simbolico, oltre la pornografia del male.
Ma è sempre efficace il risultato? Chiaramente no. Ed è comunque politica l’impronta dell’opera stessa? In qualche modo sì. O meglio, lo diventa se è all’altezza del conflitto, se muove qualcosa sul piano del pensiero, del sentimento personale, della coscienza collettiva, delle immagini condivise e degli immaginari in emersione. A prescindere dal tema, dal linguaggio, dal soggetto, l’opera d’arte – che sia una tela astratta o una performance relazionale – è sempre politica se opera spostamenti; se inaugura rapporti con il “fuori” e con l’“universale”; se rivela, con dei dispositivi propri, un destino possibile per le immagini, oltre la dittatura del simulacro e del luogo comune: farsi, disfarsi e rifarsi, provando a disfare e rifare l’ordine dato. Lungo i sentieri di una logosfera, tra estetica e politica.
Viceversa, in qualche caso, ha più ragione il silenzio. Nel surplus di visioni spietate, prodotte e liberate in rete, nell’overdose d’informazione, nel rumore bianco che avvolge i fatti e ne sciupa i contorni, il tempo della tregua a volte è più incisivo. Tempo della sospensione, del lutto. Quantomeno se, per la foga di dire, di rappresentare, di produrre forme accattivanti e valori monetari, si casca nella trappola conformista. Attivismo sociale di maniera e nuovo rumore. Lo strappo, fosse pure racchiuso in un sussurro, si consuma sempre altrove.
-
trascritto da
-
Giacomo Carmagnini