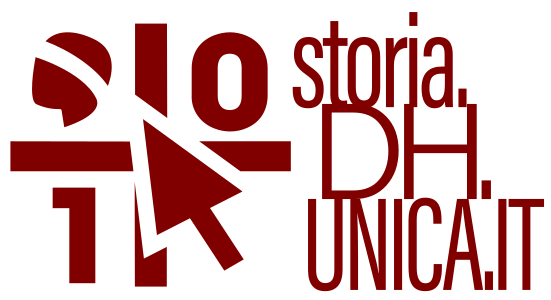-
Denominazione
-
it
Torre di Porto Paglia
-
Data
-
1577
-
Descrizione
-
La torre di Porto Paglia sorge sul litorale del golfo del Leone, arroccata su uno scoglio a circa 40 metri dalla battigia, raggiungibile dal sentiero collinare che dalla statale conduce al villaggio di Porto Paglia o dalla strada che da Iglesias porta alla spiaggia di Fontanamare.
Il nome, attestato già nel XVI secolo, ricorda l'invasione delle alghe posidonie, soprattutto in occasione delle mareggiate, che depositate sul litorale formano banchi simili a mucchi di fieno.
Essa rappresenta un esempio costruttivo anomalo se inserito all’interno dello schema tipologico delle torri costiere sarde.
Non si tratta di una vera e propria torre, bensì di una batteria "rasante" o batteria "a fior d'acqua". Dal punto di vista costruttivo si compone infatti di due parti principali: un basamento, definito planimetricamente da una poligonale costituita da tratti rettilinei e curvi, studiata per resistere agli urti, e munito di rostro per infrangere le onde, mentre la torre vera e propria è costituita da un corpo cilindrico cavo di 11,60 metri di diametro, la cui altezza si attesta intorno ai 7 metri, con il prospetto rivolto verso l'entroterra non circolare ma concavo.
-
ANALISI STORICA
Le prime attestazioni della presenza di una torre nei pressi di Porto Paglia risalgono alla seconda metà del XVI secolo, quando Filippo II, re di Spagna, invia nell’isola una serie di funzionari incaricati di redigere un quadro esaustivo delle condizioni del sistema difensivo sardo, per comprendere lo stato di conservazione delle strutture esistenti e se, qualora necessario, intervenire per edificarne di nuove.
Tra questi ufficiali si ricorda Don Marco Antonio Camos, capitano di Iglesias che, su ordine del vicerè e luogotenente generale di Sardegna, Don Giovanni Coloma, nel 1572 percorre il periplo dell’isola di Sardegna al fine di individuare i siti ottimali, dal punto di vista strategico, per la costruzione di nuove torri di difesa costiera.
Questa strategia di rafforzamento dell’assetto difensivo si rende indispensabile dal momento che le opere di fortificazione delle città non sono sufficienti da sole a garantire la difesa in occasione di attacchi dal mare e che i piccoli centri, non dotati di mura, hanno scarsa capacità difensiva.
La relazione del Camos del 1572 sottolinea l’importanza di questo tratto della costa sulcitana e i motivi per cui deve essere maggiormente presidiato: «la feracità dei campi e la loro potenzialità di produzione granaria e l’attività mineraria argentifera, significativa fonte di introito della corona».
Oltre a queste si aggiunge l’attività della pesca che riveste un ruolo di primaria e vitale importanza per l’economia iglesiente, in particolare a partire dal 1602, anno in cui l’imprenditore cagliaritano Pietro Porta impianta la tonnara in Porto Paglia.
Per poter esercitare la pesca del tonno è assolutamente necessario che venga garantito un servizio di sorveglianza, come viene sottolineato in quegli stessi anni dal Fara: «Merita menzione anche la mattanza dei tonni e dei pesci spada. In particolare nello stretto del Sulcis ove la pesca fornirebbe risorse pressoché illimitate se l’attività non risultasse insicura per la presenza dei pirati».
Così come accade a Portoscuso, il villaggio e la tonnara devono essere protette dai possibili attacchi dei corsari barbareschi, motivo per il quale vengono erette delle torri la cui costruzione risponde alle esigenze del sistema di difesa statico: lo scopo è quello di limitare, in prima istanza, l’attacco nemico e, allo stesso tempo, avvisare i centri limitrofi e le popolazioni delle ville vicine dell’imminente pericolo attraverso l’attivazione di una catena di trasmissione ininterrotta dell’allarme.
La torre Porto Paglia, già operativa nel 1598, viene costruita nel promontorio detto Sa Turri, in una posizione atta a garantire il dominio e il controllo della tonnara; la presenza di un sistema di avvistamento risulta però già presente vent’anni prima, come riporta la carta corografica stilata da Rocco Capellino nel 1577, realizzata dopo vent’anni di rilevamenti in loco, nella quale l’ingegnere militare individua una serie di torri lungo le coste sarde, tra cui quella di Porto Paglia.
La carta rappresenta perciò un termine ante quem per la datazione della torre. Quest’ultima risulta ancora presente nel XVII e XVIII secolo, come attesta la carta della Descripcion dela Isla y Reyno de Sardeña del 1639, in cui la torre viene indicata come Torre de Porto Palla.
Nella Nova et accurata totius Sardinié Tabula del 1720 è riportata la località di Porto Paglia, ma non la torre. A questa data risale infatti anche la Relazione sullo stato delle torri in cui si cita la torre di Porto Paglia in rapporto alle gravi condizioni in cui essa versa: «Questa appartiene a Sua Maestà e richiede una spesa raggionevole alle sue riparationi la quale oltre non esser di servitio nella situazione in cui si trova non puotendo scuoprire nissuna parte et è anche soggetta ad esser valancata, per il che havendo attentamente esaminato ogni cosa s'è giudicato meglio di erigerla: Sopra le ruppi di fontana mare la quale scoprirebbe tutte le coste e custodirebbe meglio il suo porto riccevendo li signali da quella dell’Isola Piana, come pure di quella di comes 4 miglia entro terra».
La torre è indicata nuovamente nella Carta della Sardegna con l’Annotazione delle cose più rimarcabili divisione dei Capi degli Arcivescovadi e dei Vescovadi dei Marchesati Contee Baronie et Incontrade, a riprova del fatto che essa può aver subito in precedenza o un consolidamento atto al recupero della struttura preesistente o la demolizione completa e la nuova costruzione della stessa. Sicuramente la torre è stata ricostruita dopo il 1773, anno in cui l’ingegnere Daristo è incaricato di redigere il progetto della nuova torre, come attesta il calcolo della spesa per la costruzione della torre, il quale riporta i materiali, le lavorazioni e altre voci in merito alle scelte progettuali adottate; il progetto definitivo tuttavia viene firmato nel 1780 del dall'ingegner Marciot «per una spesa di oltre 6625 lire sarde». La guarnigione si insedia nel 1789 ma vi rimane solo fino al 1798 poiché la batteria non può ospitare i cannoni, causandone così l’abbandono e il conseguente spostamento dell’artiglieria all’interno del palazzotto della tonnara.
Nel 1819 la torre risulta "di niun servizio per essere diroccata", causa anche la posizione scelta per la sua edificazione come riporta il capitano nautico William Henry Smyth nella sua relazione di viaggio durante la sua visita in Sardegna: «Tra Punta Rama e Capo Altano vi è Porto Paglia, una grande baia abbastanza esposta alle burrasche provenienti da ovest: vicino al suo centro sfocia il Fontan’a Mare, un ruscelletto che fluisce dai recessi boscosi del Monte San Giovanni. All’estremità sud-est della baia, su una piccola altura, vi è una tonnara con un villaggio di pescatori, difeso da una torre rotonda, assurdamente collocata in basso».
-
LA TORRE OGGI
Attualmente la torre di Porto Paglia si trova allo stato di rudere, dovuto come detto in precedenza non solo alle cause naturali di una progressiva azione erosiva del mare derivanti dal vistoso fenomeno di arretramento della linea di costa, ma anche all’incuria e all’abbandono dell’edificio dopo la sua dismissione, prima ancora della soppressione con Regio Editto del 17 settembre 1842 della Reale Amministrazione delle Torri. La torre infatti risulta profondamente mutata ed alterata dopo i vistosi crolli per cui la ricostruzione dell’assetto originario (Fig.10) si basa su un’interpretazione e analisi delle fonti bibliografiche e archivistiche, e su un’attenta lettura dal vivo della fabbrica.
Fig. 10. Rilievo della torre di Porto Paglia.
La torre e la tonnara di Porto Paglia rappresentano un patrimonio inestimabile e di estremo valore dal punto di vista storico, architettonico e culturale in quanto sono la testimonianza di un particolare modo di sentire e il riflesso di una comunità che attraverso l’attività produttiva della pesca del tonno ha definito e costruito questo paesaggio costiero. Il desiderio è che queste architetture non rimangano resti muti di un passato che lentamente e inesorabilmente rischia di essere dimenticato dalla collettività ma siano parte attiva dei processi quotidiani della vita delle comunità. In questo senso è importante individuare una rete di relazioni entro la quale poter collocare il sito affinchè acquisisca un nuovo senso, individuando nuovi collegamenti, materiali e immateriali, con ciò che lo circonda.
-
Comune attuale
-
it
Gonnesa
-
Latitudine
-
it
39.2606501508469
-
Longitudine
-
it
8.414830421684021
-
Citazione bibliografica
-
E. Altara, Guida alle torri costiere della Sardegna. Mille anni di incursioni barbaresche, Cortona, 2007;
A. Cámara, “Las fortificaciones y la defensa del Mediterráneo”, in Felipe II y el Mediterráneo. La monarquía y los reinos. Convegno Internazionale, Barcellona, IV, a cura di Ernest Belenguer Cebrià, Madrid 1999.
G. Cossu, Descrizione geografica della Sardegna, a cura di Isabella Zedda Macciò, Illisso, Nuoro 2000.
A. della Marmora, Itinerario dell’isola di Sardegna, a cura di Manlio Brigaglia, Editrice Archivio Fotografico Sardo – Nuoro, Sassari 2001.
F. Farae, In sardiniae Corografiam, a cura di Enzo Cadoni, Edizioni Gallizzi, Sassari 1992.
F. Fois, Torri spagnole e forti piemontesi in Sardegna, La Voce Sarda Editrice, Cagliari 1981.
C. Giannattasio, S.Grillo, S. Murru, Il sistema di torri costiere della Sardegna: forma, materiali, tecniche murarie, «L’Erma di Bretschneider» Roma 2017.
F. Mameli, Relazione di un viaggio in Sardegna compiuto nel 1829, Tipografia Edit. Iglesiente, 1901.
G. Montaldo, Le torri costiere della Sardegna. Carlo Delfino. Sassari 1992.
S. Murru, Le torri costiere della Sardegna nel Mediterraneo: cronologie delle strutture murarie, tesi di dottorato di ricerca UNICA, A.A. 2014-2015.
G. G. Ortu a cura di, Acta Curiarum Regni Sardiniae 14. Il Parlamento del viceré Carlo de Boria duca di Gandía (1614), Consiglio Regionale della Sardegna, EDI.CO.S., Cagliari 1995.
L. Piloni, Carte geografiche della Sardegna, Della Torre, Cagliari 1997.
E. Pillosu, Un inedito rapporto cinquecentesco sulla difesa costiera della Sardegna di Marco Antonio Camos, Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo, IV n. 21, 22, 23 e 24, 1959; V. n. 25, Cagliari 1961.
M. Rassu, Guida alle torri e ai forti costieri, Artigianarte, Cagliari 2000.
M. Rassu, Sentinelle del mare. Le torri della difesa costiera della Sardegna. Grafiche del Parteolla. Dolianova 2005.
F. Russo, La difesa costiera del Regno di Sardegna dal XVI al XIX secolo, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Esercito, Roma 1992.
W. H. Smyth, Relazione sull’isola di Sardegna, a cura di Manlio Brigaglia, Illisso, Nuoro 1998.
-
D. Vacca, Restauro delle torri della Sardegna costa Sud-Orientale danneggiate dal terremoto del 1616, pubblicazione on-line
-
Autore della scheda
-
it
Eleonora Giglio (Scuola di Specializzazione Beni Architettonici e del Paesaggio)
-
Data di creazione della scheda
-
it
02/04/2023
 Tonnara di Porto Paglia
Tonnara di Porto Paglia
 Torre di Porto Paglia
Torre di Porto Paglia