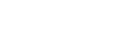Nel corso del XII secolo, il Mediterraneo vide una trasformazione radicale nei traffici marittimi e nei rapporti di potere, e la Sardegna divenne un nodo strategico conteso tra le grandi potenze marinare, specialmente Genova e Pisa. Questo si rifletté in modo evidente nello sviluppo delle saline, che tornarono a essere centri vitali di produzione e ricchezza.
Il sale, bene prezioso e strategico, attirò l'interesse non solo dei mercanti italiani, ma anche di quelli provenzali. I mercanti marsigliesi, in particolare, aspiravano al controllo del commercio salifero, da cui traevano profitti enormi. L’antagonismo tra i monaci di Marsiglia e gli arcivescovi di Cagliari potrebbe essere letto proprio come un riflesso della rivalità economica tra Pisa e Marsiglia per assicurarsi il monopolio dell’oro bianco isolano.
A spuntarla furono infine i Pisani, che, dopo aver espugnato il castello di Cagliari e ottenuto la vittoria a Santa Gilla, entrarono in possesso non solo del distretto urbano, ma anche delle saline e dei villaggi ad esse collegati. Furono così in grado di controllare anche Portu Salis — uno scalo localizzato tra la chiesetta di San Bardilio e il canale delle saline — dove, sin dall’XI secolo, si caricava il sale destinato alle città marinare, Pisa e Genova in primis.
Numerosi documenti testimoniano il fervore del traffico salifero: già nel 1104 i Pisani ottennero il diritto di esportare liberamente sale da Cagliari, ma è probabile che tale privilegio fosse solo una conferma di concessioni preesistenti. L’importanza commerciale del sale era tale che l’attuale Via Sardegna, a Cagliai, nel periodo pisano, era conosciuta come Via del Sale. Il fervore per il sale è testimoniato anche dalla toponomastica: sono decine i luoghi il cui nome è legato al sale e persino intere comunità come Salarius (odierna Selargius).
Mentre Pisa deteneva saline in tutta l’isola — da Cagliari alla Gallura, da Terranova a Posada (protetta dal Castello della Fava) — Genova continuava ad approvvigionarsi principalmente dalle saline di Terralba e Torres. Anche navi provenienti da Napoli, Gaeta e Capua facevano rotta su portu de Bagneriis per caricare sale, a riprova di una rete commerciale ampia e duratura.
Non solo le potenze marinare, ma anche i monasteri contribuirono allo sfruttamento delle risorse salifere. Nel Sassarese, molti stagni vennero convertiti in saline dai monaci giunti sull’isola nel XII secolo: comunità come quelle di San Michele di Salvenor, della Santissima Trinità di Saccargia e di Santa Maria di Tergu possedevano più impianti ciascuna.
Nel cuore del Medioevo, la Sardegna fu un centro nevralgico per i traffici marittimi e il commercio del sale. Le sue saline non solo alimentarono l’economia di Pisa e Genova, ma scrissero una pagina importante della storia del Mediterraneo.