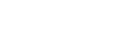A cura di Beatrice Schivo
La schiavitù mediterranea fu un fenomeno reciproco. Per tutta l'età moderna i cristiani erano fatti schiavi nei paesi del Maghreb dai corsari barbareschi, tanto quanto i musulmani venivano catturati e incatenati dagli europei, corsari a loro volta.
Il Regno di Sardegna era particolarmente esposto alle incursioni e alle razzie e ne soffrì le pesanti conseguenze militari, economiche, sociali e soprattutto umane. Gli attacchi erano indiscriminati e avevano il solo obiettivo di fare bottino, depredare i villaggi e catturare le popolazioni. Le razzie andarono avanti soprattutto nel Cinquecento e nella prima metà del Seicento, diminuendo fino a scomparire nei secoli successivi.
Le popolazioni rivierasche vivevano nella continua apprensione per via della pressione della guerra di corsa nemica. Le incursioni avvenivano soprattutto quando le popolazioni eranosenza protezione o mal difese nei loro villaggi, o isolate nelle campagne o sul mare. I comportamenti quotidiani, individuali e sociali, ma anche viaggi sul mare ne risentirono fortemente. Anche la vita religiosa e sociale era, non di rado, bersaglio di attacchi. Per questo i fedeli venivano accompagnati nelle processioni e nelle feste da scorte militari di difesa.
Anche le autorità erano costantemente in apprensione, e i provvedimenti contro il "pericolo turco" si susseguirono frequentemente specialmente nei primi decenni del XVII secolo.
Gli schiavi sardi erano presenti in buon numero nei bagni delle reggenze barbaresche, le cui città basanvao la loro economia in buona parte sul riscatto degli schiavi cristiani.
Bibliografia
Giuliana Boccadamo, Napoli e l’Islam. Storie di musulmani, schiavi e rinnegati in Età Moderna, D’Auria, Napoli 2010;
Gennaro Varriale, Redimere anime: la Santa Casa della Redenzione dei cattivi a Napoli, 1548–1599, «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 18, n.1 (2015), pp. 233–259;
Rossella Cancila, Corsa e pirateria nella Sicilia della prima età moderna, «Quaderni storici»/2 (2001), pp. 363–378;
Enrica Lucchini, La merce umana. Schiavitù e riscatto dei liguri nel Seicento, Bonacci, Roma 1990;
Luca Lo Basso, Il prezzo della libertà: l’analisi dei libri contabili del Magistrato per il riscatto degli schiavi della Repubblica di Genova all’inizio del XVIII secolo, École française de Rome, Roma 2008;
Marco Lenci, Le confraternite del riscatto nella Toscana di età moderna: il caso di Firenze, «Archivio storico italiano», 167, n.2 (2009), pp. 269–298;
Andrea Pelizza, «Restituirsi in libertà alla patria». Riscatti di schiavi a Venezia tra XVI e XVIII secolo, «Quaderni storici», 47, n.140 (2) (2012), pp. 341–38