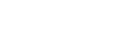«Feroci e inumani corsari barbareschi rapirono quanto poterono;
devastarono, ruppero, profanarono o villipesero quanto dovevano lasciare.
Guastarono […] tutte le barche sparse
in quei litorali.
Ottocentotrenta popolani erano al tempo stesso raccolti;
e seminudi e martoriati in ogni maniera,
cacciavansi […] a caricare la sentina delle navi tunisane»G. Manno

Un aspetto della schiavitù che ha attirato particolare attenzione da parte degli storici è il riscatto, cioè i percorsi attraverso i quali i cristiani ridotti in schiavitù potevano tornare in libertà a seguito del versamento di una somma di denaro. Tale meccanismo diede vita, per quasi tutta l'età moderna, a una vera e propria "economia del riscatto", che ebbe il suo centro nel Mediterraneo.
In questo scenario in particolare due religiosi di origine medievale ebbero un ruolo chiave. Parliamo dell'Ordine della Santissima Trinità, i cui membri erano detti trinitari, e dell'Ordine di Santa Maria della Mercede (mercedari). Nel contesto del Regno di Sardegna, spesso i due ordini collaboravano, liberando un gran numero di schiavi cristiani.
Significativo fu anche il numero delle perdite: numerosi religiosi vennero uccisi mentre portavano avanti la missione.In ambito sardo la parabola dell’Ordine di Santa Maria della Mercede è stata studiata da Antonio Rubino col supporto di un ampio scavo archivistico.
Ai due ordini religiosi Trinitario e Mercedario si affiancano nel corso del XVI secolo organizzazioni locali dedite allo stesso scopo. Tra i tanti ricordiamo: la romana Opera Pia del Riscatto, la Real Casa della Redenzione de’ Captivi di Napoli, l’Arciconfraternita per la Redenzione de’ Captivi di Palermo, il Magistrato del Riscatto di Genova.
Anche l’Arciconfraternita del Gonfalone di Roma era impegnata nella redenzione dei captivi. Alla fine del Cinquecento organizzò due missioni di riscatto ad Algeri, dove si trovavano numerosi schiavi sardi. A scrivere in merito alla vicenda è lo storico dell’economia Ciro Manca nel 1975. Attraverso le carte dell’Arciconfraternita conservate nell’Archivio Apostolico Vaticano, Manca racconta della partecipazione di un vescovo sardo alle due missioni. Giovanni Sanna di Ales era dottore in utroque iure, prima decano di Ales e poi vescovo di Ampurias, grande conoscitore delle lingue. Ottenne l’autorizzazione a recarsi ad Algeri e in altre località nordafricane e condurre trattative. Nel 1585 riuscì a riscattare 74 schiavi di cui 4 sardi.
Un evento in particolare è stato oggetto di attenzione da parte degli storici che si sono occupati di schiavitù in Sardegna: l’attacco sferrato dai corsari tunisini nel 1798 a Carloforte. La cittadina di Carloforte si trova nell’Isola di San Pietro, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Venne fondata negli anni Trenta del Settecento a seguito del programma di colonizzazione co-finanziato dal re Carlo Emanuele III per il trasferimento nell’isola di abitanti dell’isolotto tunisino di Tabarka. All’alba del 2 settembre 1798, un gruppo di corsari tunisini sbarcò a Carloforte e iniziò un violento saccheggio, portando via 830 abitanti. Immediatamente si avviarono le procedure per il riscatto, rivelatesi tutt’altro che semplici. Solo nel 1803 gli schiavi vennero liberati.

Bibliografia
Salvatore Bono, L'incursione tunisina a Carloforte (2 settembre 1798), in Carloforte tra Settecento e Ottocento: cinque anni di schiavitù per i carolini, dalla cattura alla liberazione (1798-1803), Agorà, 31, 2006;
Ernesto Pontieri, Problemi sardi al principio del secolo XIX: riscatto degli schiavi carolini nel 1803, in Studi Sardi (1), 1,1934
Amerigo Imeroni, I re di Sardegna pel riscatto degli schiavi dai barbareschi, La libreria dello Stato, Roma, 1935
Joseph Kleyntjens, L’azione della Santa Sede per il riscatto di schiavi sardi catturati dai Barbareschi, in Archivio Storico Italiano (95), 3, 1937
Tito Orrù, Postumi risvolti della politica finanziaria del governo sabaudo in “esilio”: il “credito Pollini” per il riscatto degli schiavi carolini, Giuffrè, Milano, 1971
Giuseppe Vallebona, Carloforte. Storia di una colonizzazione, Edizioni della Torre, Cagliari, 1988
Antonio Rubino, I mercedari in Sardegna (1335-2000), Istituto storico dell'ordine della Mercede, Roma, 2000
Ciro Manca, Un decano d’Ales redentore di schiavi cristiani in berberia sul finire del Cinquecento, in La Diocesi di Ales-Usellus-Terralba: aspetti e valori, Fossataro, Cagliari, 1975
Maria Bonaria Lai, Dalla luce al buio. I Trinitari: un Ordine religioso presente in Sardegna nei secoli passati ed oggi sconosciuto ai più, in Almanacco di Cagliari, 2014